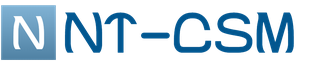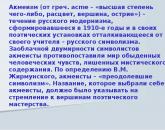La comunicazione pedagogica e le sue caratteristiche psicologiche. Caratteristiche generali della comunicazione pedagogica
Invia il tuo buon lavoro nella base di conoscenza è semplice. Utilizza il modulo sottostante
Studenti, dottorandi, giovani scienziati che utilizzano la base di conoscenza nei loro studi e nel loro lavoro ti saranno molto grati.
caratteristiche generali comunicazione
1. La comunicazione come forma di interazione
La comunicazione, il processo di comunicazione, è un concetto ampio e capiente. Questa è comunicazione conscia e inconscia, verbale e non verbale, trasmissione e ricezione di informazioni, che si osserva ovunque e sempre. La comunicazione ha molte facce: ha molte forme e tipologie. La comunicazione pedagogica è un particolare tipo di comunicazione tra persone. Ha sia caratteristiche generali di questa forma di interazione, sia specifiche per processo educativo.
Consideriamo le caratteristiche generali della comunicazione per caratterizzare ulteriormente la comunicazione pedagogica tra l'insegnante e gli studenti da queste posizioni. AA. Leontiev individua le seguenti caratteristiche: contatto, orientamento, orientamento, dinamica psicologica del processo. Nell'ultima edizione, sono definiti come specializzazione e grado di mediazione, orientamento della comunicazione e dinamiche psicologiche. Il contenuto della specializzazione della comunicazione sottolinea l'importanza di combinare tutti i mezzi - verbali e non verbali per aumentare l'efficacia dell'impatto del discorso, il contatto è considerato dal grado di convergenza nel tempo e nello spazio della comunicazione parlata e della sua percezione.
Una caratteristica importante della comunicazione è la sua dinamica psicologica, determinata dalle caratteristiche dell'impatto delle informazioni verbali.
Aggiungiamo altre due caratteristiche della comunicazione: rappresentatività poliinformativa. La prima è la rappresentazione soggettiva del parlante nel testo, la seconda è la diversità della comunicazione vocale, dove si realizzano simultaneamente tutte le sue caratteristiche (contenuto, espressività, impatto), si riflettono diversi livelli (soggetto, semantica, ecc.).
La comunicazione rappresentativa presuppone che qualsiasi comunicazione rifletta le caratteristiche individuali e personali dei comunicanti, il loro livello culturale, età, genere, interessi, ecc. Di particolare importanza è l'analisi della comunicazione verbale-testo, che consente di rivelare quelle relazioni sociali e sociali in cui sono incluse le persone che realizzano questa comunicazione, le loro caratteristiche personali.
Una caratteristica altrettanto importante della comunicazione verbale è la poliinformativa. Sta nel fatto che il messaggio vocale trasmesso nel processo di comunicazione verbale ha un contenuto comunicativo e soggettivo complesso, che è un'unità del contenuto effettivo, dei piani espressivi e di incentivazione dell'enunciato.
Riassumendo quanto sopra: la comunicazione vocale (verbale) è descritta da almeno sette caratteristiche: contatto, orientamento, orientamento, specializzazione semiotica, dinamica, rappresentatività, poliinformativa.
Definendo la comunicazione come "l'interazione delle persone, il cui contenuto è la conoscenza reciproca e lo scambio di informazioni attraverso varie relazioni favorevoli al processo di attività congiunta", V.N. Panorev ha individuato quattro punti nella comunicazione: comunicazione, interazione, cognizione, relazione, rispettivamente, e quattro approcci allo studio della comunicazione: comunicativo, informativo, cognitivo e normativo.
B.F. Lomov ha descritto tre lati (funzioni) della comunicazione: informazione e comunicazione; normativo e comunicativo; affettivo-comunicativo, sottolineando l'obbligo della componente comunicativa vera e propria come la ricezione e la trasmissione di messaggi, la regolazione del comportamento e la presenza di un atteggiamento, esperienza, i.e. componente affettiva.
M. ha definito le funzioni del linguaggio in modo leggermente diverso, individuando 7 funzioni del comportamento del linguaggio: strumentale (soddisfazione dei bisogni materiali); normativo (controllo del comportamento degli altri); interazioni (mantenimento del contatto); personale (auto-presentazione); ricerca euristica (perché); immaginario (mondo interiore); informativo (messaggio di nuove informazioni). Il contenuto multilinea e lo scopo delle funzioni vocali sono evidenti. È importante che tutti siano ampiamente utilizzati nell'interpretazione della comunicazione pedagogica, riflettendo gli aspetti dell'interazione comunicativa.
La comunicazione pedagogica è comunicazione professionale un insegnante con studenti in classe e al di fuori di essa (nel processo di formazione e istruzione) con determinate funzioni pedagogiche dirette (se è piena e ottimale) a creare un clima psicologico favorevole, nonché a un altro tipo di ottimizzazione psicologica attività didattiche e le relazioni tra l'insegnante e gli studenti all'interno del gruppo studentesco.
La comunicazione pedagogica è rivolta non solo all'interazione stessa e agli studenti ai fini del loro sviluppo personale, ma anche a ciò che è fondamentale per il sistema pedagogico stesso: organizzare lo sviluppo delle conoscenze educative e la formazione delle competenze su questa base.
La comunicazione pedagogica è una forma di interazione educativa, cooperazione tra insegnante e studenti. Questa è un'interazione personale e socialmente orientata. La comunicazione pedagogica implementa contemporaneamente funzioni comunicative, percettive e interattive, utilizzando l'intero insieme di mezzi verbali, pittorici, simbolici e.
Funzionalmente, è un'interazione di contatto, informativa, incentivante, di coordinamento che stabilisce la relazione di tutti i soggetti del processo educativo. È caratterizzato da un orientamento all'oggetto completo, semi-informatività e un alto grado di rappresentatività.
Aggiungiamo che la comunicazione pedagogica come forma di cooperazione educativa è una condizione per ottimizzare l'apprendimento e sviluppare la personalità degli studenti stessi. È determinato da un triplice orientamento: personale, sociale, soggetto. L'insegnante, lavorando con uno studente sullo sviluppo di qualsiasi materiale didattico, orienta sempre il suo risultato a tutti i presenti in classe, e viceversa, lavorando con la classe, ad es. frontalmente, colpisce ogni insegnante. Pertanto, possiamo presumere che l'originalità della comunicazione pedagogica, essendo la totalità di queste caratteristiche, si esprima in una combinazione organica di elementi di comunicazione orientata alla personalità, orientata al sociale e orientata al soggetto. Allo stesso tempo, la comunicazione pedagogica, inclusi tutti gli elementi di cui sopra, ha una qualità fondamentalmente nuova.
2. Le specificità della comunicazione pedagogica
La seconda qualità della comunicazione pedagogica è determinata, anzitutto, dalla sua funzione didattica, che include la funzione educativa, perché il processo educativo ha un carattere educativo e di sviluppo. La funzione di apprendimento della comunicazione può essere correlata con quella traduttiva. La funzione didattica della comunicazione pedagogica è quella principale: parte dell'interazione multilaterale dell'insegnante - studenti, studenti tra di loro. Allo stesso tempo, la comunicazione pedagogica riflette le specificità della natura dell'interazione umana.
“... In effetti, indipendentemente dalla materia insegnata dall'insegnante, trasmette allo studente, prima di tutto, convinzioni nel potere della mente umana, un potente desiderio di conoscenza, amore per la verità e un atteggiamento verso l'altruismo socialmente utile lavoro, ... Quando l'insegnante riesce allo stesso tempo a dimostrare agli studenti un'alta e raffinata cultura delle relazioni interpersonali, giustizia unita a tatto impeccabile, entusiasmo unito a nobile modestia - allora, imitando involontariamente un tale insegnante, il più giovane la generazione è formata spiritualmente armoniosa, capace di risolvere umanamente i conflitti interpersonali così comuni nella vita.
Non meno significativa funzione di comunicazione (K.). Ciò significa che l'insegnante aiuta lo studente ad esprimere se stesso, il positivo che è in lui. La necessità dell'interesse dell'insegnante per il successo dello studente, che facilita l'interazione pedagogica, contribuisce all'autorealizzazione dello studente e al suo ulteriore sviluppo.
Le funzioni didattiche ed educative costituiscono così l'unità della comunicazione pedagogica.
3. Il concetto di tecnologia della comunicazione pedagogica
La produttività dell'attività pedagogica è in gran parte determinata dal livello di padronanza della tecnologia della comunicazione pedagogica da parte dell'insegnante.
VA Kann-Kalik ha notato che l'educazione sarà efficace se evoca atteggiamenti positivi nel bambino nei confronti di ciò che vogliamo educarlo. Allo stesso tempo, questa o quella relazione si forma sempre attraverso il meccanismo di comunicazione stabilito. Ecco perché ogni insegnante deve affrontare il compito di padroneggiare la tecnologia della comunicazione pedagogica. L'ignoranza di tale tecnologia porta al fatto che le azioni comunicative vengono eseguite per tentativi ed errori.
Le principali difficoltà che l'insegnante incontra nel comunicare con gli studenti sono legate all'incapacità di stabilire un contatto, gestire la comunicazione degli studenti in classe, costruire relazioni e ricostruirle a seconda delle specificità dei compiti pedagogici, con una mancanza di comprensione della psicologia interna dello studente posizione. Infine, si tratta di difficoltà nella comunicazione verbale e nel trasferimento del proprio atteggiamento emotivo al materiale educativo, nonché nell'incapacità di gestire il proprio stato mentale nella comunicazione. Il possesso da parte dell'insegnante della tecnologia della comunicazione pedagogica è importante anche perché determina l'atteggiamento dei bambini nei confronti dell'insegnante, che spesso trasferiscono alla materia che insegna.
4. Compito comunicativo
Per comprendere l'essenza della tecnologia della comunicazione pedagogica, è necessario fare riferimento al concetto di "compito comunicativo", poiché il processo di comunicazione professionale e pedagogica può essere rappresentato come un sistema di compiti comunicativi. Il compito comunicativo, essendo un derivato del compito pedagogico, ed essendo il suo sfondo, ha le stesse fasi di soluzione del precedente: analisi della situazione, enumerazione delle opzioni e selezione di quella ottimale, impatto comunicativo e analisi dei suoi risultati .
Pertanto, il compito comunicativo è lo stesso compito pedagogico, ma tradotto nel linguaggio della comunicazione.
Allo stesso tempo, il compito comunicativo, che riflette il compito pedagogico, è ausiliario rispetto ad esso (V.A. Kann-Kalik). Pertanto, organizzando un impatto pedagogico specifico, è necessario presentare le modalità della sua attuazione comunicativa.
È consuetudine distinguere tra i compiti comunicativi generali dell'attività imminente, che, di norma, sono pianificati in anticipo, e gli attuali compiti comunicativi che sorgono nel corso dell'interazione pedagogica. Il compito comunicativo generale si riduce alla narrazione (messaggio) e alla motivazione. La narrazione è rappresentata dalle seguenti varietà: la narrazione stessa, il messaggio, il nome, l'annuncio, l'enumerazione, la risposta, ecc. La motivazione ha anche tipi, come un ordine, una domanda, una richiesta, un invito, eccetera.
Pertanto, nel processo di risoluzione dei compiti comunicativi, l'insegnante realizza due obiettivi principali: trasmettere un messaggio agli studenti o influenzarli, ad es. indurre all'azione.
I compiti comunicativi possono essere considerati come un mezzo per risolvere un problema di apprendimento nel contesto delle attività di apprendimento. Nel processo di comunicazione con gli studenti in classe, l'insegnante risolve compiti comunicativi di diversa natura, realizzando varie funzioni pedagogiche. Sono state identificate quattro serie funzionali di azioni comunicative dell'insegnante: stimolanti, responsive (valutative e correttive), controllanti, organizzative.
Per un insegnante che gestisce l'attività di apprendimento dello studente, è importante non solo comprendere chiaramente e differenziare i tipi di azioni comunicative che guidano l'attività di apprendimento dello studente, ma anche determinare quale di queste azioni può risolvere i compiti di comunicazione pedagogica.
5. Fasi di risoluzione di un compito comunicativo
La tecnologia della comunicazione pedagogica verrà divulgata, in modo incompleto, se non caratterizzi le fasi della risoluzione di un compito comunicativo. Possono essere presentati come segue: orientamento nelle condizioni della comunicazione; attirare l'attenzione; "oggetto"; implementazione della comunicazione verbale; organizzazione del feedback significativo e connessione emotiva.
Nella fase di orientamento nelle condizioni di comunicazione, ha luogo un complesso processo di "adattamento" dello stile generale di comunicazione a specifiche condizioni di comunicazione (lezione, evento, ecc.). Tale adattamento si basa sulle seguenti componenti: la consapevolezza dell'insegnante dello stile di comunicazione con gli studenti; ripristino mentale delle precedenti caratteristiche di comunicazione in una data squadra - memoria comunicativa; chiarimento dello stile di comunicazione nelle nuove condizioni comunicative di attività, in base alla situazione in classe e ai compiti pedagogici attuali.
Qui c'è una concretizzazione dell'oggetto della comunicazione, che può essere una classe, un gruppo di bambini o singoli alunni.
La fase di attirare l'attenzione su di sé può essere implementata in diversi modi: - discorso - comunicazione verbale con gli studenti; - pausa con attivo requisito interno auto-attenzione; - segno motorio - l'uso di talits, scrittura sulla lavagna; - una versione mista che include elementi dei tre precedenti.
Molto spesso viene utilizzato un tipo misto di attrazione dell'attenzione.
Una comunicazione professionale e pedagogica produttiva richiede un attento "sondaggio dell'anima dell'oggetto" (termine di K. S. Stanislavsky). In questa fase, l'insegnante chiarisce le idee che si sono sviluppate nelle fasi precedenti sulle condizioni della comunicazione e sui possibili compiti comunicativi, cerca di cogliere il livello di prontezza del pubblico per avviare una comunicazione produttiva.
La fase principale nella risoluzione di un compito comunicativo è l'implementazione della comunicazione verbale. Il successo di tale comunicazione presuppone che l'insegnante abbia una buona memoria verbale: la capacità di selezionare correttamente strumenti linguistici, fornendo un discorso brillante ed espressivo, costruire logicamente una presentazione delle informazioni trasmesse, orientare il discorso all'interlocutore; alto livello (anticipazione).
La fase finale della risoluzione di un compito comunicativo è l'organizzazione di feedback significativi ed emotivi. Informativo Feedback fornisce informazioni sul livello di assimilazione del materiale didattico da parte degli studenti. Il feedback emotivo viene stabilito dall'insegnante sentendo l'umore della classe in una data lezione o evento, che può essere colto solo dal comportamento degli studenti, dalle espressioni dei loro volti e occhi, da osservazioni individuali e reazioni emotive. Il feedback significativo in unità con il feedback emotivo fornisce all'insegnante informazioni sul livello di percezione del materiale e sull'atmosfera cognitiva e morale della lezione.
6. Fasi della comunicazione pedagogica e della tecnologia per la loro attuazione
La comunicazione pedagogica ha dinamiche corrispondenti alla logica del processo pedagogico (intenzione, realizzazione dell'idea, analisi e valutazione). Da qui le sue fasi:
Fase 1 - la modellazione della comunicazione pedagogica è associata all'implementazione di una sorta di pianificazione di una struttura comunicativa di interazione adeguata ai compiti pedagogici, alla situazione attuale, all'individualità dell'insegnante, alle caratteristiche dei singoli studenti e della classe come Totale. In questa fase, i compiti pedagogici vengono trasferiti nella sfera dei compiti comunicativi, viene raggiunta la loro corrispondenza, che garantisce l'attuazione produttiva degli obiettivi dell'interazione pedagogica. Un elemento necessario per modellare la comunicazione imminente è la previsione di una possibile atmosfera psicologica. Ciò determina gli effettivi aspetti pedagogici dell'interazione, consente all'insegnante di presentare il suo comportamento comunicativo e il suo stato emotivo.
Fase 2 - l'organizzazione della comunicazione diretta, durante la quale l'insegnante assume la guida nella gestione della comunicazione. È qui che avviene la concretizzazione dell'oggetto della comunicazione (di solito la classe nel suo insieme).
È importante che l'insegnante attiri l'attenzione degli studenti, perché comunicazione effettiva con la classe è possibile solo se l'attenzione degli studenti è focalizzata sull'insegnante.
Fase 3 - gestione della comunicazione, la cui essenza è il supporto comunicativo dei metodi di influenza applicati. La gestione della comunicazione consiste nel concretizzare il modello di comunicazione, chiarire le condizioni e la struttura della comunicazione e attuare la comunicazione diretta.
La condizione principale per la gestione della comunicazione è l'iniziativa dell'insegnante, che consente di risolvere una serie di compiti strategici e tattici: fornire una guida per il processo, creare un'atmosfera emotiva, ecc.
Fase 4 - analisi del corso e risultati della tecnologia implementata della comunicazione pedagogica. Molto spesso, è chiamato la fase di feedback nella comunicazione e, in termini di contenuto e tecnologia di implementazione, corrisponde a fase finale risolvere un problema di comunicazione. Il significato principale di questa fase è diagnostico e correttivo.
Queste fasi caratterizzano l'implementazione graduale della comunicazione pedagogica.
Lo sviluppo della personalità di un bambino dipende non solo dalla natura delle relazioni con gli adulti, ma anche dall'influenza dei coetanei. La simpatia per un altro bambino si trasforma gradualmente in un bisogno di comunicare con lui.
La necessità di comunicare con i coetanei si sviluppa, prima di tutto, sulla base delle attività congiunte dei bambini nel gioco, oltre che sul gioco.
I coetanei si influenzano a vicenda. È nel processo di comunicazione che il bambino si trova di fronte alla necessità di mettere in pratica le norme di comportamento apprese in relazione ad altre persone, di adattare queste norme e regole a una varietà di situazioni specifiche. Nelle attività congiunte dei bambini sorgono costantemente situazioni che richiedono il coordinamento delle azioni, manifestazioni di un atteggiamento benevolo nei confronti dei coetanei. Gli studenti rinunciano ai desideri personali per raggiungere un obiettivo comune. In queste situazioni i bambini non sempre trovano il modo giusto di comportarsi. Spesso sorgono conflitti tra loro, quando ognuno difende il proprio desiderio, indipendentemente dai desideri e dalle regole del suo pari. Ma è proprio a questa età che il bambino scopre da sé la verità che senza empatia per l'altro, senza concessione all'altro, lui stesso rimarrà un perdente. Le relazioni sul gioco e la relazione del gioco agiscono in realtà come una scuola di relazioni sociali.
7. Stili di comunicazione degli insegnanti
L'insegnante della lezione ha l'opportunità di influenzare individualmente la classe e ogni bambino attraverso quelle norme accettate che sono prescritte dalle tradizioni e dalle regole della scuola. Di solito l'insegnante sta di fronte alla classe e tutti i bambini dovrebbero sedersi e ascoltare l'insegnante quando spiega. L'insegnante cammina tra le file e controlla il lavoro di tutti, quando i bambini scrivono, disegnano. L'insegnante è impegnato nella lezione con l'attuazione del piano di lavoro per insegnare ai bambini. Con tutta l'uniformità del lato esterno del lavoro dell'insegnante in classe, si possono distinguere una serie di stili tipici di influenza sugli studenti.
1. Con uno stile di comunicazione autoritario, l'insegnante decide da solo tutte le questioni relative alla vita sia del gruppo di classe che di ogni studente. Gli insegnanti non consentono agli studenti di mostrare indipendenza e iniziativa. Lo stile di comunicazione autoritario dà origine a un'autostima inadeguata degli studenti, instilla un culto del potere, forma nevrotici e provoca un livello inadeguato di affermazioni nella comunicazione con le persone che li circondano.
2. Permissivo (ignorante) è caratterizzato dal desiderio dell'insegnante di essere minimamente coinvolto nell'attività, che si spiega con l'eliminazione della responsabilità per i suoi risultati.
Le caratteristiche comuni degli stili di comunicazione conniventi e autoritari, nonostante l'apparente opposto, sono il rapporto tra insegnante e studenti, la mancanza di fiducia tra loro, l'evidente isolamento, l'alienazione dell'insegnante, la sottolineatura dimostrativa o la sua posizione dominante.
3. Democratico (stile di collaborazione): l'insegnante si concentra sull'aumento del ruolo soggettivo dello studente nell'interazione, sul coinvolgimento di tutti nella risoluzione di problemi comuni. La caratteristica principale di questo stile è l'accettazione reciproca e l'orientamento reciproco.
8. La dipendenza del comportamento del bambino in classe dallo stile comunicativo dell'insegnante
Lo studente più giovane è in grande dipendenza emotiva dall'adulto. La cosiddetta fame emotiva - il bisogno di emozioni positive di un adulto significativo - determina in gran parte il comportamento del bambino. Lo stile di comunicazione di un adulto determina il suo comportamento in classe durante la lezione, in sala giochi e altri luoghi riservati ad attività e divertimenti.
Quindi lo stile imperativo si distingue per la posizione alienata dell'insegnante nei confronti dei bambini. Non sentendo la vicinanza emotiva con il suo insegnante, il bambino cerca inconsciamente di compensare il bisogno insoddisfatto di emozioni positive. Non appena, secondo l'opinione del bambino, c'è l'opportunità di rivolgersi al vicino di scrivania oa qualcun altro, inizia subito a comunicare in ogni occasione. La tensione della volontà, non incoraggiata dagli adulti, stanca ed esaurisce rapidamente il bambino, cerca inconsciamente di alleviare la tensione. Tuttavia, l'occhio vigile dell'insegnante coglie di sorpresa il trasgressore della disciplina. L'insegnante fa un'osservazione, punisce il bambino. I ricercatori hanno osservato il lavoro di insegnanti con diversi stili di comunicazione e studiato i tipi di punizione dei bambini per violazioni disciplinari. Si è scoperto che gli insegnanti con uno stile di comunicazione imperativo fanno più commenti, scrivono nel diario, valutano il comportamento come "2", mettono il bambino più spesso alla scrivania, in un angolo, ecc.
Allo stesso tempo, gli insegnanti con uno stile di comunicazione democratico non accarezzano mai il bambino per l'orecchio, non esercitano alcuna violenza fisica. Fanno osservazioni verbali, guardano rigorosamente il bambino che viola la disciplina, ma, soprattutto, lavorano con la classe, organizzandola per attività di apprendimento, formando un interesse cognitivo.
È stato riscontrato che i bambini rispondono in modo diverso alla domanda: "Perché segui le regole di condotta in classe", a seconda dello stile di comunicazione: 1. Stile imperativo - la risposta: "Temo che ..." Il bambino ha paura dell'insegnante; ha paura che l'insegnante “gridi”, “sgridi”, ecc. Lo stile comunicativo imperativo dell'insegnante, sebbene influisca sulla disciplina della classe, è uno stile improduttivo in termini di educazione della personalità del bambino. Questo stile sviluppa la riflessione negativa, la capacità di correlare il proprio comportamento con i risultati successivi. E il desiderio di trarne il massimo beneficio per se stesso. Il bambino cerca di imparare ad agire in modo tale che l'insegnante non veda la sua indisciplina, inizia ad agire di nascosto.
Lo stile di comunicazione democratico genera motivazioni buoni rapporti con l'insegnante, motivazioni per le attività di apprendimento, motivazioni per la collaborazione con l'intera classe. Il bambino inizia a essere timido riguardo ai commenti, perché vergognarsi di infrangere le regole. Vuole che il suo insegnante lo ami, che i suoi genitori siano felici con lui, che i suoi compagni lo trattino bene. Comincia a sforzarsi di rispettare le regole, perché. questo è suo dovere, dandogli la possibilità di esercitare il diritto al silenzio in aula durante la lezione.
Un insegnante esperto non dirà a un bambino “Alzati! Ti stai comportando male". Dirà diversamente: "Chi impedisce alla classe di lavorare, il gatto ci priva del diritto al silenzio". In questo caso, il comportamento del bambino viene valutato dal punto di vista del suo atteggiamento nei confronti degli altri. Il buon comportamento di tutti è inteso come la chiave del successo di tutti. Lo stile democratico sviluppa una riflessione positiva: la capacità di correlare il proprio comportamento con i risultati successivi e il desiderio di costruire il proprio comportamento in modo che aiuti il \u200b\u200blavoro dell'intera classe, dell'insegnante e del bambino stesso. Un'analisi degli stili di comunicazione degli insegnanti ha mostrato che l'unico stile produttivo è quello democratico.
9. L'influenza dello stile comunicativo dell'insegnante sull'attività dello studente
Possiamo considerare l'attività in tutte e tre le sue forme: fisica, psicologica, sociale.
Attività fisica: il suo tono, la necessità di un movimento instancabile, la destrezza è un indicatore di salute e potenziale per lo sviluppo della sua psiche. Un bambino sano è curioso e curioso. Desidera ardentemente la conoscenza del mondo che lo circonda. L'attività fisica e psicologica del bambino è in stretta interazione: un bambino vigoroso e sano è mentalmente attivo, un bambino stanco e tormentato non è più interessato a nulla.
L'attività mentale è la necessità di un normale bambino in via di sviluppo di conoscere la vita circostante: natura, relazioni umane; il bisogno di autoconoscenza del bambino.
Lo stile democratico implica il pieno coinvolgimento dell'insegnante nello stato della classe e di ogni singolo studente. Numerosi studi di psicologi e insegnanti hanno dimostrato l'importanza di includere i cosiddetti minuti di educazione fisica, i movimenti alla musica nel contenuto della lezione.
Comprendere che i bambini devono essere disciplinati e il desiderio di essere disciplinati dovrebbe essere ricompensato con il diritto del bambino al riposo.
Lo stile imperativo disciplina la classe in termini di obbedienza all'ordine esterno stabilito, i bambini non parlano e stanno fermi.
Studi speciali hanno dimostrato che lo stesso stile di comunicazione, caratteristico di un insegnante, determina la misura del successo di un bambino nelle attività di apprendimento. A seconda dello stile di comunicazione dell'insegnante con la classe e con il singolo bambino, l'efficienza e il successo dell'attività cognitiva, l'attività psicologica del bambino cambia. Lo stile democratico comporta un appello alla cooperazione e all'attività cognitiva. La normatività, rivestita di una forma attraente di comunicazione riservata per il bambino sull'attuale compito educativo, organizza la sua attenzione, fa funzionare la memoria e il pensiero. Studio speciale ha mostrato che solo uno stile democratico crea le condizioni per lo sviluppo dell'attività mentale di un bambino. L'attività sociale del bambino si sviluppa insieme alla sua attività psicologica, quando, sotto la guida di un adulto, si rivela l'autocoscienza del bambino.
10. Studente junior in comunicazione con un insegnante
Ricerca di A.E. Lagutina mostrano che i bambini privati di adulti vicini, cresciuti in una mancanza di comunicazione, non possono vivere appieno gli eventi della propria vita. Situazioni di vita non condivise da nessuno, inconsce e non vissute, non vengono affatto ricordate.
Pertanto, all'età di 6-10 anni, i bambini hanno bisogno di un adulto che organizzi l'esperienza della loro vita e aiuti a percepirla e realizzarla.
Durante questo periodo avviene la formazione della personalità del bambino e la comunicazione con gli adulti è una delle condizioni più importanti per questo. Nel periodo dai 6 ai 10 anni, il bambino è aperto in relazione ai rappresentanti socio-culturali normativi esistenti nella società.
L'assimilazione di norme e regole etiche. il desiderio di seguire modelli culturali gli permette di "crescere" facilmente, senza mostrare critiche e resistenze, nella cultura in cui vive.
Tuttavia, la conoscenza e le idee da sole non sono sufficienti per la formazione di una personalità. Il bambino per un periodo piuttosto lungo mostra un comportamento abbastanza evidente tra verbale e reale. Conoscere le regole, non seguirle, valutare correttamente eventi ed eroi, si comporta in modo impulsivo, a volte imprevedibile.
Lo sviluppo personale richiede la capacità di analizzare il proprio comportamento, frenare gli impulsi immediati e risolvere i conflitti interni. Ecco perché gli psicologi parlano solo di creare i prerequisiti per lo sviluppo personale durante questo periodo della vita. Affinché tali prerequisiti si sviluppino, è necessario padroneggiare "l'arbitrarietà generale del proprio comportamento" (L.S. Vygodsky), la subordinazione dei motivi delle proprie azioni (A.N. Leontiev), nonché l'esperienza e l'accettazione emotiva di quelle morali norme e regole che diventano regolatori di comportamento (L.I., V.V. e altri)
All'età di 5-7 anni, sotto l'influenza della comunicazione con gli adulti, si forma un tipo speciale di relazione, chiamato M.I. al di fuori del personale situazionale. Un bambino e un adulto entrano in partnership non su oggetti e azioni con loro, ma su manifestazioni personali di persone. Il bambino è interessato a un vasto mondo di valori universali, giudizi, valutazioni e opinioni di un adulto.
I bambini dai 6 ai 7 anni hanno bisogno di attenzioni speciali. Lo sviluppo cognitivo del bambino gli consente di diventare uno studente e lo sviluppo personale indica che psicologicamente è ancora un bambino in età prescolare. Come stabilito da M.I., il bambino si aspetta ancora elogi e approvazione da un adulto, e tuttavia si sopravvaluta, ma dal punto di vista degli adulti, l'autostima è del tutto adeguata ai compiti dello sviluppo personale. Il suo significato sta nell'attività e nel coraggio speciali, nel desiderio di sperimentare il mondo, in un senso positivo di sé, allegria, accettazione emotiva di sé.
Nel periodo dai 7 ai 10 anni, secondo insegnanti, psicologi, medici, si verificano bruscamente varie difficoltà di sviluppo. Gli scolari più giovani spesso perdono l'attività emotiva insita nei bambini in età prescolare, l'allegria, hanno difficoltà nell'apprendimento e nel comportamento. Diminuzione dell'autostima, manifestazione di ansia, insicurezza, paura e molte altre manifestazioni di instabilità psico-emotiva diventano abbastanza tipiche. Un bambino in età scolare è in grande dipendenza emotiva dall'insegnante. La cosiddetta fame emotiva - il bisogno di emozioni positive di un adulto significativo, e l'insegnante è proprio un tale adulto - determina in gran parte il comportamento del bambino. La comunicazione con un adulto non dovrebbe essere limitata al trasferimento di determinate conoscenze, istruzioni, norme, regole. Nello spazio del "deve" e del "dovrebbe" non c'è spazio per l'iniziativa personale, la creatività e la propria ricerca. La pressione dell'insegnante può trasformarsi in soppressione della personalità, comportare problemi e difficoltà psicologiche.
Un bambino in età scolare si sforza di ricevere l'approvazione di un adulto per i suoi risultati che soddisfano le aspettative sociali.
Durante questo periodo, i motivi del comportamento e dell'attività sono saturi di nuovi contenuti sociali. I motivi educativi per stabilire relazioni con adulti e coetanei riguardo alle attività educative con tutte le sue componenti iniziano ad assumere un posto speciale nelle affermazioni di un bambino in età scolare. Questo trova espressione nella relazione del bambino con l'insegnante.
A scuola si sviluppa un tipo speciale di relazione tra lo studente e l'insegnante. Un insegnante non è solo un adulto che suscita o non ama un bambino. È un intermediario della conoscenza, la cui funzione è trasferire a un bambino le conquiste della cultura dell'esperienza dell'umanità.
Inoltre, l'insegnante è un vero portatore richieste pubbliche al bambino come studente. La partecipazione congiunta alle attività di apprendimento genera un nuovo tipo di relazione; l'insegnante chiede - lo studente deve capire e realizzare, l'insegnante valuta - lo studente dà per scontato. Allo stesso tempo, il bambino è concentrato nel soddisfare le aspettative dell'insegnante e nel farsi riconoscere da lui.
Il bambino, spinto da un adulto, inizia, si sforza di sviluppare le capacità di autocontrollo e autostima.
Cambiare posto con stile relazioni pubbliche- il passaggio alla posizione di studente, scolaro - crea una situazione di apertura psicologica del bambino. E senza che, fidandosi di un adulto, in una nuova situazione di vita per lui, il bambino accetta prontamente le esigenze dell'insegnante. Allo stesso tempo, il bambino non apprende opportunamente e insensibilmente nuove regole per lui, ma sperimenta una misura di ammissibilità, la possibilità di infrangere queste regole, evitarne l'attuazione o impegnarsi in una discussione con l'insegnante.
Uno studente più giovane è in grado di mostrare la riflessione - la capacità di andare oltre una situazione specifica e considerare le azioni mentali che compie, è in grado di realizzare e controllare le sue azioni di apprendimento. Tuttavia, le nuove abilità non sono dirette da lui nella situazione di apprendimento a se stesso. Impara a scuola sulla natura, sul mondo e impara molto poco su se stesso.
Allo stesso tempo, lo sviluppo della personalità viene effettuato nel corso della consapevolezza di se stesso e delle sue capacità da parte di una persona. Per fare ciò, l'insegnante deve aiutare gli studenti nello sviluppo dell'autoconoscenza, nella padronanza dei mezzi di autoconoscenza e autoregolamentazione.
Nell'educazione di uno studente più giovane, rimane poco spazio per la comunicazione personale con gli adulti e la precedente esperienza personale emotivamente colorata del bambino, compresa quella psicologica, i suoi concetti e le sue idee, non è sufficientemente presa in considerazione. Tutte queste circostanze possono creare difficoltà nel processo di comunicazione con l'insegnante.
Pertanto, gli studenti più giovani nel processo di comunicazione mostrano le seguenti caratteristiche pronunciate:
Discrepanza tra comportamento verbale e reale;
Diminuzione dell'autostima, attività emotiva;
Manifestazione di ansia, incertezza, paura e altri segni di instabilità psico-emotiva; l'emergere della dipendenza emotiva dall'insegnante - sul riconoscimento da parte degli adulti dei loro risultati, il desiderio di soddisfare le aspettative dell'insegnante, di essere riconosciuto;
Apertura psicologica;
I motivi di apprendimento e i motivi per stabilire relazioni con i coetanei adulti iniziano ad assumere un posto speciale;
Il desiderio di autoaffermazione, autocontrollo e autostima.
Nel processo di comunicazione, l'insegnante dovrebbe instillare nello studente fiducia nelle proprie capacità, stimolare un'autoeducazione positiva, lo sviluppo personale e il superamento delle difficoltà. Lo sviluppo degli studenti più giovani è in gran parte determinato dalla comunicazione pedagogica che l'insegnante crea nello spazio di apprendimento.
Sulla base del fatto che la comunicazione pedagogica è finalizzata a creare condizioni ottimali per lo sviluppo di ogni individuo, è necessario attuare i seguenti obiettivi educativi e didattici:
Creazione delle migliori condizioni per lo sviluppo della motivazione all'apprendimento e della natura creativa delle attività educative;
Contribuire alla formazione della personalità;
Mantenere un clima emotivo favorevole per ogni studente;
Stimolazione dei processi di autoconoscenza, autoeducazione, creazione di un'adeguata autostima;
Organizzazione delle condizioni per l'autorealizzazione degli studenti;
Fornire le condizioni per l'attività mentale, sociale e fisica.
11. Metodologia delle abilità di autoapprendimento e abilità della comunicazione pedagogica
L'incapacità di comunicare e risolvere vari problemi nel processo di comunicazione è caratteristica non solo dei bambini, ma anche di noi stessi come insegnanti ed educatori, e finché non lo impariamo noi stessi, difficilmente possiamo contare sul fatto che saremo in grado di insegnare questo ai bambini.
La capacità di un insegnante di comunicare con i bambini viene talvolta interpretata come la capacità di un insegnante di presentare e spiegare correttamente il materiale agli studenti in classe, di parlare con i bambini su argomenti di loro interesse. Questo, ovviamente, è incluso nella struttura delle abilità comunicative pedagogiche, ma le abilità stesse non sono limitate alle abilità e abilità corrispondenti. Oltre a quanto sopra, la presenza di capacità pedagogiche per comunicare con i bambini implica:
1. La capacità di comprendere correttamente il bambino, di vedere le cose attraverso i suoi occhi.
2. La capacità di vedere in lui una personalità uguale.
3. Disponibilità a essere critici con se stessi e riconoscere apertamente le critiche a se stessi da parte di studenti e alunni.
4. La capacità di non ingannare, di non imbrogliare, di dire sempre e ovunque solo la verità.
5. La capacità di esercitare la necessaria influenza pedagogica sugli studenti.
6. Padroneggiare il senso dell'umorismo.
7. Possesso della parola.
L'educatore può anche di volta in volta porsi o chiedere ad altri di rispondere alle seguenti domande su di lui:
1. Che impressione faccio sui bambini
2. Sono abbastanza casuale e rischioso con loro?
3. Sincero o non sincero, guardo dalla loro parte
4. Ho abbastanza capacità sviluppate per avere figli per me stesso
5. Posso avere una conversazione con i bambini su qualsiasi argomento
6. I bambini si sentono liberi come me quando interagiscono con me?
7. Riesco sempre a convincere i bambini oa volte devo ordinare
8. Ho il senso dell'umorismo
9. Come i miei figli percepiscono la mia battuta
10. Ci sono bambini che evitano di comunicare con me
11. Ci sono situazioni in cui i bambini sono riluttanti a comunicare con me
Dopo l'autovalutazione e l'autoanalisi dei dati sulle capacità e abilità comunicative, l'insegnante può, personalmente, autonomamente o con l'aiuto dei suoi colleghi, sviluppare raccomandazioni per la loro correzione.
1. Questi segnali devono incontrarsi regolarmente ed essere visti quotidianamente dalla persona.
2. Dovrebbero apparire proprio in quei momenti in cui è necessario applicare le abilità e le abilità comunicative necessarie.
In conclusione, ne formeremo diversi regole generali, in seguito al quale potrebbe anche aiutare l'insegnante a sviluppare le sue capacità pedagogiche:
1. Evita frequenti giudizi moralistici sullo studente, ma è meglio non usarli affatto.
2. Evitare l'uso di punizioni e qualsiasi minaccia contro il bambino.
3. Evita di scaricare i tuoi problemi e le tue difficoltà sui bambini, lamentati meno con i bambini.
4. Evitare manifestazioni di intolleranza, irritabilità nei confronti dei bambini e in loro presenza.
5. Evita di prendere in giro i bambini e le altre persone.
6. Evita tutto ciò che può in qualche modo umiliare il bambino.
7. Evita di trarre conclusioni premature e, soprattutto, "definitive" sul bambino come persona, persona.
8. Riconoscere e rispettare, non a parole, ma nei fatti, il diritto del minore di avere, e osare, esprimere apertamente le proprie opinioni su qualsiasi questione.
Solo padroneggiando tutte queste regole e seguendole rigorosamente, l'insegnante può far crescere nel bambino la personalità di cui abbiamo urgente bisogno ora.
La comunicazione è una sfera indipendente della vita delle persone e, d'altra parte, permea tutte le sue altre sfere - conoscenza, materia-pratica e spirituale- attività pratiche, gioco, sport.
La comunicazione gioca un ruolo importante nello sviluppo umano: nel padroneggiare le norme del comportamento socio-politico, nello sviluppo emotivo, nell'acquisire un'esperienza sociale individuale, nel realizzare e affermarsi come persona.
La comunicazione pedagogica è costituita da una serie di componenti. Include conoscenze scientifiche in pedagogia e psicologia, ad es. abilità professionali, etica pedagogica e tecnica pedagogica.
La tecnica pedagogica consente all'insegnante di scegliere il tono giusto nella comunicazione con gli studenti e i loro genitori. Tono, stile dei rapporti con i bambini giusta scelta dizione, espressioni facciali, gesti: tutto questo è incluso nel concetto di tecnologia pedagogica.
L'insegnante è obbligato a controllare costantemente la sua comunicazione pedagogica nella misura in cui gli è soggetta la soluzione dei problemi professionali, per cercare i modi migliori per la mente e il cuore dei bambini.
Bibliografia
1. Brudny A.A. Comprensione e comunicazione. M., 1997.
2. Bueva L.B. Ambiente sociale e coscienza della personalità. M., 1968.
3. Dobrovich A.B. Educatore di psicologia e psicoigiene della comunicazione. M., 1987
4. Zimnyaya I.A. Psicologia pedagogica: un libro di testo per le università. ed. secondo, aggiungi., corretto. e perab. - M.: Loghi, 2004.
5. Kann-Kalik V.A. Insegnante di comunicazione pedagogica. M., 1987.
6. Carnegie D. Come sviluppare la fiducia in se stessi e influenzare le persone parlando in pubblico. Minsk, 1990.
7. Leont'v A.A. Psicologia della comunicazione, 2a ed., corretta. e aggiuntivi M., 1997.
8. Leontiev A.A. Comunicazione pedagogica, 2a ed., riveduta. e aggiuntivi - M., 1997.
9. Lisina M.N. Comunicazione, personalità e psiche del bambino. M.; Voronezh, 1997.
10. Markova A.K. Psicologia del lavoro dell'insegnante. M.; 1993.
11. Mitina A.K. L'insegnante come persona e professionista. M.; 1994.
12. Nemov R.S. Psicologia: tutorial per gli studenti delle scuole pedagogiche. - M.; Illuminismo, 1980. - 301 p.: riprod.
13. Panferov V.N. Psicologia della comunicazione // Questioni di filosofia. 1972 n. 7
14. Petrovskaya LA Competenza nella comunicazione: sociale formazione psicologica. M., 1989.
15. Pedagogia: manuale per studenti ped. ah. istituzioni / V.A. Slastenin, IF Isaev, A.I. Mishchenko, E.N. Shiyanov. - M.; School-Press, 1998. - 512 p.
16. Yakobson P.M. La comunicazione delle persone come problema socio-psicologico. M.; 1973.
Documenti simili
La comunicazione pedagogica nella struttura dell'attività pedagogica. Tecnologia della comunicazione pedagogica. Fasi di comunicazione pedagogica e tecnologia per la loro attuazione. Funzioni ed esigenze psicologiche dell'insegnante nell'organizzazione del processo educativo.
test, aggiunto il 14/02/2011
test, aggiunto il 16/10/2011
Concetti di comunicazione pedagogica. Stili di comunicazione. Il valore dello stile individuale di comunicazione e dei mezzi per aumentare le capacità comunicative dell'insegnante. Mezzi di sviluppo della comunicazione. Progettazione della comunicazione pedagogica e preparazione ad essa. Tecnologia della comunicazione.
tesina, aggiunta il 21/12/2008
Comunicazione professionale di un insegnante con gli studenti in un processo pedagogico olistico, le sue indicazioni. Gli obiettivi della comunicazione pedagogica, caratteristiche dell'attuazione dei suoi compiti. Percezione e comprensione della personalità dello studente da parte dell'insegnante. Funzioni della comunicazione pedagogica.
presentazione, aggiunta il 13/06/2014
L'essenza della comunicazione pedagogica e le sue funzioni principali. Fondamenti psicologici e pedagogici dell'organizzazione del processo di apprendimento a scuola. Stili e tecnologia della comunicazione pedagogica e condizioni per la sua attuazione. Esperienza nell'organizzazione di lezioni in una serie di discipline con gli scolari.
tesina, aggiunta il 06/01/2014
Comunicazione pedagogica: l'essenza del concetto, le caratteristiche, l'obiettivo principale. Contatto, funzioni motivanti e amotivazionali della comunicazione. Orientamento e tappe principali della comunicazione pedagogica. Stile di comunicazione autoritario, democratico, liberale, manipolativo.
presentazione, aggiunta il 25/07/2011
La comunicazione pedagogica come mezzo attraverso il quale si realizza l'attuazione dei compiti di formazione e istruzione. Stili di comunicazione pedagogica, loro caratteristiche. Sviluppo mentale dello studente più giovane. Valutazione dell'impatto della comunicazione pedagogica sugli studenti.
tesina, aggiunta il 09/08/2014
Psicologia e struttura della comunicazione pedagogica. L'aspetto comunicativo della comunicazione pedagogica. La personalità dell'insegnante nella struttura formazione degli insegnanti. Caratteristiche degli aspetti formali degli stili pedagogici. Tecnologie interattive nell'istruzione.
rapporto pratico, aggiunto il 27/11/2014
La comunicazione pedagogica in una scuola professionale, le sue condizioni. L'influenza della comunicazione pedagogica sul livello di istruzione e educazione degli studenti in una scuola professionale. Applicazione di modelli e tecnologie della comunicazione pedagogica nel processo educativo.
tesina, aggiunta il 15/12/2010
Interazione umana con altre persone. Funzioni e mezzi della comunicazione pedagogica. Stili di comunicazione pedagogica e stili di leadership pedagogica. Cambiare la distanza di comunicazione. Il meccanismo di conoscenza e comprensione dell'identità personale dell'alunno.
Classificazione delle abilità pedagogiche.
Caratterizzazione dei principali tratti psicologici della personalità dell'insegnante come individuo.
Una delle principali qualità professionalmente significative della personalità di un insegnante è il suo "orientamento personale".
Si possono distinguere tre direzioni che determinano l'essenza dell'orientamento pedagogico: un atteggiamento emotivo e di valore nei confronti della professione docente, una tendenza a impegnarsi in attività che incarnano le specificità di questa professione; una qualità professionalmente significativa della personalità di un insegnante o una componente delle capacità pedagogiche; gestione riflessiva dello sviluppo degli studenti.
L'orientamento pedagogico è la motivazione per la professione di insegnante, la cosa principale in cui è un efficace orientamento allo sviluppo della personalità dello studente. Un orientamento pedagogico sostenibile è il desiderio di diventare, essere e rimanere un insegnante, aiutandolo a superare ostacoli e difficoltà nel suo lavoro. L'orientamento della personalità dell'insegnante si manifesta in tutta la sua vita professionale e nelle singole situazioni pedagogiche, determina la sua percezione e logica di comportamento, l'intero aspetto di una persona. Lo sviluppo dell'orientamento pedagogico è facilitato dallo spostamento della motivazione dell'insegnante dal lato tematico del suo lavoro alla sfera psicologica, interesse per la personalità dello studente.
Il motivo principale di un orientamento veramente pedagogico è l'interesse per il contenuto dell'attività pedagogica. L'orientamento pedagogico come suo livello più alto include una vocazione che si correla nel suo sviluppo con la necessità dell'attività scelta. In questa fase più alta dello sviluppo - la vocazione - "un insegnante non può immaginarsi senza una scuola, senza la vita e il lavoro dei suoi studenti".
Gli insegnanti orientati allo "sviluppo" sono relativamente più propensi a prestare attenzione ai fattori variabili del rendimento scolastico (per loro, la diligenza o la diligenza degli scolari è di fondamentale importanza); gli insegnanti focalizzati sulla "prestazione" prestano maggiore attenzione ai fattori stabili di rendimento negli studi (le capacità o le inclinazioni degli scolari sono significative per loro). In accordo con ciò, gli insegnanti "orientati al rendimento" ritengono possibile fare previsioni a lungo termine sul rendimento scolastico e sulla futura carriera professionale degli scolari.
Le abilità pedagogiche sono chiamate un insieme di caratteristiche psicologiche individuali della personalità di un insegnante che soddisfano i requisiti dell'attività pedagogica e determinano il successo nella padronanza di questa attività. La differenza tra abilità pedagogiche e abilità pedagogiche sta nel fatto che le capacità pedagogiche sono tratti della personalità e le abilità pedagogiche sono atti separati di attività pedagogica svolta da una persona ad alto livello.
Ogni abilità ha la sua struttura, distingue tra proprietà principali e ausiliarie.
Le proprietà principali nelle abilità pedagogiche sono: tatto pedagogico; osservazione; amore per i bambini; necessità di trasferimento di conoscenze.
Il tatto pedagogico è l'osservanza da parte dell'insegnante del principio di misura nella comunicazione con i bambini in un'ampia varietà di campi di attività, la capacità di scegliere il giusto approccio agli studenti. Il tatto pedagogico implica: rispetto per lo studente ed esattezza nei suoi confronti; sviluppo dell'indipendenza degli studenti in tutti i tipi di attività e ferma guida pedagogica del loro lavoro; attenzione allo stato mentale dello studente e ragionevolezza e coerenza dei requisiti per lui, ecc.
L'osservazione pedagogica è l'abilità di un insegnante, manifestata nella capacità di notare le proprietà essenziali, caratteristiche, persino sottili degli studenti.
Abilità didattiche: la capacità di trasmettere agli studenti materiale didattico, rendendolo accessibile ai bambini, presentando loro il materiale o il problema in modo chiaro e comprensibile, suscitando interesse per l'argomento, suscitando negli studenti un pensiero indipendente attivo. Abilità accademiche - abilità nel campo scientifico pertinente (matematica, fisica, biologia, letteratura, ecc.).
Abilità percettive: la capacità di penetrare nel mondo interiore dello studente, allievo, osservazione psicologica associata a una sottile comprensione della personalità dello studente e dei suoi stati mentali temporanei.
Abilità linguistiche: la capacità di esprimere in modo chiaro e chiaro i propri pensieri, sentimenti attraverso la parola, nonché le espressioni facciali e la pantomima.
Le capacità organizzative sono, in primo luogo, la capacità di organizzare una squadra di studenti, radunarla, ispirarla a risolvere problemi importanti e, in secondo luogo, la capacità di organizzare adeguatamente il proprio lavoro.
Abilità comunicative: la capacità di comunicare con i bambini, la capacità di trovare il giusto approccio agli studenti, di stabilire con loro relazioni adeguate dal punto di vista pedagogico, la presenza di tatto pedagogico.
L'immaginazione pedagogica (o capacità prognostiche) è un'abilità speciale, espressa in previsione delle conseguenze delle proprie azioni, nel disegno educativo della personalità dello studente, associata all'idea di ciò che lo studente diventerà in futuro, nell'abilità prevedere lo sviluppo di determinate qualità dello studente.
La capacità di distribuire l'attenzione contemporaneamente tra più attività; è di particolare importanza per il lavoro dell'insegnante.
La comunicazione pedagogica è una forma specifica di comunicazione che ha le sue caratteristiche e allo stesso tempo obbedisce ai modelli psicologici generali inerenti alla comunicazione come forma di interazione umana con altre persone, comprese le componenti comunicative, interattive e percettive. La comunicazione pedagogica è un insieme di mezzi e metodi che assicurano l'attuazione degli scopi e degli obiettivi dell'istruzione e della formazione e determinano la natura dell'interazione tra l'insegnante e gli studenti.
Gli studi nel campo della psicologia dell'educazione mostrano che una parte significativa delle difficoltà pedagogiche è dovuta non tanto a carenze scientifiche e formazione metodologica insegnanti, quanta deformazione della sfera della comunicazione professionale e pedagogica. L'analisi dei primissimi passi professionali degli insegnanti rivela un fenomeno che potremmo chiamare imprinting pedagogico (imprinting istantaneo): i risultati dei primissimi contatti con gli studenti determinano la scelta della direzione in cui si svilupperà l'ulteriore evoluzione della comunicazione professionale e pedagogica andare.
14.1.1. Definizioni del concetto di comunicazione
La comunicazione è un concetto estremamente complesso e capiente. Spesso viene interpretato come l'interazione di due o più persone al fine di stabilire e mantenere relazioni interpersonali, per ottenere un risultato comune di attività congiunte. Dal punto di vista dell'approccio all'attività domestica, la comunicazione è un processo complesso e sfaccettato di stabilire e sviluppare contatti tra le persone, generato dalla necessità di attività congiunte e che include lo scambio di informazioni, lo sviluppo di una strategia di interazione unificata, la percezione e la comprensione di un'altra persona (Psicologia ..., 1996. P. 224) (http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html).
La comunicazione umana può essere considerata non solo come un atto di scambio verbale di informazioni consapevole e razionalmente formalizzato, ma anche come un contatto emotivo diretto tra le persone. È diverso sia nel contenuto che nella forma di manifestazione. La comunicazione può variare da alti livelli di compenetrazione spirituale dei partner ai contatti più contorti e frammentati (Stankin M.I., 2000; vedi abstract).
La comunicazione è un fenomeno piuttosto sfaccettato (Fig. 1). Rappresenta l'atteggiamento delle persone l'una verso l'altra, la loro interazione e lo scambio di informazioni tra di loro, la loro compenetrazione spirituale. L'aspetto dell'atteggiamento personale è solo una delle componenti, una delle sfaccettature di questo fenomeno.
14.1.2. Approccio interdisciplinare alla comunicazione
La comunicazione è oggetto di studio di molte scienze (Fig. 2, Fig. 3). Per comodità di analisi, N.P. Erastov individua come approcci psicologici indipendenti logico-epistemologico, funzionale-linguistico, complesso-associativo e generale alla comunicazione (Erastov N.P., 1979).
In termini logici ed epistemologici, la comunicazione è considerata come un tipo speciale di attività cognitiva e pratica delle persone finalizzata a un'adeguata riflessione della realtà, svolta in determinate condizioni con determinati obiettivi e con l'ausilio di determinati mezzi. Questo approccio alla comunicazione ti permette di concretizzarla entità sociale al livello dei componenti strutturali e delle loro connessioni tra loro in una forma estremamente generale.
Il processo di comunicazione non può avvenire senza alcun mezzo. L'analisi della corrispondenza di questi mezzi al contenuto, all'ambientazione, agli obiettivi e ai partner della comunicazione contribuisce sotto molti aspetti a comprenderne l'essenza ei meccanismi. È chiaro che un'analisi psicologica della comunicazione è impossibile anche senza uno studio approfondito di mezzi e metodi specifici per trasmettere pensieri, sentimenti e intenzioni delle persone in atti reali di comunicazione.
La lingua è il principale mezzo di comunicazione. Pertanto, lo studio del suo contenuto, forme, tipi, possibilità e norme è il problema più importante della teoria della comunicazione in quanto tale. Questi aspetti della comunicazione sono oggetto del suo studio nell'approccio funzionale-linguistico alla comunicazione.
In realtà, l'analisi psicologica della comunicazione inizia dove vengono utilizzati metodi di ricerca psicologica, ei fatti osservati sono fissati in termini di psicologia come scienza e sono considerati rispetto a modelli psicologici già noti. La comunicazione per uno psicologo è, prima di tutto, i modelli del corso dell'attività mentale delle persone che comunicano tra loro con determinati obiettivi in \u200b\u200bdeterminate condizioni della sua attività.
Nella pratica dell'analisi scientifica, il varie opzioni combinazioni dell'attuale approccio psicologico alla comunicazione con approcci ad essa provenienti da altre scienze (sociologia, filosofia, fisiologia, medicina, pedagogia, ecc.). Gli approcci complesso-combinativo formano un'unica lega, o complesso, di informazioni psicologiche e non psicologiche (teoria socio-psicologica e psicolinguistica della comunicazione), altri rimangono combinazioni ordinarie (teoria psicofisiologica e medico-psicologica della comunicazione).
Molti degli approcci complessi-combinativi alla comunicazione sono sviluppati nell'ambito delle tradizionali branche applicate della psicologia (psicologia sociale, psicologia dell'educazione, psicologia del lavoro, psicologia forense, patopsicologia, zoopsicologia, ecc.). Alcuni degli approcci sono di natura relativamente indipendente (analisi psicolinguistica, logico-psicologica, psicofisiologica della comunicazione).
Ciascuno di questi approcci ha le sue specificità, i suoi problemi. Ma in generale, questi problemi si basano su un'analisi psicologica generale della comunicazione come fenomeno dell'attività mentale.
14.2. Le specificità della comunicazione pedagogica
14.2.1. Caratteristiche della comunicazione pedagogica
La comunicazione pedagogica è una specifica interazione interpersonale tra un insegnante e un allievo (studente), che media l'assimilazione della conoscenza e la formazione di una personalità nel processo educativo (Pedagogico ..., 1993-1996. Vol. 2). Spesso la comunicazione pedagogica è definita in psicologia come l'interazione dei soggetti del processo pedagogico, svolta per mezzo di segni e finalizzata a cambiamenti significativi proprietà, stati, comportamento e formazioni semantiche personali dei partner. La comunicazione è un elemento integrante dell'attività pedagogica; al di fuori di esso, è impossibile raggiungere gli obiettivi della formazione e dell'istruzione (Leontiev A.A., 1996) (http://www.avpu.ru/project/sbornik2004/161.htm).
UN. Leontiev Nella letteratura psicologica e pedagogica ci sono diverse interpretazioni della comunicazione pedagogica (Fig. 4). Diamo un'occhiata ad alcuni di loro. Ad esempio, A.N. Leontiev definisce la comunicazione pedagogica come "la comunicazione professionale di un insegnante con gli studenti in classe e al di fuori di essa (nel processo di formazione e istruzione), che ha determinate funzioni pedagogiche e mira (se è piena e ottimale) a creare un favorevole psicologico clima, così come in un altro tipo di ottimizzazione psicologica dell'attività educativa e delle relazioni tra l'insegnante e lo studente all'interno del gruppo studentesco "(Leontiev A.N., 1979. P. 3). I.A. Zimnyaya richiama l'attenzione sul fatto che la comunicazione pedagogica "come forma di cooperazione educativa è una condizione per ottimizzare l'apprendimento e sviluppare la personalità degli studenti stessi".
La comunicazione pedagogica è la principale forma di attuazione del processo pedagogico. La sua produttività è determinata, prima di tutto, dagli obiettivi e dai valori della comunicazione, che devono essere accettati da tutti i soggetti del processo pedagogico come un imperativo del loro comportamento individuale. È possibile individuare i corrispondenti livelli di comunicazione pedagogica (Fig. 5).
L'obiettivo principale della comunicazione pedagogica è sia il trasferimento del pubblico che esperienza professionale(conoscenze, abilità) dall'insegnante agli studenti, e nello scambio di significati personali associati agli oggetti studiati e alla vita in generale (Fig. 6). Nella comunicazione avviene la formazione (cioè l'emergere di nuove proprietà e qualità) dell'individualità sia degli studenti che degli insegnanti (Cialdini R., 2001; vedi nota).
Oltre alla funzione informativa, se ne possono distinguere molte altre, ad esempio:
contatto - stabilire un contatto come stato di disponibilità reciproca per la ricezione e la trasmissione informazioni educative e mantenere la relazione sotto forma di costante orientamento reciproco;
incentivo - stimolazione dell'attività dello studente, indirizzandolo a eseguire determinati attività didattiche;
amotivo - inducendo le necessarie esperienze emotive nello studente ("scambio di emozioni"), nonché modificando le proprie esperienze e stati con il suo aiuto, ecc.
La comunicazione pedagogica crea le condizioni per la realizzazione delle potenziali forze essenziali dei soggetti del processo pedagogico.
Il valore più alto della comunicazione pedagogica è l'individualità dell'insegnante e dello studente. La dignità e l'onore dell'insegnante, la dignità e l'onore degli studenti sono il valore più importante della comunicazione pedagogica.
In relazione a ciò, il principio guida della comunicazione pedagogica può essere accettato dall'imperativo di I. Kant: tratta sempre te stesso e gli studenti come obiettivi della comunicazione, a seguito della quale c'è un'ascesa all'individualità. Un imperativo è un requisito incondizionato. È questa ascesa all'individualità nel processo di comunicazione che è espressione dell'onore e della dignità dei soggetti della comunicazione.
La comunicazione pedagogica dovrebbe concentrarsi non solo sulla dignità umana come valore più importante della comunicazione. Di grande importanza per la comunicazione produttiva sono valori etici come l'onestà, la franchezza, il disinteresse, la fiducia, la misericordia, la gratitudine, la cura, la lealtà alla parola.
La specificità della comunicazione pedagogica, prima di tutto, si manifesta nel suo orientamento. È rivolto non solo all'interazione stessa e agli studenti ai fini del loro sviluppo personale, ma anche, che è la cosa principale per il sistema pedagogico stesso, a organizzare lo sviluppo delle conoscenze educative e la formazione delle abilità su questa base . Per questo motivo, la comunicazione pedagogica è caratterizzata, per così dire, da una triplice attenzione: sull'interazione educativa stessa, sugli studenti (i loro stato attuale, promettenti linee di sviluppo) e sul tema dello sviluppo (assimilazione) (Ershov P.M., 1998; vedi abstract).
Allo stesso tempo, la comunicazione pedagogica è determinata anche da una triplice attenzione ai temi: personale, sociale e tematica. Ciò è dovuto al fatto che l'insegnante, lavorando con uno studente sullo sviluppo di qualsiasi materiale didattico, orienta sempre il suo risultato a tutti i presenti in classe, ad es. colpisce frontalmente ogni studente. Pertanto, possiamo presumere che l'originalità della comunicazione pedagogica, rivelata nella totalità di queste caratteristiche, si esprima anche nel fatto che combina organicamente elementi di comunicazione orientata alla personalità, orientata al sociale e orientata al soggetto (Mitina L.M., 1996; vedi estratto).
La qualità della comunicazione pedagogica è determinata, anzitutto, dal fatto che essa attua una specifica funzione didattica, che include l'educazione. Dopo tutto, il punto di partenza per l'organizzazione di un processo educativo ottimale è la natura che nutre e sviluppa l'apprendimento. La funzione di apprendimento può essere correlata con la funzione traduttiva della comunicazione, secondo A.A. Brudny, ma solo in termini generali. La funzione didattica della comunicazione pedagogica è quella principale, ma non è autosufficiente, è una parte naturale dell'interazione multilaterale dell'insegnante - studenti, studenti tra di loro.
Klimov E.A. La comunicazione pedagogica riflette le specificità della natura dell'interazione umana, descritta dallo schema "uomo - uomo" (secondo E.A. Klimov).
Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di questo gruppo di professioni vi sono le seguenti:
La capacità di guidare, insegnare, educare, "compiere azioni utili per servire i vari bisogni delle persone".
La capacità di ascoltare e ascoltare.
Prospettiva ampia.
Cultura della parola (comunicativa).
"L'orientamento spirituale della mente, l'osservazione alle manifestazioni dei sentimenti, della mente e del carattere di una persona, al suo comportamento, la capacità e la capacità di rappresentare mentalmente, modellare precisamente il suo mondo interiore e non attribuirgli il proprio o un altro, familiare per esperienza».
"Un approccio progettuale a una persona basato sulla convinzione che una persona possa sempre migliorare".
La capacità di entrare in empatia.
Osservazione, ecc. (Klimov E.A., 1995, p. 224).
14.2.3. Modelli di comunicazione pedagogica
La comunicazione è un processo di sviluppo e formazione di relazioni tra soggetti che sono attivamente coinvolti nel dialogo. Il discorso dell'insegnante è lo strumento principale che gli consente di presentare agli studenti i suoi modi di pensare.
Se consideriamo la comunicazione come un processo trasversale nell'apprendimento, allora è necessario distinguere due principali modelli di comunicazione:
educativo e disciplinare;
orientato alla personalità.
Makarenko A.S.
1. Modello educativo e disciplinare della comunicazione. Ha preso forma nel nostro Paese nel corso di decenni e porta l'impronta della seconda metà degli anni '70. del secolo scorso, quando l'obiettivo dell'istruzione era fornire agli studenti conoscenze, abilità e abilità. Lo slogan durante l'interazione di un adulto con i bambini era "Fai come me". Il modello di comunicazione in esame è caratterizzato da uno stile comunicativo autoritario (Fig. 7; Fig. 8), dove:
Metodi di comunicazione: istruzioni, spiegazioni, divieti, richieste, minacce, punizioni, annotazioni, grida.
Tattiche di comunicazione: dettame o tutela.
Posizione personale: soddisfare i requisiti delle autorità di gestione e di vigilanza.
Come risultato di questo modello di comunicazione, c'è un effetto dannoso sulla personalità del bambino. Un'alternativa a questo modello è il modello di comunicazione orientato alla personalità (vedi sotto).
Tradizionalmente, la formazione e l'istruzione erano considerate processi diretti a senso unico, il cui meccanismo era la trasmissione di informazioni educative dal suo portatore - l'insegnante al destinatario - lo studente. Il processo pedagogico, costruito sulla base di tali idee, in condizioni moderne mostra una bassa efficienza. Lo studente, in quanto partecipante passivo di questo processo, è solo in grado di assimilare (di fatto, ricordare) le informazioni limitate che gli vengono fornite in già pronto. Non sviluppa la capacità di padroneggiare in modo indipendente nuova informazione, usalo in condizioni e combinazioni non standard, trova nuovi dati basati su quelli già appresi. Un processo educativo orientato unilateralmente praticamente non raggiunge l'obiettivo principale dell'educazione: la formazione di una persona matura, indipendente, responsabile, capace di compiere passi adeguati in condizioni contraddittorie e mutevoli. mondo moderno. Una personalità sotto l'influenza dell'influenza direttiva autoritaria acquisisce le caratteristiche di dipendenza, conformità (Antsupov A.Ya., 1996).
2. Modello di comunicazione orientato alla persona. Lo scopo di un modello di comunicazione orientato alla personalità è fornire a un bambino un senso di sicurezza psicologica, la sua fiducia nel mondo, la gioia dell'esistenza, la formazione dell'inizio di una personalità, lo sviluppo dell'individualità di un bambino. Questo modello di comunicazione è caratterizzato da un tipo di comunicazione dialogico (Fig. 8) (Pavlova L.G., 1991; vedi annotazione).
Questo modello di comunicazione è caratterizzato dal fatto che un adulto interagisce con un bambino nel processo di comunicazione (Sinagina N.Yu. et al., 2001; vedi abstract). Non forza lo sviluppo dei bambini, ma impedisce il verificarsi di possibili deviazioni nello sviluppo personale dei bambini. La formazione di conoscenze, abilità e abilità non è un obiettivo, ma un mezzo per il pieno sviluppo dell'individuo.
Modalità di comunicazione: comprensione, riconoscimento e accettazione della personalità del bambino, basate sulla capacità di decentramento che si sta formando negli adulti (la capacità di assumere la posizione di un altro, tenere conto del punto di vista del bambino e non ignorare i suoi sentimenti ed emozioni).
Tattiche di comunicazione: cooperazione, creazione e utilizzo di situazioni che richiedono la manifestazione dell'attività intellettuale e morale dei bambini.
La posizione personale dell'insegnante: procedi dagli interessi del bambino e dalle prospettive del suo ulteriore sviluppo.
A questo proposito, nella scienza e nella pratica moderne, il concetto di processo pedagogico come dialogo, che prevede l'interazione mutuamente diretta e condizionata dei partecipanti a questo processo, nonché metodi di discussione di gruppo, sta diventando sempre più riconosciuto (Fig. 9 , animazione). (Kurganov S.Yu., 1989; vedi abstract). A questo proposito, la comunicazione pedagogica funge da meccanismo principale per raggiungere gli obiettivi principali della formazione e dell'istruzione.
Tradizionalmente, nella comunicazione si distinguono tre funzioni interconnesse: comunicativa (scambio di informazioni), percettiva (percezione e conoscenza reciproca da parte delle persone), interattiva (organizzazione e regolazione delle attività congiunte). Queste funzioni della comunicazione nell'attività pedagogica si realizzano nell'unità. Ogni persona svolge molte funzioni: ufficiale (capo, subordinato, studente, medico, insegnante, ecc.), Famiglia (madre, padre, marito, moglie, sorella, ecc.).
Va sottolineato che l'attuazione delle funzioni di comunicazione designate è in gran parte determinata dagli atteggiamenti morali ed etici dell'insegnante - come l'umanesimo, un approccio ottimista all'individuo, il riconoscimento della sua originalità.
La comunicazione pedagogica è, prima di tutto, comunicazione: trasferimento di informazioni, scambio di informazioni tra i partecipanti al processo pedagogico. L'informazione accompagna tutte le azioni dell'insegnante. Lo scambio di informazioni è l'aspetto più difficile, soprattutto per un insegnante alle prime armi, dell'attività pedagogica. L'efficacia della comunicazione dipende da molte condizioni. È importante, prima di tutto, fornire una motivazione positiva nel trasferimento delle informazioni, nella loro comprensione e accettazione da parte degli alunni. È importante attirare l'attenzione, suscitare interesse per il tema della comunicazione.
A tal fine, in classe, gli insegnanti utilizzano fatti divertenti, situazioni problematiche, brani di narrativa, letteratura scientifica popolare, riferimenti storici e offrono frammenti di filmati video.
Come ha scritto G. I. Shchukina, “attraverso il prisma dell'attività linguistica, si può rintracciare lo stile e la natura della comunicazione, l'atteggiamento personale dell'insegnante nei confronti delle questioni e dei problemi in esame. Nell'attività linguistica si manifestano erudizione, abilità pedagogiche, la capacità di un insegnante di costruire i propri contatti con gli studenti.
V. A. Sukhomlinsky ha sostenuto che la parola di un insegnante è il suo mezzo professionale, "uno strumento indispensabile per influenzare l'anima di un allievo".
Consideriamo le caratteristiche generali della comunicazione per caratterizzare ulteriormente la comunicazione pedagogica tra l'insegnante e gli studenti (insegnante e studenti) da queste posizioni.
Il lato formale del processo di comunicazione vocale può essere caratterizzato sulla base della tipologia del comportamento vocale (discorso) descritto da A. A. Kholodovich. Ha proposto cinque caratteristiche binarie per identificare un atto linguistico:
1) mezzi di espressione;
2) comunicazione;
3) orientamento;
4) quantificazione;
5) contatto.
Quindi, sulla base dei "mezzi di espressione" la comunicazione può essere sonora o scritta. Con il segno di "comunicatività" l'autore rileva la presenza o l'assenza di un interlocutore e, in caso di presenza, la comunicazione diretta (ad esempio, dialogo) o indiretta - tramite un intermediario, tramite un terzo (ad esempio, traduzione) . "Orientamento" significa sia transitività (uno parla, l'altro (gli altri) ascolta), sia reciprocità (due interlocutori parlano e ascoltano alternativamente). La quantificazione determina il numero di ascoltatori (uno - molti) e la natura della parte ricevente. Il segno di "contatto" segna la presenza o l'assenza dell'interlocutore nel campo visivo.
In base alla combinazione di queste caratteristiche, sono teoricamente possibili 32 tipi di comunicazione vocale. In base a questo concetto, la comunicazione pedagogica può essere caratterizzata principalmente come solida, diretta, di contatto, transitoria (che dovrebbe essere reciproca), di massa.
Definendo la comunicazione come il processo di stabilire e mantenere intenzionale, diretto o mediato da uno o un altro mezzo di contatto tra le persone, in un modo o nell'altro psicologicamente connesse tra loro, A. A. Leontiev identifica le seguenti caratteristiche:
1) contatto;
2) orientamento;
4) semiotico;
5) specializzazione;
6) le dinamiche psicologiche del processo.
Nell'ultima edizione, sono definiti da A. A. Leontiev come specializzazione semiotica e grado di mediazione, orientamento della comunicazione e dinamica psicologica. Allo stesso tempo, riempie alcune delle caratteristiche precedentemente citate con nuovi contenuti. Si nota così la duplice natura dell'orientamento: cambiare le caratteristiche dell'interazione delle persone e cambiare se stesse. Nel determinare l'orientamento, si nota non solo la direzione dello scambio di informazioni, ma anche la natura sociale o personale della direzione dell'orientamento stesso. Su questa base, A. A. Leontiev, B. Kh. Bgazhnokov distinguono due tipi di comunicazione: orientata alla personalità e orientata alla società. Differiscono nella struttura comunicativa, funzionale, socio-psicologica e linguistica. Le affermazioni nella comunicazione socialmente orientata sono rivolte a molte persone e dovrebbero essere comprese da tutti. Pertanto, sono soggetti ai requisiti di completezza, diffusione, trasparenza, accuratezza e alta cultura. Il contenuto della specializzazione semiotica della comunicazione sottolinea l'importanza di combinare tutti i mezzi: verbali e non verbali - per aumentare l'efficacia dell'impatto del discorso. Il contatto è considerato in base al grado di convergenza nel tempo e nello spazio del messaggio parlato e della sua percezione. Una caratteristica importante della comunicazione è la sua dinamica psicologica, determinata dalle caratteristiche dell'impatto delle informazioni verbali.
A seconda del grado e della natura dell'impatto delle informazioni verbali sulla psiche umana, ci sono: comunicazione, persuasione e suggestione. Secondo queste caratteristiche, seguendo A. A. Leontiev, si può definire, ad esempio, una conferenza come socialmente orientato comunicazione con diverse dinamiche psicologiche (ma che coinvolgono principalmente la persuasione e l'informazione), avvicinandosi alla comunicazione interpersonale (conversazione) in termini di natura dei mezzi utilizzati in essa e in termini di mediazione sociale.
Aggiungiamo a quanto detto altre due caratteristiche della comunicazione: la rappresentatività e la multi-informatività. La rappresentatività è la rappresentazione soggettiva del parlante (insegnante o studente) nel testo, la poliinformativa è la versatilità della comunicazione vocale, dove tutte le sue caratteristiche (contenuto, espressività, impatto) si realizzano simultaneamente, si riflettono diversi livelli (soggetto, semantica, ecc. .).
La natura sociale della rappresentatività è determinata dal fatto che non esiste una comunicazione inutile tra le persone, è sempre significativa, storicamente specifica e può esistere solo in un'occasione specifica, in determinate forme. attività sociali e relazioni - industriali, tecniche, economiche, politiche, morali, ecc. Queste attività influenzano la comunicazione e si riflettono in essa. La rappresentatività implica che qualsiasi comunicazione rispecchi le caratteristiche individuali e personali di chi comunica, ad esempio un docente (insegnante) e gli studenti (studenti), il loro livello culturale, età, genere, nonché interessi, bisogni, gusti, inclinazioni, ecc. . Di particolare importanza è l'analisi della comunicazione verbale, delle sue forme principali, del prodotto della comunicazione - un testo che consente di rivelare quelle relazioni sociali e sociali in cui sono incluse le persone che realizzano questa comunicazione, le loro caratteristiche personali.
Una caratteristica altrettanto importante della comunicazione verbale è la poliinformativa. Sta nel fatto che il messaggio vocale trasmesso nel processo di comunicazione verbale ha un contenuto comunicativo e soggettivo complesso, che è un'unità del contenuto effettivo, dei piani espressivi e di incentivazione dell'enunciato. Naturalmente ognuno di essi può essere espresso più o meno esplicitamente, ma la loro unità interna determina la poliinformativa della comunicazione verbale (discorso) nell'attività sociale e comunicativa delle persone. Pertanto, la comunicazione verbale (verbale) è descritta da almeno sette caratteristiche: contatto, orientamento, orientamento, specializzazione semiotica, dinamica, rappresentatività, poliinformativa.
A seconda dello scopo, il discorso può essere divertente, dove la cosa principale è l'intrattenimento, l'interesse, mantenere l'attenzione; informativo - dà una nuova idea sull'argomento; stimolante, rivolto ai sentimenti, alle emozioni di una persona; persuasivo - coinvolge argomenti logici per provare o smentire qualsiasi posizione; chiamata all'azione.
Nella comunicazione pedagogica è "presente" l'intera varietà di tipi di discorso, ma indipendentemente dal fatto che convinca, informi, se l'insegnante chiama gli alunni, al suo discorso vengono imposti requisiti speciali:
1) correttezza (rispetto delle norme letterarie e linguistiche);
2) accuratezza (uso di parole, espressioni nei loro significati caratteristici);
3) chiarezza, semplicità, coerenza, accessibilità;
4) ricchezza (varietà dei mezzi linguistici utilizzati);
5) figuratività, emotività.
Per usare abilmente la parola, l'insegnante deve porsi queste domande: come dirlo correttamente, come dirlo in modo accessibile, come dirlo in modo convincente, come dirlo emotivamente.
Nella comunicazione è importante non solo ciò che viene detto, ma anche come viene detto. Parlare magnificamente insegna una scienza speciale: la retorica. Non solo rivela modi per trasmettere magnificamente informazioni, ma delinea chiaramente le regole che trasformano la parola in un mezzo per influenzare altre persone.
Il discorso esprime l'atteggiamento dell'insegnante nei confronti del contenuto delle informazioni e di colui con cui comunica, cioè l'espressività emotiva del discorso è importante: intonazione, tempo, dizione, forza, pause.
A. S. Makarenko credeva che si potesse diventare un maestro solo quando si impara a pronunciare le parole "vieni qui" con 15-20 sfumature di intonazione. L'intonazione conferisce al discorso dell'insegnante una colorazione emotiva. "Le persone non sono offese dal significato, ma dall'intonazione, perché l'intonazione rivela un significato diverso, nascosto e principale", osserva Y. Trifonov. Con l'intonazione è possibile focalizzare l'attenzione degli alunni, evidenziare singole parole ed espressioni, sottolineare l'importanza del compito, esprimere un atteggiamento positivo o negativo nei confronti delle informazioni presentate, del risultato dell'attività, esprimere sorpresa, gioia, dubbio.
Integrare il discorso, influenzare emotivamente gli alunni, trasmettere i sentimenti e le esperienze dell'insegnante mezzi non verbali. KS Stanislavsky ha sostenuto che le persone comunicano con l'aiuto dei loro cinque sensi: occhi, espressioni facciali, voce, movimenti delle mani e delle dita, nonché attraverso la radiazione e la percezione delle radiazioni.
Questi mezzi senza parole sono chiamati il linguaggio emozionale della comunicazione. Quanto è importante per molti studenti quando durante la lezione, quando rispondono a una domanda difficile, l'insegnante li sostiene annuendo con la testa, mettendo un bel voto, sorridendo. E come non solo rispondere, per ottenere anche un buon voto dall'insegnante, una persona il cui aspetto non esprime nulla.
Pertanto, la cultura della comunicazione si ottiene attraverso mezzi sia verbali che non verbali.
Affinché si crei un'interazione dialogica tra l'insegnante e l'alunno in una situazione di domanda, si propone di soddisfare le seguenti condizioni:
1) se fai una domanda, attendi che il tuo interlocutore risponda;
2) se esprimi il tuo punto di vista, incoraggia lo studente a esprimere il suo atteggiamento nei suoi confronti;
3) se non sei d'accordo, formula argomenti e incoraggia lo studente a cercarli;
4) pausa durante la conversazione. Non catturare l'intero "spazio di comunicazione";
5) guarda più spesso in faccia lo studente, il tuo interlocutore;
6) ripeti più spesso le frasi: “Cosa ne pensi?”, “Mi interessa la tua opinione”, “Perché taci?”, “Non sei d'accordo con me? Perché?", "Dimostrami che mi sbaglio".
Secondo R. K. Werderber, la capacità di sollevare una domanda, esprimere emotivamente i propri pensieri è un aspetto importante della comunicazione, ma l'altro lato non è meno significativo per un insegnante: la capacità di ascoltare.
Il meccanismo di conoscenza e comprensione dell'identità personale dell'alunno è l'empatia pedagogica. Secondo la definizione di I. S. Sergeev, "L'empatia è la comprensione degli stati emotivi di un'altra persona sotto forma di empatia e simpatia". Quindi, possiamo dire che l'empatia pedagogica si manifesta nella capacità dell'educatore di mettersi mentalmente al posto dell'alunno, di essere intriso del suo stato mentale, di comprendere, di entrare in empatia. Ma questo è possibile se l'insegnante conosce e comprende bene se stesso, è in grado di analizzare oggettivamente i suoi pensieri, esperienze, azioni, rapporti con le persone, cioè se ha sviluppato la riflessione.
Un insegnante che possiede la riflessione e percepisce empaticamente, comprende e valuta correttamente l'alunno può prevedere con successo, correggere le relazioni educative ed educative e gestirle.
I mezzi di comunicazione comprendono:
1) lingua - un sistema di parole, espressioni e regole per la loro combinazione in dichiarazioni significative utilizzate per la comunicazione. Le parole e le regole per il loro uso sono le stesse per tutti i parlanti di una data lingua, e questo rende possibile la comunicazione usando la lingua. Se dico "tavolo", sono sicuro che qualcuno dei miei interlocutori collega lo stesso concetto a questa parola come faccio io - questo è un obiettivo significato sociale le parole possono essere chiamate un segno della lingua. Ma il significato oggettivo della parola è rifratto per una persona attraverso il prisma della propria attività e forma già il suo significato personale, "soggettivo", quindi non sempre ci capiamo correttamente.
2) intonazione, espressività emotiva, capace di dare significati diversi alla stessa frase.
3) le espressioni facciali, la postura, lo sguardo dell'interlocutore possono esaltare, integrare o smentire il significato della frase.
4) i gesti come mezzo di comunicazione possono essere entrambi generalmente accettati, ad es. hanno significati loro assegnati, o espressivi, ad es. servono ad aumentare l'espressività della parola.
5) la distanza alla quale gli interlocutori comunicano dipende dalle tradizioni culturali, nazionali, dal grado di fiducia nell'interlocutore.
Pertanto, l'efficacia della comunicazione dipende da molte condizioni. È importante, prima di tutto, fornire una motivazione positiva nel trasferimento delle informazioni, nella loro comprensione e accettazione da parte degli alunni. È importante attirare l'attenzione, suscitare interesse per il tema della comunicazione. E il ruolo principale è dato direttamente all'insegnante.
INTRODUZIONE.. 2
Capitolo 1. Caratteristiche della comunicazione pedagogica. 5
1.1. Analisi della letteratura psicologica e pedagogica sul problema della comunicazione pedagogica. 5
1.2. Gli obiettivi della comunicazione pedagogica. 8
1.3. Funzioni della comunicazione pedagogica. 12
1.5. Mezzi di comunicazione pedagogica. 22
1.6. La struttura della comunicazione pedagogica. 27
Capitolo 2. Stile di comunicazione pedagogica e. 34
i suoi tipi.. 34
2.1. Il concetto di stile della comunicazione pedagogica. 34
2.2. Tipi di stili di comunicazione pedagogica. 35
Capitolo 3. Identificazione degli stili di comunicazione pedagogica tra gli insegnanti di materia. 45
CONCLUSIONI... 55
CONCLUSIONE.. 57
LETTERATURA.. 59
Istruzione: 61
Questionario per l'insegnante per analizzare le caratteristiche dello stile individuale della sua attività pedagogica. 65
INTRODUZIONE
Lavoro, conoscenza, comunicazione... Gli ambiti più importanti della vita umana. Ne parliamo spesso, le analizziamo… Antoine de Saint-Exupery definiva la comunicazione umana il più grande lusso del mondo. Ma in un caso è un "lusso", e nell'altro una necessità professionale. Dopotutto, alcuni tipi di lavoro umano sono semplicemente impossibili senza comunicazione. Questo tipo di attività è il lavoro di un insegnante. La struttura del lavoro pedagogico, secondo gli psicologi, ha più di 200 componenti, ma uno dei suoi aspetti più difficili è la comunicazione, quando c'è un impatto della personalità sulla personalità.
Prima o poi, davanti a ogni studente di un'università pedagogica, il problema dell'interazione con coloro per i quali padroneggia il programma del suo allenamento Vocale- con i loro studenti e allievi. L'esperienza mostra che le conoscenze e le abilità acquisite durante gli anni di studio all'università saranno richieste dal futuro specialista come una sorta di strumento per insegnare ai propri studenti e familiarizzarli con le origini della cultura universale.
Di conseguenza, sia il contenuto delle materie che costituiscono il nucleo delle qualifiche dell'insegnante sia i metodi particolari di insegnarle sono necessari al futuro specialista per entrare in contatto con i suoi studenti, influenzare i motivi del loro insegnamento e interessare gli studenti a la materia insegnata e nella propria personalità. Senza questo, il processo di apprendimento sarà di natura formale, impersonale e non porterà soddisfazione né all'insegnante stesso, né ai suoi studenti, né alla società nel suo insieme.
La comunicazione nell'insegnamento è molto importante. A volte è la complessità della comunicazione che determina il nostro atteggiamento nei confronti del lavoro pedagogico e l'atteggiamento degli studenti nei confronti degli insegnanti. La scuola è quella fase della vita di ogni persona, dopo la quale deve decidere chi sarà. Naturalmente, il processo educativo a scuola porta il laureato a scelta professionale. Tuttavia, questa scelta fa sempre riflettere una persona su ciò che sarà e, inoltre, su ciò che già è? Com'era durante tutti i suoi anni scolastici, come diventa alla fine della scuola - tutto ciò influisce in modo significativo sulla sua scelta morale, sulle aspettative sociali. E per soddisfare queste aspettative, l'insegnante, fin dai primi passi della sua comunicazione con gli alunni, insegna loro a sentire in se stessi un senso edificante della dignità umana. E se non tutti i laureati riescono a mantenerlo e ad agire in conformità con esso, allora c'è una parte della colpa dell'insegnante in questo. Quando si verifica? Con il primo grido? Con uno sguardo indifferente, disattenzione allo studente?
Già 20 anni fa, la scienza psicologica e pedagogica ha dimostrato in modo convincente che affinché l'educazione sia efficace, è necessario evocare nel bambino un atteggiamento positivo nei confronti di ciò che vogliamo educare in lui. E questo o quell'atteggiamento si forma sempre nell'attività, attraverso il meccanismo più complesso delle relazioni, la comunicazione.
La comunicazione pedagogica ha una certa struttura, specificità e tecnologia di implementazione, che a volte gli insegnanti padroneggiano spontaneamente. Ma possiamo dire con sicurezza che è necessario e necessario imparare la comunicazione pedagogica. È nel lavoro poco appariscente e scrupoloso di conoscere se stessi nella comunicazione con i bambini, padroneggiando le basi della comunicazione pedagogica che si forma l'individualità creativa dell'insegnante.
La rilevanza del tema oggetto di studio è determinata dalla necessità di studiare gli stili degli insegnanti di materia e la loro influenza sulla relazione con gli studenti della classe di laurea (grado 11) al fine di fornire raccomandazioni sull'ottimizzazione dello stile delle relazioni e sull'assestamento situazioni di conflitto con gli studenti della terza media.
L'oggetto dello studio è lo stile di comunicazione pedagogica degli insegnanti di materie che insegnano nell'11 ° grado.
L'oggetto dello studio sono le manifestazioni oggettive dello stile di comunicazione pedagogica degli insegnanti delle materie e le raccomandazioni per la sua ottimizzazione.
Lo scopo del lavoro del corso era analizzare gli stili della comunicazione pedagogica al fine di determinare le linee guida psicologiche e pedagogiche per lo sviluppo di raccomandazioni per ottimizzare lo stile della comunicazione pedagogica degli insegnanti che ne hanno bisogno.
IN aspetto teorico l'obiettivo era selezionare la letteratura psicologica e pedagogica sull'argomento. In termini pratici, il nostro studio è stato finalizzato all'individuazione di linee guida per dare consigli sull'ottimizzazione dello stile di comunicazione pedagogica degli insegnanti che hanno problemi nel rapporto con gli studenti. La parte pratica è stata svolta sulla base degli insegnanti di materia della scuola secondaria n. 1.
Gli obiettivi della ricerca:
Condurre un'analisi teorica del problema della comunicazione pedagogica, della sua struttura, funzioni, obiettivi, contenuti e mezzi.
Rivelare il concetto di stile della comunicazione pedagogica, le sue caratteristiche e tipi.
Determinare il rapporto quantitativo tra stili costruttivi e non costruttivi di comunicazione pedagogica degli insegnanti e fornire raccomandazioni per ottimizzare gli stili non costruttivi di comunicazione pedagogica al fine di fermare le situazioni di conflitto che si presentano nell'undicesimo grado.
Capitolo 1. Caratteristiche della comunicazione pedagogica
1.1. Analisi della letteratura psicologica e pedagogica sul problema della comunicazione pedagogica
La comunicazione è lo strumento professionale più importante dell'attività pedagogica. Ricerca di A.A. Bodaleva, N.V. Kuzmina, VA Kann - Kalika, A.A. Leontyev, A.N. Mudrik, A. E Shcherbakov e altri hanno dimostrato Grande importanza comunicazione nel lavoro di un insegnante.
Secondo A.A. Lobanova, "comunicazione" come concetto quotidiano e "comunicazione" come concetto psicologico e pedagogico non coincidono nel loro significato, il che complica in una certa misura lo studio di questo fenomeno.
La comunicazione pedagogica è una comunicazione professionale di un insegnante con gli studenti in classe e al di fuori di essa, volta a creare un clima psicologico favorevole (Leontiev A.A. Comunicazione pedagogica. - P.3). Una comunicazione pedagogica errata provoca paura, incertezza, indebolimento dell'attenzione, memoria, prestazioni, dinamiche del linguaggio compromesse e, di conseguenza, la comparsa di dichiarazioni stereotipate degli scolari, perché hanno un desiderio e una capacità ridotti di pensare in modo indipendente e conformità in comportamento aumenta. Alla fine nasce un atteggiamento negativo stabile nei confronti dell'insegnante, e quindi della materia.
AA. Leontiev credeva che la comunicazione tra un insegnante e gli studenti dovesse provocare la gioia della comprensione, la sete di attività e contribuire all'ottimizzazione del processo educativo.
Le richieste di relazioni cameratesche nella scuola sovietica sorsero fin dai primi giorni del suo inizio. Famosi insegnanti dell'epoca lo sostenevano: N.K. Krupskaja, S.T. Shatsky, A.V. Lunacharsky, P.P. Blonsky, credendo che la cooperazione collettiva sia la base della comunicazione tra insegnante e studenti.
Ma, forse, questo problema preoccupava A.S. più di altri. Makarenko e V.S. Sukhomlinsky. Sulla base dell'orientamento umano della scuola, A.S. Makarenko è giunto alla conclusione che la cosa principale nella comunicazione tra insegnanti e studenti dovrebbero essere le relazioni basate sul rispetto e l'esattezza. Considerava l'abilità pedagogica come l'arte di influenzare l'allievo, costringendolo a sperimentare e realizzare la necessità di un certo comportamento.
Molti saggi consigli sulla comunicazione pedagogica sono stati dati da V.A. Sukhomlinsky. Sottolineando che l'educazione con una parola è il luogo più debole e vulnerabile della scuola sovietica, ha chiesto all'insegnante di padroneggiarla: "... ogni parola pronunciata tra le mura della scuola deve essere premurosa, saggia, propositiva, corposa ...". V.A. Sukhomlinsky ha condannato in particolare il grido dell'insegnante, considerandolo un inutile strumento educativo.
Le opere di molti insegnanti sovietici, come: Sh.A. Amonashvili, I.P. Volkov, T. e Goncharova, E.I. Ilyina, S.N. Lysenkova, V.F. Shatolova, M.P. Shchetinin e altri, è stato dimostrato che l'apprendimento efficace è possibile solo sulle posizioni della pedagogia della cooperazione. Dicono tutti: l'insegnante va incontro ai bambini, sta dal punto di vista del bambino, come su una pedana da cui conduce.
Il concetto di "comunicazione pedagogica" è diventato oggetto di speciali ricerche scientifiche e pedagogiche relativamente di recente - negli anni '70 -'80 del XX secolo.
Il problema dello studio della struttura della comunicazione pedagogica è stato affrontato da N.S. Trubetskoy, A. Gardiner, R.O. Yakobson, VA Artemov, Ya Yanoushek e altri.
In una serie di opere (A.V. Belsky, V.A. Artemov, L.D. Revtova, V.I. Kadomtsev, ecc.), Sono stati fatti tentativi per classificare l'intera varietà di azioni vocali (compiti vocali). Lo studio delle unità funzionali della comunicazione pedagogica è stato condotto da M.I. Lisina, LA Hareva, TS Putilovskaya, A.K. Markova, TA Stezhko, L.N. Nikipelova.
Inoltre, nell'attività pedagogica, le difficoltà o le difficoltà nell'interazione tra insegnante e studenti vengono indagate in modo abbastanza attivo al fine di determinare i fattori che influenzano le difficoltà, le cause che le causano, ecc. (N.V. Kuzmina, A.N. Leontiev, A.K. Markova, V.A. Kann-Kalik, E.V. Tsukanova, V.V. Ryzhov, L.A. Povarnitsyna, ecc.).
Vediamo così che il problema dello studio di vari aspetti della comunicazione pedagogica trova la sua ampia distribuzione nelle opere di un'intera galassia di insegnanti del XX secolo.
1.2. Gli obiettivi della comunicazione pedagogica
Di norma, una persona entra in interazione con i suoi partner per motivi di comunicazione.
Secondo gli obiettivi, la comunicazione può essere suddivisa in biologica e sociale secondo i bisogni che serve (RS Nemov).
La comunicazione biologica ha lo scopo di soddisfare i bisogni biologici, mantenere, preservare e sviluppare il corpo umano.
La comunicazione sociale è finalizzata a soddisfare bisogni cognitivi, creativi, estetici, morali e altri bisogni puramente umani. Ha lo scopo di ampliare e rafforzare i contatti interpersonali, di stabilire relazioni con le persone e i gruppi sociali circostanti, di risolvere i problemi di formazione, istruzione e crescita personale dell'individuo.
Per le persone è particolarmente importante la comunicazione sociale, perché per loro è alto il significato dell'aspetto puramente umano dell'interazione, la componente umana diretta di tutti i contatti tra di loro, senza la quale una persona si svilupperà solo come essere biologico.
Ad esempio, la colazione, il pranzo o la cena non sono per ognuno di noi solo un modo per soddisfare il naturale bisogno biologico di cibo. Ci sforziamo di accompagnare il pasto con una bella portata, ci prendiamo cura del design estetico di ogni piatto, nonché delle condizioni igieniche e dell'ambiente in cui dobbiamo mangiare. La stessa procedura del mangiare viene spesso eseguita non da soli, ma nella cerchia di parenti o amici.
Allo stesso tempo, le conversazioni con gli altri diventano attributi importanti e integranti del pasto e talvolta svolgono un ruolo più importante del cibo stesso. Non è un caso che a volte possiamo rifiutare il cibo, proprio per non sederci alla stessa tavola con un partner per noi indesiderato.
L'essenza della comunicazione umana, ovviamente, sta nel fatto che anche con la soddisfazione dei bisogni biologici elementari, rimane una persona, ad es. prendersi cura anche dell'incarnazione di bisogni estetici, morali e altri bisogni puramente umani. Ma per questo è necessario garantire la formazione e lo sviluppo di tali bisogni sia nei bambini che negli adulti, il che significa che è necessario risolvere i problemi dell'educazione dei bisogni umani ragionevoli.
L'insegnante interagisce con i suoi colleghi, gli alunni ei loro genitori, altre persone a lui legate attività professionale. Questo è lo scopo della comunicazione professionale e pedagogica. Ovviamente, questi obiettivi sono principalmente dovuti agli obiettivi e agli obiettivi generali che devono affrontare il sistema educativo della nostra società, le sue principali linee guida.
Per diversi decenni di esistenza della scuola sovietica, l'intero sistema educativo aveva un carattere statale chiaramente espresso e mirava a soddisfare un ordine sociale definito per un determinato periodo. Negli anni '20 - '30. l'eliminazione dell'analfabetismo e la lotta contro i bambini senza fissa dimora hanno agito come tale ordine sociale; negli anni '40 - '50. - formazione delle riserve di lavoro e dei difensori della Patria; negli anni '60 - '70. - introduzione dell'istruzione secondaria generale obbligatoria nel paese. La presenza di tali ordini è testimoniata dalle relative risoluzioni del Partito Comunista e del governo sovietico.
Per molto tempo la pedagogia tradizionale si è concentrata sulla preparazione educativa degli scolari, sul miglioramento del contenuto e degli aspetti metodologici del processo educativo. Uno dei compiti più importanti della scuola sovietica era quello di dotare gli studenti dei cosiddetti ZUN, ad es. conoscenze, abilità e abilità. Tutto medio scuole comprensive i paesi avevano una carta unica, erano obbligati a impegnarsi nello standard curriculum e un programma unificato del processo educativo. Il rispetto di questi requisiti obbligava tutti gli insegnanti a muoversi verso lo studio di una particolare materia in un unico ritmo.
Molta attenzione è stata prestata all'educazione degli scolari, che è stata svolta anche secondo i programmi e le raccomandazioni pertinenti inviati dall'alto. In questo caso, gli insegnanti avevano più margine di manovra nella scelta dei contenuti e delle forme di attività specifiche. Tuttavia, gli ideali di educazione, linee guida educative e spesso un elenco di attività obbligatorie, insieme a raccomandazioni per la loro attuazione, si sono formati ai piani superiori della piramide statale e si sono riflessi nelle relative pubblicazioni pedagogiche.
Le domande sullo sviluppo degli studenti non sono state respinte, ma non occupavano un posto prioritario, sembravano essere relegate in secondo piano. Si credeva che lo sviluppo della personalità dello studente avvenisse principalmente attraverso le informazioni che apprende, attraverso le abilità che acquisisce. Da ciò ne è seguito: per risolvere il problema di armare gli studenti di conoscenza, l'arsenale dell'insegnante dovrebbe essere dominato da metodi riproduttivi come la narrazione, la dimostrazione, l'esercizio, con l'aiuto del quale l'insegnante fornisce allo studente le "munizioni" necessarie , cioè. conoscenze, abilità e abilità.
L'interazione di un insegnante con i suoi allievi non può essere fine a se stessa. Prima di tutto, dovrebbe contribuire all'orientamento dell'alunno nel mondo dei valori, dovrebbe essere finalizzato ad aiutarlo nella costruzione del proprio sistema di valori.
Il valore per una persona è tutto ciò che ha un certo significato per lui, significato personale o sociale. Questi possono essere oggetti, fenomeni o loro proprietà che hanno un significato positivo per l'individuo, ad es. soddisfare i bisogni della persona emozioni positive. I valori giocano un ruolo molto importante nella vita di una persona: delineano e integrano la sua posizione rispetto a vari oggetti, lo aiutano a valutarne alcuni positivamente, altri - negativamente e riconoscere gli altri come particolarmente significativi per se stesso.
Quali valori possono essere discussi? Dopotutto, oggi, secondo le leggi vigenti, in istituzioni educativeè vietata la propaganda ideologica e politica di qualsiasi partito. Tuttavia, la depoliticizzazione e deideologizzazione dell'istruzione non significa affatto il rifiuto di alcun ideale. Per molti secoli del suo sviluppo, l'umanità ha accumulato parecchi valori che possono servire da linee guida sia nel lavoro educativo dell'insegnante che nel processo di autoeducazione degli scolari. Stiamo parlando di valori umani universali che sono stati sviluppati e selezionati nel corso della storia dello sviluppo delle civiltà umane, avendo resistito alla prova del tempo.
Va notato che il processo di orientamento dello studente a determinati valori non procede senza intoppi.
Da un lato, ogni persona inizialmente, dal momento della sua nascita, è nel mondo della cultura e ha la possibilità di interagire con essa. Fin dai primi anni della sua vita impara la lingua, conosce le opere musicali e arti visive, è legato a determinate regole di condotta, alle tradizioni e ai costumi esistenti nella società. Nelle sue attività, così come nelle sue azioni, pensieri ed esperienze, lo studente ha l'opportunità di fare affidamento su valori spirituali e morali universali, sull'esperienza accumulata di comunicazione e visione del mondo. La cultura è in grado di impostare ciascuno di noi un sistema di idee di valore, servire come base per impostare e implementare compiti cognitivi, pratici e personali.
Allo stesso tempo, la mera presenza di una persona all'interno di uno spazio culturale non gli garantisce l'appropriazione dell'esperienza culturale e dei valori culturali. Il sistema di valori di una persona non nasce da solo. Ad esempio, la presenza di libri in casa non sempre introduce alla lettura bambini e adulti. Allo stesso modo, la semplice presenza di uno studente in una lezione non sempre contribuisce alla sua conoscenza delle leggi della natura o dei fatti storici.
Il processo di accettazione e appropriazione dei valori, chiamato interiorizzazione, comprende una serie di fasi condizionali: conoscenza del valore; traduzione di informazioni su di esso nella propria lingua individuale; attività attiva del soggetto, a seguito della quale il valore percepito viene accettato o rifiutato; l'inclusione del valore conosciuto nel sistema di valori personalmente riconosciuto; cambiamento di personalità derivante dall'accettazione o dal rifiuto di un valore.
Se non ha luogo un incontro personale di uno studente con valore culturale, allora (valore culturale) rimarrà al di fuori dello studente e sarà per lui incomprensibile e non necessario. Di conseguenza, leggi elementari della natura, eventi storici, opere letterarie e artistiche e disposizioni di legge e valori morali della società.
In questo caso si possono stabilire pseudovalori, quando la responsabilità reciproca sostituisce l'amicizia, la guerra tra bande è l'unico vero modo per sistemare le cose e le relazioni sessuali vengono interpretate come amore.
1.3. Funzioni della comunicazione pedagogica
La comunicazione pedagogica svolge quasi tutte le funzioni principali implementate nella comunicazione non pedagogica quotidiana. Insieme a questo, le funzioni della comunicazione pedagogica hanno le loro caratteristiche distintive(AA Lobanov).
La funzione informativa consiste nel trasferimento attraverso la comunicazione di determinate informazioni di natura quotidiana, educativa, metodologica, di ricerca, di ricerca e di altra natura. L'attuazione di questa funzione contribuisce alla trasformazione dell'esperienza di vita accumulata, della conoscenza scientifica, assicura il processo di introduzione dell'individuo ai valori materiali e spirituali della società. Nel processo di apprendimento, l'insegnante appare agli studenti come una delle principali fonti di informazioni educative in un particolare campo della scienza, della letteratura, dell'arte o della pratica. Pertanto, la comunicazione con l'insegnante contribuisce alla trasformazione delle informazioni rilevanti per gli studenti.
In una scuola moderna ogni docente fa parte di una specifica associazione metodologica di docenti di materia, docenti di classe, educatori del gruppo diurno allargato. Parlando con i colleghi a seminari, conferenze, consigli pedagogici, l'insegnante li informa sulla sua comprensione dell'essenza del processo educativo, condivide la sua esperienza nell'uso di forme, metodi e tecniche specifici nel lavorare con gli studenti.
La funzione educativa della comunicazione professionale e pedagogica occupa o, almeno, dovrebbe occupare un posto centrale. Dopotutto, uno dei principali significati dell'interazione con un insegnante è contribuire alla familiarizzazione di una persona in crescita con il sistema di valori culturali e morali che si è sviluppato nella società, alla cultura della comunicazione con le persone che lo circondano. Non è un caso che una delle prime domande con cui un bambino rivolge a un adulto sia la domanda "cosa è bene e cosa è male?".
Grazie alla comunicazione con un insegnante, nel ruolo di cui può agire un genitore, insegnante, allenatore, lo studente ha l'opportunità non solo di assegnare una certa porzione di conoscenza sulle regole delle relazioni tra le persone che lo circondano. Si immerge nel mondo complesso e contraddittorio delle relazioni umane e sente ciò che prova un adulto: sia la soddisfazione per un lavoro ben fatto, sia l'indignazione per il lassismo di qualcuno, e la tristezza per la perdita di una persona cara.
"Quando è la cosa più vivida, più intensa, più profonda che esprimiamo a parole: l'insegnante educa i suoi allievi?" - chiede V.A. Sukhomlinsky. E lui risponde: "Quando i sentimenti dell'insegnante sono in contatto con i sentimenti dell'animale domestico".
La funzione delle persone che si conoscono è anche una delle più importanti nella comunicazione. Ogni persona è tutt'altro che indifferente con chi dovrà studiare insieme, lavorare, trascorrere il tempo libero, creare una famiglia. Poiché il benessere di una persona dipende in gran parte dalle persone che lo circondano, è necessario conoscere bene queste persone: le caratteristiche del loro temperamento, carattere, orientamenti di valore. È importante che l'insegnante conosca le caratteristiche dello sviluppo fisico, intellettuale, emotivo e morale di ciascuno dei suoi studenti, le caratteristiche del suo rapporto con l'apprendimento, il lavoro, le persone e se stesso. Gli studenti sono anche lungi dall'essere indifferenti a chi lavora con loro, cos'è un insegnante come specialista e come persona? Pertanto, attraverso la comunicazione e le attività congiunte, l'insegnante e gli studenti si conoscono.
Nella comunicazione pedagogica si realizza la funzione di organizzare e servire l'una o l'altra attività disciplinare: educativa, industriale, scientifica, cognitiva, di gioco e altro. Intrecciata con un tipo specifico di attività, la comunicazione agisce come un modo per organizzarla. È, per così dire, relegato in secondo piano e, a prima vista, svolge solo un ruolo secondario, ausiliario, poiché il lavoro, il raggiungimento dei suoi compiti, viene in primo piano. Ad esempio, in relazione alle attività educative, l'obiettivo principale della lezione è che gli studenti padroneggino determinate conoscenze e abilità, si uniscano ricerca educativa. Dopotutto, i genitori mandano i loro figli a scuola non solo per parlare con gli insegnanti, ma per imparare a leggere e scrivere, "diventare intelligenti", imparare le leggi della natura, imparare a risolvere problemi complessi in matematica, fisica e altre materie.
Tuttavia, questa è un'apparente "minoranza", perché è grazie alla comunicazione che l'insegnante dirige i pensieri degli studenti in una certa direzione della lezione, focalizza la loro attenzione su fenomeni e processi interessanti, si offre di ricordare nomi, eventi, date specifici , formule che sono la spina dorsale in un particolare campo della conoscenza. Attraverso la comunicazione, l'insegnante riceve informazioni sull'efficacia dell'organizzazione delle attività cognitive e pratiche degli studenti: come hanno compreso il materiale didattico? Quanto bene possono utilizzare le nuove conoscenze per risolvere i problemi? compiti pratici? Pertanto, nel processo pedagogico, gioca la comunicazione ruolo speciale: anche servendo alcuni attività principale e come se svolgesse un ruolo di supporto, influisce in modo significativo sulla qualità di questa attività.
Grazie alla comunicazione si effettua il contagio emotivo degli studenti, il loro umore si alza, appare un importante nella vita della classe. Le peculiarità della comunicazione spiegano il desiderio degli studenti di svolgere l'attività proposta da un insegnante e il rifiuto della stessa attività proposta da un altro insegnante. Questo è esattamente ciò che spiega un tale paradosso che si verifica nella pratica scolastica, quando un insegnante che ha una vasta conoscenza ed è in grado di risolvere i problemi più complessi dei manuali per i candidati all'università non è interessato ai suoi studenti, e un insegnante che ha un basso formazione della materia, diventa l'anima della squadra studentesca e gode del rispetto degli studenti.
Un esempio di tale comunicazione sono i contatti amichevoli, gli incontri di vecchi amici d'infanzia, ex compagni di classe. I partner traggono soddisfazione dal fatto stesso di incontrare amici, dalla condivisione di ricordi degli anni passati, dall'opportunità di confrontare i risultati della loro vita con i successi dei loro coetanei.
Nella pratica scolastica, non è raro che uno studente venga dall'insegnante non per chiedere aiuto in materia, ma "proprio così" per stare un po 'con il suo mentore, per parlare con lui di qualcosa, per "solo parlare" . Ciò può includere anche conversazioni tra l'educatore e gli alunni "cuore a cuore", "occhi negli occhi", durante i quali si realizza lo scambio di valori spirituali personali. Gli scolari moderni, nonostante il gran numero di contatti con gli altri, molto spesso sperimentano una carenza proprio di tale comunicazione.
Nella comunicazione pedagogica si realizza la funzione di introdurre il partner all'esperienza e ai valori dell'iniziatore della comunicazione. Ciò è particolarmente vero per la comunicazione tra genitori e figli, insegnanti e studenti, insegnanti e studenti. La missione di genitori e insegnanti è proprio quella di aiutare i loro figli e studenti a unire le loro opinioni, credenze, standard morali, ad es. a qual è il valore della vita adulta.
Nelle situazioni della vita reale, specialmente in quelle in cui l'insegnante e gli studenti interagiscono, è evidente un certo "squilibrio" dei partner, per quanto democratica possa essere la loro relazione. Un genitore o un insegnante, di norma, ha molta esperienza di vita, una quantità significativa di conoscenze e abilità, più stabile posizione sociale dei suoi figli o studenti. Questo vantaggio conferisce determinati diritti a dimostrare la propria competenza sia in aree specifiche della conoscenza scientifica che in questioni di vita e allo stesso tempo impone seri obblighi allo svolgimento qualitativo del ruolo di genitore o insegnante. Allo stesso tempo, è importante mantenere il senso delle proporzioni. Non è un segreto che a volte genitori e insegnanti vorrebbero accelerare molti processi in modo che i bambini imparino più velocemente, prendano i loro doveri più seriamente e siano più rispettosi degli anziani. Nel tentativo di accelerare tali processi, gli adulti mostrano impazienza, irritabilità nei confronti dei bambini, consentono l'uso di mezzi duri e, di regola, rovinano solo i rapporti con i bambini e non ottengono i risultati desiderati. Pertanto, più forti sono i contatti interpersonali tra genitori e figli, insegnanti e studenti, maggiori saranno le opportunità per introdurre i rappresentanti delle giovani generazioni ai valori delle generazioni più anziane.
Nel corso della comunicazione professionale e pedagogica si può realizzare anche la funzione di introdurre l'iniziatore della comunicazione ai valori del partner. Questo processo è autoeducazione, ad es. il processo di autoformazione dell'iniziatore della comunicazione, il processo di creazione del proprio "io" attraverso l'orientamento ai valori di un'altra persona. Una persona del genere per uno studente può essere un padre, una madre, un insegnante, un amico, un amante, un idolo musicale o sportivo.
Concentrandosi su una persona significativa per se stesso, lo studente apprende sia gli attributi esterni del suo idolo (l'originalità dell'abbigliamento, l'acconciatura, il comportamento) sia le caratteristiche delle sue opinioni e convinzioni (cosa ha detto, quale posizione ha preso nella disputa, cosa ama e ciò che non sopporta). In questo modo, per così dire, si appropria dei valori di un'altra persona, affezionandosi gradualmente a loro.
Se un insegnante diventa l'idolo di uno scolaretto, lo studente apprende non solo gli attributi esterni del suo comportamento, ma anche le sue idee morali su concetti come dovere, responsabilità, onore. Lo studente si sforza di fare ciò che sarebbe approvato da questo insegnante e di non fare ciò che lo sconvolgerebbe. Questo dimostra ancora una volta quanto sia importante per un insegnante diventare una persona significativa per i propri studenti.
In una serie di lavori sulla tecnologia pedagogica, vengono individuate diverse importanti funzioni della comunicazione professionale e pedagogica.
Il punto di partenza è la funzione di apertura del bambino alla comunicazione. Si manifesta nel risvegliare il desiderio di comunicazione del bambino, rimuovendo i vincoli psicologici, alleviandolo dalla paura dell'ignoto, aumentando l'autostima e la fiducia in se stessi e convincendo anche un'altra persona, in particolare l'insegnante, di un atteggiamento positivo nei suoi confronti . Questa funzione gioca un ruolo cruciale nella fase iniziale dell'interazione tra l'insegnante e lo studente. La sua attuazione è legata alla capacità dell'insegnante di "applicarsi" ai bambini, di dimostrare la sua disposizione nei loro confronti, di convincerli delle sue intenzioni pacifiche e dei suoi nobili pensieri. L'inizio della comunicazione e la sua natura dipendono in gran parte da questo.
La funzione di partecipazione è progettata per supportare un partner (in particolare uno studente) nella sua comunicazione. La sua attuazione richiede che l'insegnante si faccia carico di alcune delle difficoltà dello studente, gli fornisca l'aiuto e il supporto necessari e stimoli le sue azioni di successo. È importante poter mostrare interesse per lo studente, imparare ad ascoltare il proprio interlocutore, offrirgli il proprio aiuto. Attraverso la complicità, l'insegnante riesce a comprendere meglio il mondo interiore del suo allievo, al quale a volte deve rivelare il suo mondo interiore, trasmettergli il suo "io".
Una caratteristica speciale nella comunicazione professionale e pedagogica è la funzione di elevare la personalità dello studente. L'attuazione di questa funzione comporta l'esercizio di una tale influenza sull'allievo, che contribuisce alla sua ascesa verso nuove formazioni spirituali. Come risultato della comunicazione con l'insegnante, lo studente dovrebbe voler essere più gentile, più audace, più risoluto, più attento alle persone che lo circondano e avere molte altre qualità e tratti caratteriali positivi.
È importante che l'insegnante conosca il ruolo di ciascuna delle funzioni di comunicazione e, quando pianifica le sue attività con gli studenti, si occupi dell'implementazione non solo di una, ma dell'intero sistema di funzioni. "Un insegnante", scrive V.A. Kan-Kalik, "nella sua attività deve attuare tutte le funzioni della comunicazione - agire sia come fonte di informazioni, sia come persona che conosce un'altra persona o gruppo di persone, sia come organizzatore di attività collettive attività e relazioni”.
Purtroppo alcuni insegnanti, quando preparano una lezione, si concentrano sulla funzione informativa, lasciando gli altri senza la necessaria attenzione. Selezionano attentamente il contenuto del materiale didattico, riflettono sui metodi della sua presentazione, pianificano il tempo per interrogare gli studenti e spiegare il nuovo materiale. Tuttavia, se allo stesso tempo l'insegnante non sa come interagire con gli studenti, non presta attenzione alla loro età e alle caratteristiche della personalità, non si preoccupa dell'impressione che gli studenti hanno di lui, tutti gli sforzi didattici dell'insegnante possono essere invano. Molti studenti percepiscono il contenuto della lezione principalmente attraverso la personalità dell'insegnante, attraverso il suo modo di comportarsi in classe e il modo di comunicare con gli studenti.
Pertanto, nella comunicazione si realizzano molte funzioni diverse, ognuna delle quali è importante nell'attività professionale di un insegnante.
Se i partner si scambiano oggetti o prodotti di attività, tale comunicazione è chiamata materiale, poiché consente alle persone di ricevere oggetti di cultura materiale e spirituale necessari per loro. Ad esempio, ciò accade quando un insegnante e gli scolari come parte di un team di produzione negoziano con il datore di lavoro le condizioni per eseguire lavori relativi alla costruzione di una struttura o alla raccolta, concordano la procedura per scambiare il loro lavoro con cibo o denaro guadagnato da questo, e poi realizzare questi accordi.
La comunicazione cognitiva, a differenza della comunicazione materiale, è uno scambio di conoscenze e agisce come fattore sviluppo intellettuale partner. La comunicazione cognitiva è al centro del processo di apprendimento.
L'essenza dell'attività pedagogica è dimostrare agli studenti la loro erudizione in determinate aree della conoscenza e, in una certa misura, contribuire alla trasformazione di parte di questa conoscenza. A scuola e soprattutto negli anni degli studenti futuro insegnante riceve una parte significativa delle conoscenze dai suoi insegnanti scolastici e universitari, e poi, diventando un insegnante, cerca di trasmettere le conoscenze acquisite ai suoi studenti. Quindi, grazie alla comunicazione cognitiva, viene effettuato l'eterno movimento della conoscenza dall'insegnante agli studenti, a seguito del quale viene assicurata non solo la conservazione di questa conoscenza, ma il loro costante incremento e sviluppo, l'emergere di nuove aree di conoscenza.
Poiché lo scambio di stati mentali e fisiologici è possibile durante l'interazione dei partner, anche la comunicazione condizionale si distingue per il contenuto. Con tale comunicazione, le persone in un certo modo influenzano il benessere mentale o fisico di un partner. Ad esempio, il comportamento severo dell'insegnante all'inizio della lezione, l'espressione seria sul suo viso e la sua voce ferma mettono gli studenti in uno stato d'animo lavorativo, e il suo sorriso, le battute e il racconto di storie divertenti contribuiscono al rilascio emotivo in la lezione. Grazie alla comunicazione condizionata, un insegnante può calmare uno studente angosciato dal fallimento, un allenatore può sollevare lo spirito di un atleta prima della partenza e qualcuno si prenderà cura di rovinare l'umore del suo avversario in una lite.
La comunicazione motivazionale è un impatto sugli obiettivi, interessi, motivi e bisogni del soggetto. È una fonte di energia aggiuntiva per un partner di comunicazione, poiché nel processo di interazione vengono trasmessi determinati motivi per le azioni, sorge l'interesse per qualcosa, la motivazione per questa o quell'attività viene “accesa”.
Ad esempio, molti insegnanti orientati alla creatività non si limitano a presentare semplicemente il contenuto del materiale didattico disponibile in un libro di testo scolastico, ma cercano di interessare gli studenti utilizzando informazioni insolite provenienti da altre fonti, attraverso l'uso di moderni sussidi didattici tecnici, dimostrando interessanti esperimenti e altre tecniche didattiche. Sanno che uno studente che si distingue per un interesse cognitivo (a volte chiamato "studente motivato") è un alleato dell'insegnante. E lavorare con gli alleati è molto più piacevole che lavorare con persone indifferenti o negative.
La comunicazione dell'attività si basa sullo scambio interpersonale di azioni, operazioni, competenze e abilità. Tale comunicazione è particolarmente evidente nelle lezioni di lavoro, cultura fisica, su laboratorio e esercitazioni pratiche in fisica, chimica e una serie di altre materie. L'insegnante, dopo aver dimostrato agli studenti le sue azioni sulla macchina o sull'attrezzatura sportiva, durante l'assemblaggio di vari schemi, si offre quindi di ripetere queste azioni agli studenti. Grazie alla comunicazione attiva, la formazione abilità pratiche e le abilità degli studenti.
1.5. Mezzi di comunicazione pedagogica
Un'altra importante caratteristica della comunicazione sono i mezzi di comunicazione, che possono essere rappresentati come modi per trasmettere informazioni ed esprimere relazioni tra partner nel processo della loro interazione (A.A. Lobanov). Lisina ritiene che i mezzi di comunicazione siano "... quelle operazioni con l'aiuto delle quali ogni partecipante costruisce le sue azioni comunicative e contribuisce all'interazione con un'altra persona ...". Individua 3 principali categorie di mezzi di comunicazione: mezzi espressivi - mimici (sorriso, sguardo, mimica facciale, movimenti espressivi delle mani e del corpo, vocalizzazioni espressive); mezzi efficaci per l'oggetto (movimenti locomotori e dell'oggetto, posture utilizzate per scopi di comunicazione, avvicinamento, rimozione, consegna di oggetti, posture di protesta) e mezzi di comunicazione verbale (dichiarazioni, domande, risposte, osservazioni).
Lobanov A.A. dà la seguente classificazione: a seconda dei mezzi, la comunicazione può essere diretta e indiretta, diretta e indiretta, verbale e non verbale.
La comunicazione diretta viene effettuata con l'aiuto di organi naturali donati all'uomo dalla natura: mani, testa, busto, corde vocali, ecc.
Ad esempio, una madre, calmando il suo bambino turbato, gli accarezza dolcemente la testa, gli dice parole gentili e sorride. Il bambino sente la sua voce gentile, sente il tocco gentile delle sue mani calde e le risponde con il suo sorriso. Metodi di comunicazione simili sono usati da molti insegnanti di scuola materna. istituzioni prescolari, orfanotrofi, insegnanti di scuola primaria e persino secondaria.
La comunicazione mediata è associata all'uso di mezzi e strumenti speciali per organizzare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le persone. Questi possono essere oggetti naturali (un bastone, un sasso lanciato) o media culturali (radio, televisione, stampa). Da tempo immemorabile, molti innamorati hanno utilizzato per comunicare sassolini lanciati contro le finestre dei loro amanti, oltre a note e altri mezzi per trasmettere le informazioni necessarie.
Un esempio di comunicazione mediata è il controllo da parte dell'insegnante del lavoro scritto dello studente, quando, leggendo le righe di un tema scolastico o pensando a come risolvere compito di controllo, l'insegnante riceve per sé informazioni sul filo del pensiero dello studente, le caratteristiche dello sviluppo del suo pensiero figurativo e astratto. Le righe del saggio di uno studente o le colonne dei calcoli fungono qui da mezzo di comunicazione tra l'insegnante e lo studente.
Nella comunicazione diretta, i partner interagiscono faccia a faccia, ad es. "qui e ora", partecipare personalmente all'atto stesso della comunicazione. Senza intermediari, si scambiano sguardi, strette di mano, messaggi verbali.
Ad esempio, un insegnante in una lezione non solo sente come risponde lo studente, ma vede anche come è preoccupato allo stesso tempo, capisce dalla sua postura tesa e dai suoi gesti limitati lo stato mentale al momento della risposta, come risultato di che cerca di aiutare lo studente.
La comunicazione indiretta avviene tramite un intermediario. I partner non si vedono o si sentono personalmente, ma trasmettono informazioni attraverso una terza parte che funge da intermediario. Ad esempio, un insegnante trasmette attraverso gli studenti parole di gratitudine ai genitori per aver sponsorizzato una gita scolastica in un'altra città.
Anche gli apparecchi radiotelevisivi possono essere utilizzati come intermediari, reti di computer, stampa e altri sistemi di segni. Il processo educativo include sempre più reti televisive e informatiche sia locali che globali, grazie alle quali scolari moderni, studenti e insegnanti hanno l'opportunità di comunicare non solo con i loro compagni di classe e colleghi, ma anche con rappresentanti di altre città e paesi.
Il principale mezzo di comunicazione professionale e pedagogica è la lingua, il linguaggio umano. Gli psicologi chiamano tale comunicazione verbale, ad es. verbale, poiché le informazioni tra le comunicazioni vengono trasmesse usando le parole.
La comunicazione verbale è inerente solo a una persona e, come prerequisito, comporta l'acquisizione del linguaggio, orale e scrivere. La comunicazione attraverso la parola consolida e conserva l'esperienza dell'uomo, i valori culturali e morali, tramandandoli di generazione in generazione. La lingua è un mezzo speciale per trasformare la cultura. La parola è un forte irritante e può avere un enorme impatto su una persona: "Con una parola puoi uccidere, con una parola puoi salvare, con una parola puoi guidare i reggimenti dietro di te", dice una famosa poesia di Rudolf Shefner .
Esiste anche una comunicazione non verbale (senza parole), che non comporta l'uso di un discorso sonoro come mezzo di comunicazione. Questa è la comunicazione con l'aiuto di sguardi, gesti, espressioni facciali e altri segnali non verbali.
Grazie alla comunicazione non verbale, una persona ha l'opportunità di svilupparsi mentalmente anche prima di padroneggiare e imparare a usare la parola, dal momento della nascita a 2-3 anni. Inoltre, da solo comunicazione non verbale contribuisce allo sviluppo e al miglioramento delle capacità comunicative di una persona, a seguito delle quali diventa più capace contatti interpersonali e apre maggiori opportunità di sviluppo. Dalla postura dello studente (curvo o raddrizzato), dalla sua andatura (strascicare i piedi o battere un passo), dall'espressione del suo viso (cupo o raggiante in un sorriso), l'insegnante può facilmente capire lo stato della studente e scegli le tattiche della sua interazione con lui che sono necessarie per questa situazione. I mezzi di comunicazione pedagogica sono varie influenze da parte dell'insegnante, che determinano la natura del suo rapporto con gli scolari.
L'impatto pedagogico è esercitato da un breve momento di comunicazione, a volte appena percettibile, tra l'insegnante-educatore ei suoi studenti e alunni, nonché anche un breve momento di interazione tra lo studente e il mondo esterno. L'insegnante ha sbattuto rumorosamente la porta all'ingresso dell'aula, si è fermato e ha guardato severamente ogni studente, ha fatto un'osservazione allo studente che era in ritardo per la lezione, ha suggerito agli studenti di aprire i quaderni e di annotare l'argomento della lezione - questo non è un elenco completo delle possibili influenze pedagogiche solo durante il momento organizzativo della lezione. Lo scopo dell'influenza pedagogica non è sopprimere l'eccessiva agilità dello studente ("obbedire all'insegnante"), ma organizzare l'interazione dello studente con il mondo e trasferirlo nella posizione di un soggetto consapevole della propria vita.
L'impatto pedagogico, di norma, corrisponde agli obiettivi e agli obiettivi su cui si concentra l'insegnante. Se l'obiettivo dell'insegnante è stabilire relazioni democratiche con i suoi studenti, allora la sua influenza non dovrebbe essere di natura autoritaria, non dovrebbe offendere la dignità degli studenti.
L'influenza pedagogica dovrebbe aiutare, in primo luogo, ad avviare l'attività dello studente, poiché solo una persona attiva è in grado di apprendere il mondo e sviluppa le tue inclinazioni; in secondo luogo, aiutare lo studente a padroneggiare le modalità di organizzazione delle attività e di interazione con il mondo, poiché lo studente non sempre sa come risolvere compiti educativi e, inoltre, di vita; in terzo luogo, contribuire alla comprensione dell '"io" dello studente nei suoi rapporti con il mondo esterno, per dargli l'opportunità di prendere autonomamente decisioni e assumersene lui stesso la responsabilità.
Queste sono le principali funzioni dell'influenza pedagogica, che, a loro volta, vengono realizzate attraverso le corrispondenti operazioni e abilità dell'insegnante. Se il numero di funzioni è piuttosto limitato, il numero di operazioni è pressoché infinito a causa della diversità dell'attrezzatura operativa dell'insegnante: le caratteristiche del suo discorso, i gesti, le espressioni facciali, i movimenti del corpo, le azioni e altre manifestazioni. Ciò contribuisce all'ampliamento della gamma di comunicazione tra insegnante e alunni e alla creazione di ulteriori opportunità per familiarizzare gli scolari con i valori culturali della società.
Consideriamo alcune operazioni.
"I-messaggio" è un annuncio da parte dell'insegnante del suo stato, benessere, pensieri e sentimenti su un particolare evento o fenomeno, testimone o partecipante di cui è. Ad esempio: "Mi rallegro sempre quando incontro un cavaliere moderno", dice l'insegnante a uno studente che ha mostrato un atteggiamento cavalleresco nei confronti di una dama.
"I-message" è un tale giudizio di valore dell'insegnante, in cui la valutazione pedagogica si trasforma da una forma aperta in una nascosta. Non prescrive agli scolari cosa dovrebbero fare, ma corregge il loro atteggiamento e comportamento, fornendo libertà di scelta. Nel "messaggio in prima persona" l'insegnante usa formule vocali come "io sempre...!", "io sempre...!", "io sempre...!".
Il "messaggio in prima persona" può essere utilizzato sia per l'approvazione che per la condanna di determinate azioni dello studente. "Mi fa sempre piacere vedere persone vestite con eleganza e gusto", dice l'insegnante di classe ai suoi studenti, elegantemente vestiti per una gita a teatro. "Mi fa sempre male quando vedo come i deboli sono offesi", dice l'insegnante, proteggendo la prima elementare dalla pressione dell'adolescente.
Il "rinforzo positivo" consiste nell'annuncio pubblico dei reali vantaggi del partner.
Ogni studente può sempre trovare qualcosa di buono, positivo. Possono essere sia i dati esterni dello studente - fisico alto e forte, bella figura, sia le sue caratteristiche intellettuali - buona memoria, eloquenza sviluppata, abilità matematiche. Il rispetto, l'ammirazione possono essere meritati dagli hobby e dai risultati dello studente: esibizione di successo a una competizione o gare sportive, partecipazione a una mostra d'arte, pubblicazione delle sue prime poesie. Pertanto, quando l'insegnante afferma di essere stato lieto di conoscere i risultati dello studente, stimola lo studente a nuovi successi creativi. Il rinforzo positivo può essere assegnato alle azioni comportamentali individuali dello studente: mostrare preoccupazione per il suo compagno di classe, arrabbiarsi per il rendimento infruttuoso della classe nelle Olimpiadi scolastiche, ecc.
Ovviamente il compito dell'insegnante è vedere sia i punti di forza che di debolezza dello studente, ma concentrarsi sulle sue manifestazioni positive, prendersi cura di creare una reputazione positiva tra lo studente e un'atmosfera psicologica favorevole in cui è più facile superare carenze.
"You-message" è l'annuncio da parte dell'insegnante della sua ipotesi sul probabile stato del bambino al momento della sua esecuzione di un'azione specifica. Usa formule vocali come "Probabilmente tu ...", "Tu, ovviamente ...", "A quanto pare ...". "Devi essere stato molto impegnato e non hai avuto il tempo di mettere in ordine il tuo vestito", dice un insegnante a uno studente che è venuto a scuola con i vestiti sgualciti. L'insegnante, per così dire, giustifica lo studente, cerca di trovare una propria spiegazione per la sua negligenza e sciatteria, e attraverso questo cerca di attirare la sua attenzione sulla necessità di monitorare il suo aspetto.
"We-message" consiste nell'introdurre lo studente ai problemi che l'insegnante risolverà: "Considereremo oggi nella lezione ..."; "È giunto il momento di mettere alla prova la nostra forza in...". L'insegnante include discretamente ogni studente nella sua squadra, lui, per così dire, dichiara una disponibilità generale per un caso specifico.
I metodi di influenza possono essere la fornitura di assistenza allo studente, la manifestazione di interesse per la sua personalità oi risultati delle sue attività, la richiesta di aiuto e altre operazioni descritte nella letteratura sulla tecnologia pedagogica.
1.6. La struttura della comunicazione pedagogica
L'interazione dell'insegnante con la classe ha un certo lasso di tempo; è limitato alla durata di una lezione, di un'ora di lezione o di qualche altra attività. Tuttavia, la struttura della comunicazione pedagogica non si limita ai contatti diretti tra l'insegnante e gli alunni, ma include anche una serie di altri punti.
Nella struttura della comunicazione pedagogica si possono distinguere una serie di fasi (V.A. Kann - Kalik):
Modellazione da parte dell'insegnante della comunicazione imminente con la classe, con un altro altro pubblico in fase di preparazione per attività dirette con bambini o adulti (fase prognostica).
Organizzazione della comunicazione diretta con la classe, il pubblico al momento dell'interazione iniziale con loro (il periodo iniziale della comunicazione).
Gestione della comunicazione nel processo pedagogico in via di sviluppo.
Analisi del sistema di comunicazione implementato e modellazione del sistema di comunicazione della prossima attività.
Nella prima fase - la fase di modellazione - l'insegnante è preconfigurato per l'imminente interazione con la classe. Di norma, durante la preparazione di una lezione, tutti gli insegnanti riflettono sul contenuto del materiale didattico che presenteranno a lezione, selezionano i metodi e le tecniche con cui dovranno organizzare le attività conoscitive e pratiche degli studenti, controllano il disponibilità delle attrezzature di laboratorio e dei mezzi tecnici per la lezione. Svolgono la preparazione didattica per la lezione, risolvendo un tipico compito didattico: cosa insegnare e come insegnare ai propri studenti?
Sfortunatamente, non tutti gli insegnanti pensano a quelle persone che sono destinate a materiale didattico, metodi e tecniche per studiarlo. E invano, perché il successo dell'attività didattica dell'insegnante è praticamente impossibile senza un supporto comunicativo adeguatamente organizzato. Questa è la specificità del lavoro pedagogico. I compiti didattici saranno risolti con successo se l'insegnante pensa anche a modi per risolvere compiti comunicativi.
Pertanto, nella fase di modellazione, è anche importante considerare le modalità di interazione con gli studenti durante la lezione. A cosa dovresti prestare attenzione qui?
In questa fase, l'insegnante prevede la percezione degli studenti non solo del materiale educativo, ma anche della personalità dell'insegnante stesso. Qui viene in primo piano la questione dei rapporti con la classe.
Se l'insegnante non ha contatti con gli studenti, allora, ovviamente, è importante capire le ragioni della relazione fallita.
Quali sono le ragioni principali della discordia tra insegnante e studenti: nella complessità del materiale didattico, nel metodo della sua presentazione o nella personalità dell'insegnante?
A questo punto è possibile riflettere sul proprio comportamento con una particolare classe: con quale espressione facciale è più opportuno entrare in classe; come garantire rigore nella voce, nelle espressioni facciali e nei gesti nei primi minuti della lezione; quando è meglio condurre una sorta di rilassamento psicologico in classe e come farlo al meglio (dimostrare esperienze interessanti, raccontare una storia divertente o fare riferimento a un video).
Non si dovrebbe considerare questo tipo di preimpostazione come una preparazione di ricette pedagogiche originali per varie situazioni che possono nascere in classe. La comunicazione della prescrizione è quasi impossibile, poiché la lezione è un processo con condizioni in costante cambiamento. Possiamo solo parlare dell'analisi delle relazioni che si sono sviluppate tra l'insegnante e la classe, della presa in considerazione dei suoi punti di forza e debolezze nella comunicazione con gli studenti, sulla determinazione preliminare della propria posizione e sulla costruzione di diverse linee di comportamento a seconda della situazione attuale di interazione con gli studenti.
Tale modellazione viene eseguita da rappresentanti di molte professioni: medici - prima di eseguire operazioni chirurgiche, istruttori - alla vigilia delle competizioni sportive, astronauti - prima del volo spaziale, militari - in preparazione per operazioni di addestramento o combattimento. È anche importante che l'insegnante rifletta sulle sue azioni prima della lezione e combini la soluzione dei compiti didattici e comunicativi in \u200b\u200bun unico insieme. Ovviamente, gli insegnanti alle prime armi hanno bisogno di una formazione più approfondita rispetto alle loro controparti più esperte. Ma la cosa principale è che questa fase è importante per qualsiasi insegnante.
La seconda fase è l'inizio dell'interazione diretta tra l'insegnante e la classe. Altrimenti, si chiama attacco comunicativo. Molto dipende dai primissimi minuti di comunicazione tra l'insegnante e gli studenti. L'insegnante sarà in grado di prendere in mano l'iniziativa della comunicazione o la darà immediatamente ai suoi studenti? Attuerà costantemente le sue idee per l'interazione con la classe o lascerà che tutto faccia il suo corso: come andrà a finire?
Prima di tutto, l'auto-presentazione dell'insegnante alla classe è importante. Con quale espressione facciale l'insegnante entra in classe? Una faccia irritata, arrabbiata o arrabbiata sarà una reazione degli studenti. In divertente e gioioso - completamente diverso. E se il volto dell'insegnante esprime indifferenza agli studenti, gli studenti reagiranno di conseguenza.
Ovviamente un'informazione importante per gli studenti è contenuta nella voce del Maestro, le sue prime parole alla classe: come si pronunciano? Quale intonazione? Cosa viene detto agli studenti? Quali sono i rischi per gli studenti?
Una voce severa, ma allo stesso tempo calma chiamerà gli studenti all'ordine, interromperà conversazioni inutili e rivolgerà la loro attenzione all'insegnante e ai compiti che pone nella lezione. Tale severità, che non contiene minacce e pressioni sulla personalità dello studente, di regola, non è offensiva per la classe e contribuisce al rapido umore degli studenti in modo professionale e alla collaborazione con l'insegnante.
Se l'insegnante parla con voce severa ma irritata contenente insulti o minacce contro gli studenti, allora l'effetto sarà completamente diverso. È possibile che gli studenti obbediscano ai requisiti dell'insegnante, ma allo stesso tempo avranno una crescente protesta interna contro la sua irritazione e minacce. Ed è molto probabile che a un certo punto della lezione, la classe oi singoli studenti trovino opportunità per esprimere la loro protesta all'insegnante: non si affretteranno a soddisfare le sue richieste, faranno deliberatamente rumore e interferiranno con l'insegnante, e forse, al contrario, taceranno e non risponderanno alle domande dell'insegnante. Rumore eccessivo o, al contrario, "silenzio morto", come sai, non lo sono condizioni favorevoli per una proficua collaborazione in classe.
L'apparizione in classe di un insegnante con un sorriso spensierato ("con un sorriso da un orecchio all'altro"), ovviamente, provocherà immediatamente un'allegra animazione in classe e "smagnetizza" gli studenti.
Un attacco comunicativo è una sorta di lotta per l'iniziativa nella comunicazione. Se l'insegnante riesce a prenderlo in mano, allora inizierà a gestire il corso della lezione e sarà in grado di realizzare le sue idee. Se l'insegnante dà l'iniziativa nella comunicazione agli studenti, allora sarà difficile per lui gestire il processo, poiché dovrà seguire gli eventi. Un attacco comunicativo è una sorta di domanda dell'insegnante: "Sono il maestro della classe", dice un insegnante; "Offro collaborazione", dice il secondo; "Ragazzi, non vi offenderò, ma non offendete neanche me", supplica il terzo. Quale opzione scegliere?
La terza fase - la gestione della comunicazione nel processo pedagogico in via di sviluppo - è la più lunga in termini di tempo di interazione diretta tra insegnante e studenti e, ovviamente, la più difficile.
Questa complessità è dovuta principalmente al fatto che ogni fase della lezione (momento organizzativo, interrogazione degli studenti, spiegazione di nuovo materiale, consolidamento, ecc.) Si distingue per le specificità dei compiti risolti su di essa e le peculiarità dell'interazione tra l'insegnante e la classe.
Ad esempio, quando si spiega nuovo materiale a un insegnante, è importante attirare l'attenzione degli studenti sulla sua presentazione, sulle sue dimostrazioni ed esempi. Qui tutto dipende dall'insegnante, dalla sua capacità di esprimere chiaramente ed emotivamente i suoi pensieri, dimostrare chiaramente le sue esperienze. E durante le domande, l'insegnante cerca non solo di ascoltare la risposta dello studente, ma anche di attirare l'attenzione dell'intera classe sulla sua risposta. E qui praticamente non è l'insegnante, ma lo studente che controlla l'attenzione degli scolari. Questo controllo può avvenire se lo studente parla in modo chiaro, chiaro ed emotivo. E se la risposta dello studente non suona, se contiene molti errori, se il discorso dello studente è appena udibile e confuso, è improbabile che la classe lo ascolti. Pertanto, l'insegnante deve trovare modi per comunicare con la classe, non solo nel processo della propria presentazione del materiale educativo, ma anche nel corso della risposta sia di uno studente forte che di uno studente debole.
La complessità di questa fase è dovuta anche al fatto che l'insegnante non solo delinea e realizza le sue idee didattiche e comunicative, come accade nella 1a e 2a fase, ma incontra anche situazioni nuove e non pianificate.
In questa fase, l'insegnante è costretto a rispondere rapidamente a situazioni impreviste in classe e a risolvere costantemente nuovi compiti di comunicazione per se stesso. Ecco perché la comunicazione pedagogica è un processo creativo.
La quarta fase è l'analisi del sistema di comunicazione implementato e la modellazione del sistema. comunicazione delle prossime attività. L'essenza di questa fase è analizzare la comunicazione con gli scolari, annotarne le tendenze principali e comprendere le ragioni dell'interazione riuscita con loro, nonché le difficoltà che l'insegnante ha dovuto affrontare.
In questa fase, è importante che l'insegnante si ponga le seguenti domande: la lezione ha avuto successo in termini di comunicazione con gli studenti? Ha interagito correttamente con la classe? Cosa ha contribuito e cosa ha ostacolato l'instaurarsi di contatti con gli studenti in classe? Quali situazioni inaspettate sono sorte durante la lezione? Quanto è riuscito a trovare vie d'uscita da queste situazioni? Con quali mezzi è stato possibile controllare l'attenzione degli studenti, includerli in attività conoscitive e pratiche? In che misura la voce, l'aspetto, le espressioni facciali ei gesti hanno aiutato a comunicare con la classe? Quali imprecisioni, calcoli errati ed errori di comunicazione sono stati commessi durante la lezione e cosa è necessario fare per non ripeterli più? È altrettanto importante rispondere a queste domande nel modo più onesto possibile.
Un antico filosofo disse: "Non puoi entrare due volte nello stesso fiume". Allo stesso tempo, l'esperienza di attraversare un fiume aiuterà a organizzarlo attraverso altri fiumi. Senza un'analisi delle proprie attività, è impossibile andare avanti.
La struttura della comunicazione pedagogica non va confusa con la struttura della lezione.
Come sapete, la struttura della lezione prevede un momento organizzativo, un sondaggio tra gli studenti, una spiegazione del nuovo materiale, rinforzi e altri elementi. L'insegnante ha il diritto di modellare autonomamente la struttura della lezione, assegnare a ciascuno degli elementi il tempo necessario, a suo avviso, modificare la sequenza di questi elementi o escluderne alcuni in lezioni specifiche.
La struttura della comunicazione pedagogica rappresenta le fasi dell'interazione dell'insegnante con i suoi studenti e alunni dispiegati nel tempo. Qui possiamo parlare degli intervalli di tempo di ciascuna di queste fasi (ad esempio, della minimizzazione dell'attacco comunicativo), ma è quasi impossibile scambiarli o escluderne qualcuno. L'insegnante pensa prima allo svolgimento della lezione e alle caratteristiche della sua comunicazione con la classe, quindi entra in classe e inizia la sua interazione con gli studenti. Effettua prima un attacco comunicativo e gestisce il processo di comunicazione durante la lezione, e solo successivamente analizza l'interazione con gli studenti avvenuta.
Una simile struttura di comunicazione è possibile quando l'insegnante interagisce non solo in classe con i suoi studenti. Ovviamente, le fasi sopra descritte avvengono quando l'insegnante comunica con i suoi colleghi, oltre che con i genitori degli studenti e con i rappresentanti dell'amministrazione scolastica. In molti contatti dell'insegnante con uno qualsiasi dei soggetti della comunicazione, si possono individuare la fase prognostica, l'attacco comunicativo, la gestione della comunicazione in corso e l'analisi della comunicazione completata.
Capitolo 2. Stile di comunicazione pedagogica e
i suoi tipi
2.1. Il concetto di stile della comunicazione pedagogica
La comunicazione permea l'intero sistema di influenza pedagogica, ciascuno dei suoi microelementi. Durante la lezione, l'insegnante deve padroneggiare la struttura comunicativa dell'intero processo pedagogico, essere il più sensibile possibile ai minimi cambiamenti, correlare costantemente i metodi selezionati di influenza pedagogica con le caratteristiche della comunicazione in questa fase. Tutto ciò richiede che l'insegnante sia in grado di risolvere due problemi contemporaneamente: stile di comunicazione; 2) progettare mezzi espressivi di influenza comunicativa. La seconda componente è in continua evoluzione sotto l'influenza di compiti pedagogici e, di conseguenza, comunicativi emergenti. Nella scelta di un sistema di mezzi espressivi di comunicazione, un ruolo importante è svolto dal tipo di relazione stabilito tra l'insegnante e gli studenti.
Si possono distinguere le seguenti caratteristiche della comunicazione nel processo dell'attività pedagogica (V.A. Kann - Kalik):
Il sistema generale di comunicazione stabilito tra l'insegnante e gli studenti (un certo stile di comunicazione);
Il sistema di comunicazione caratteristico di una particolare fase dell'attività pedagogica;
sistema situazionale di comunicazione che sorge quando si risolve uno specifico compito pedagogico e comunicativo.
Lo stile della comunicazione pedagogica è una forma stabile di modi e mezzi di interazione pedagogica delle persone tra loro. AA. Lobanov comprende lo stile della comunicazione pedagogica come un sistema specifico di metodi per influenzare gli scolari da parte dell'insegnante.
VA Kann-Kalik definisce lo stile di comunicazione come caratteristiche tipologiche individuali dell'interazione socio-psicologica tra insegnante e studenti. Nello stile della comunicazione, a suo avviso, trovano espressione: a) caratteristiche delle capacità comunicative dell'insegnante; b) la natura consolidata del rapporto tra insegnante e alunni; c) l'individualità creativa dell'insegnante; d) caratteristiche del gruppo studentesco. Sottolinea che lo stile di comunicazione tra insegnante e bambini è una categoria socialmente e moralmente satura e incarna gli atteggiamenti sociali ed etici della società e dell'educatore come suo rappresentante.
Lo stile riflette il modo caratteristico dell'insegnante di rivolgersi agli studenti, le caratteristiche di presentare loro le loro esigenze e l'atteggiamento dell'insegnante nei confronti degli studenti.
Lo stile è caratterizzato dai seguenti parametri: il tono del discorso rivolto agli studenti (amichevole, indifferente o ufficiale) e la forma del discorso (ordine, domanda, consiglio, richiesta).
Lo stile della comunicazione pedagogica si manifesta anche nelle caratteristiche delle ricompense e delle punizioni dell'insegnante ai suoi alunni e studenti, stabilendo con loro una certa distanza di comunicazione.
Varie caratteristiche dello stile comunicativo dell'insegnante hanno un impatto diverso sulla natura delle esperienze emotive degli studenti, sul loro comportamento in classe ea scuola.
2.2. Tipi di stili di comunicazione pedagogica
Nella letteratura psicologica e pedagogica si distinguono più spesso 3 stili principali: autoritario, democratico e liberale.
Gli insegnanti caratterizzati da uno stile autoritario sono caratterizzati dalla soppressione dei propri alunni da parte di giudizi categorici, insindacabili e arroganza nei modi di impartire ordini e ordini. Tali insegnanti amano comandare, imporre la loro opinione, la loro volontà non solo agli scolari, ma anche ai loro genitori e ai loro colleghi. A loro importa poco delle opinioni di coloro che li circondano, quindi preferiscono il solo processo decisionale e le richieste persistenti per la loro attuazione, oppure "organizzano" una partecipazione puramente formale del team nel supportare le proprie decisioni. I sostenitori di questo stile credono che uno dei valori più importanti che dovrebbero formarsi in un bambino sia la sottomissione all'autorità di un insegnante (così come un genitore, capo, rappresentante dell'autorità). Ogni studente è obbligato a rispettare qualsiasi insegnante e ogni insegnante deve sostenere l'autorità dei colleghi in ogni modo possibile. Per il rigoroso rispetto dei requisiti, lo studente merita incoraggiamento, per la disobbedienza - punizione.
Per gli insegnanti che sono guidati da uno stile di leadership democratico, è tipico sforzarsi di fare affidamento sull'opinione dei propri reparti, tenere conto dei loro interessi, desideri e caratteristiche, risolvere con tatto e correttamente tutte le questioni e le contraddizioni emergenti con loro. A differenza delle richieste autoritarie, sono presentate in una forma delicata e corretta che non offende la dignità degli studenti. Va notato che il termine "stile democratico" non è un tributo alla moda moderna, poiché il concetto di stile democratico è stato trovato nella letteratura psicologica e pedagogica molto prima degli anni '90 del secolo scorso, quando i processi democratici iniziarono a crescere rapidamente in Russia .
I rappresentanti dello stile liberale sono caratterizzati dal desiderio di evitare situazioni di conflitto, dagli scontri con gli altri, compresi i loro studenti. Invece delle richieste, preferiscono le persuasioni e le esortazioni degli alunni, e talvolta svolgono semplicemente per loro una parte dei compiti. Questo stile può manifestarsi nella connivenza o nell'inazione dell'insegnante, nel suo ritiro dalla vita del gruppo di classe, dalla responsabilità per tutto ciò che accade in esso.
VA Kann Kalik ha stabilito gli stili più comuni di comunicazione pedagogica. Forse la più fruttuosa, a suo avviso, è la comunicazione basata sulla passione per l'attività creativa congiunta:
Al centro di questo stile c'è l'unità dell'alta professionalità dell'insegnante e dei suoi atteggiamenti etici. Dopotutto, l'entusiasmo per la ricerca creativa congiunta con gli studenti è il risultato non solo dell'attività comunicativa dell'insegnante, ma in misura maggiore del suo atteggiamento nei confronti dell'attività pedagogica in generale.
Questo stile di comunicazione ha contraddistinto le attività di V.A. Sukhomlinsky. Su questa base, formano il proprio sistema di relazioni con i bambini V.F. Shatalov, I.P. Volkov e altri.
Anche lo stile della comunicazione pedagogica basato sulla disposizione amichevole è abbastanza produttivo. Questo stile di comunicazione può essere considerato un prerequisito per il successo delle attività educative congiunte. In una certa misura, per così dire, prepara lo stile di comunicazione sopra evidenziato. Dopotutto, una disposizione amichevole è il regolatore più importante della comunicazione in generale, e in particolare della comunicazione pedagogica aziendale. Questo è uno stimolatore dello sviluppo e della fecondità del rapporto tra l'insegnante e gli studenti. La cordialità e la passione per il lavoro comune sono stili di comunicazione strettamente correlati tra loro. L'entusiasmo per una causa comune è fonte di cordialità e allo stesso tempo la cordialità, moltiplicata dall'interesse per il lavoro, dà origine a una ricerca entusiasta comune. Parlando del sistema di relazioni tra insegnante e alunni, A.S. Makarenko ha sostenuto che l'insegnante, da un lato, dovrebbe essere un compagno e un mentore senior e, dall'altro, un complice nelle attività congiunte. È necessario formare la cordialità come un certo tono nel rapporto dell'insegnante con la squadra.
Riflettendo sulle opzioni per il rapporto dell'educatore con i bambini, A.S. Makarenko ha osservato che gli insegnanti e la direzione non dovrebbero mai consentire un tono frivolo, schernire, raccontare barzellette, qualsiasi libertà nel linguaggio, mimica, buffonate, ecc. da parte loro. D'altra parte, è assolutamente inaccettabile che insegnanti e dirigenti in presenza di alunni siano cupi, irritabili, rumorosi.
La cordialità dovrebbe essere pedagogicamente opportuna, non contraddire sistema comune rapporto tra insegnante e bambini.
Abbastanza comune è la distanza di comunicazione. Questo stile di comunicazione è utilizzato sia da insegnanti esperti che da principianti. La sua essenza sta nel fatto che nel sistema di relazioni tra insegnante e studenti, la distanza funge da limitatore. Ma anche qui occorre moderazione. L'ipertrofia della distanza porta alla formalizzazione dell'intero sistema di interazione socio-psicologica tra insegnante e studenti e non contribuisce alla creazione di un'atmosfera veramente creativa. La distanza deve esistere nel sistema di relazioni tra insegnante e bambini, è necessaria. Ma dovrebbe derivare dalla logica generale del rapporto tra lo studente e l'insegnante, e non essere dettata dall'insegnante come base del rapporto. La distanza funge da indicatore del ruolo guida dell'insegnante, basato sulla sua autorità.
La trasformazione dell '"indicatore di distanza" nel dominante della comunicazione pedagogica riduce drasticamente il livello creativo complessivo del lavoro congiunto dell'insegnante e degli studenti. Ciò porta all'affermazione di un principio autoritario nel sistema di relazioni tra insegnante e bambini, che alla fine ha un effetto negativo sui risultati dell'attività. AV Petrovsky e V.V. Shpalinsky nota che nelle classi in cui gli insegnanti insegnano con una predominanza di metodi autoritari di leadership, di solito c'è una buona disciplina e rendimento scolastico, ma il benessere esterno può nascondere carenze significative nel lavoro dell'insegnante sulla formazione morale della personalità dello studente.
Qual è la popolarità di questo stile di comunicazione? Il fatto è che gli insegnanti alle prime armi spesso credono che la comunicazione-distanza li aiuti ad affermarsi immediatamente come insegnanti, e quindi usano questo stile in una certa misura come mezzo di autoaffermazione nello studente e nell'ambiente pedagogico. Ma nella maggior parte dei casi, l'uso di questo stile di comunicazione nella sua forma più pura porta a fallimenti pedagogici.
Autorità, secondo N.D. Nikandrov, dovrebbe essere vinto non attraverso l'istituzione meccanica della distanza, ma attraverso la comprensione reciproca, nel processo di un'attività creativa congiunta. E qui è estremamente importante trovare sia uno stile generale di comunicazione che un approccio situazionale a una persona.
Nel sistema dell'istruzione scolastica, lo stile di comunicazione influisce non solo sull'atteggiamento degli studenti nei confronti della materia, ma anche sull'umore generale dei bambini, sull'atmosfera del loro benessere emotivo nelle attività. Quindi, secondo A.A. Bodalev e L.I. Una zampa storta, uno stato di calma soddisfazione e gioia si verifica relativamente più spesso tra gli studenti di quei gruppi scolastici guidati da un insegnante che aderisce ai principi democratici nella sua comunicazione con gli scolari adolescenti.
Le forme democratiche di comunicazione tra insegnante e studenti hanno un effetto positivo sull'efficacia del processo educativo, principalmente perché sono più mobili, flessibili e consentono di adattarsi costantemente al metodo di influenza. sistema necessario comunicazione e, soprattutto, creare un'unità socio-psicologica dell'insegnante e degli studenti, necessaria per attività congiunte produttive.
La comunicazione-distanza in una certa misura è una fase di transizione verso una forma di comunicazione così negativa come la comunicazione-intimidazione. Questo stile di comunicazione, talvolta utilizzato anche dagli insegnanti alle prime armi, è principalmente associato all'incapacità di organizzare una comunicazione produttiva basata sulla passione. attività congiunte. Dopotutto, è difficile formare una tale comunicazione e un giovane insegnante segue spesso la linea di minor resistenza, scegliendo la comunicazione, l'intimidazione o la distanza nella sua manifestazione estrema.
In senso creativo, l'intimidazione comunicativa è generalmente inutile. In sostanza, non solo non crea un'atmosfera comunicativa che fornisce attività creativa, ma, al contrario, lo regola, poiché indirizza i bambini non a ciò che deve essere fatto, ma a ciò che non si può fare, priva la comunicazione pedagogica della cordialità, su cui si basa la comprensione reciproca, tanto necessaria per un'attività creativa congiunta .
Un ruolo altrettanto negativo nel lavoro con i bambini è svolto dalla comunicazione civettuola, anch'essa caratteristica principalmente dei giovani insegnanti e associata all'incapacità di organizzare una comunicazione pedagogica produttiva. In sostanza, questo tipo di comunicazione corrisponde al desiderio di conquistare un'autorità falsa ed economica tra i bambini, il che è contrario alle esigenze dell'etica pedagogica socialista. La comparsa di questo stile di comunicazione è causata, da un lato, dal desiderio di un giovane insegnante di stabilire rapidamente un contatto con i bambini, dal desiderio di compiacere la classe e, dall'altro, dalla mancanza delle necessarie competenze pedagogiche e cultura comunicativa, abilità, ecc. abilità di comunicazione pedagogica, esperienza di attività comunicativa professionale.
COME. Makarenko ha condannato aspramente una simile "ricerca dell'amore". Ha detto: "Rispettavo i miei assistenti e avevo solo dei geni nel lavoro educativo, ma li ho convinti che l'ultima cosa di cui hai bisogno è essere un insegnante preferito. Personalmente non ho mai raggiunto l'amore per i bambini e penso che questo amore organizzato da un insegnante per il mio piacere è un crimine...
Questa civetteria, questa ricerca dell'amore, questa vanagloria dell'amore recano grave danno all'educatore e all'educazione. Ho convinto me stesso ei miei compagni che questo ciondolo ... non dovrebbe essere nella nostra vita ...
Lascia che l'amore arrivi impercettibilmente, senza i tuoi sforzi. Ma se una persona vede l'obiettivo nell'amore, allora questo è solo un danno ... ".
Il flirt comunicativo, come mostrano le osservazioni, nasce di conseguenza; a) incomprensione da parte dell'insegnante dei responsabili che lo affrontano - compiti pedagogici; b) mancanza di capacità comunicative; c) paura della comunicazione con la classe e allo stesso tempo desiderio di stabilire un contatto con gli studenti. Come si può vedere, anche l'ignoranza della tecnologia della comunicazione, la mancanza da parte dell'insegnante dei metodi di comunicazione necessari giocano un certo ruolo.
Stili di comunicazione come l'intimidazione, il flirt e le forme estreme di comunicazione-distanza sono anche pericolosi perché, se l'insegnante non ha capacità comunicative professionali, possono attecchire e "mangiare" la personalità creativa dell'insegnante, e talvolta diventare cliché che complicare il processo pedagogico e ridurlo efficienza.
Psicologo K.N. Volkov ha individuato i seguenti requisiti che lo studente pone all'insegnante come prerequisiti per l'emergere di un senso di fiducia: contatto, capacità di entrare facilmente e in modo flessibile in comunicazione con i bambini, democratizzazione dello stile di leadership, che comporta una combinazione di rispetto per la personalità di ogni studente con la necessaria esattezza; comprensione, pazienza, varietà di interessi, capacità di stare al passo con i tempi, erudizione, sensibilità, capacità di entrare in empatia - in una parola, tutto ciò che può aprire l'anima di una persona in crescita verso un educatore.
Negli stili comunicativi produttivi, la logica della comunicazione, sollecitata da A.S. Makarenko: Non sono tanto un insegnante quanto un anziano che conduce la vita dei suoi allievi con la loro stessa partecipazione. Naturalmente, questo approccio presuppone una comunicazione amichevole tra insegnante e studenti sulla base dell'entusiasmo per le attività congiunte.
Lo stile di comunicazione influisce direttamente sull'atmosfera di benessere emotivo nel team, che, a sua volta, determina in gran parte l'efficacia delle attività educative. Il processo più fecondo di educazione e formazione è assicurato da un sistema di relazioni costruito in modo sicuro.
Ma nel nostro studio faremo affidamento sulla classificazione degli stili proposta da A.K. Makova e A.Ya. Nikonova.
La differenza di stile si basava sui seguenti motivi: le caratteristiche di contenuto dello stile (l'orientamento predominante dell'insegnante sul processo o il risultato del suo lavoro, lo spiegamento da parte dell'insegnante delle fasi indicative e di controllo e valutazione nel suo lavoro); caratteristiche dinamiche dello stile (flessibilità, stabilità, commutabilità, ecc.); prestazioni (il livello di conoscenza e capacità di apprendimento degli scolari, nonché l'interesse degli studenti per la materia). Sulla base di ciò, hanno individuato 4 stili di comunicazione pedagogica:
1. Emotivamente - stile di improvvisazione (EIS). Gli insegnanti con si distinguono per un orientamento predominante al processo di apprendimento. Un tale insegnante costruisce una spiegazione del nuovo materiale in modo logico e interessante, tuttavia, nel processo di spiegazione, spesso gli manca il feedback degli studenti. Durante il sondaggio, l'insegnante con EIS si rivolge principalmente a un gran numero di studenti
Il forte, interessato a lui, li interroga a ritmo serrato, fa domande informali, ma non permette loro di parlare molto, non aspetta che formulino da soli una risposta. Un insegnante con EIS è caratterizzato da una pianificazione insufficientemente adeguata del processo educativo. Per allenarsi nella lezione sceglie il materiale didattico più interessante; materiale meno interessante, sebbene importante, lascia analisi indipendenti da parte degli studenti. Nelle attività di un insegnante con EIS, il consolidamento e la ripetizione del materiale didattico, il controllo delle conoscenze degli studenti non sono sufficientemente rappresentati. Gli insegnanti con EIS si distinguono per l'elevata efficienza, l'uso di un ampio arsenale di vari metodi di insegnamento. Pratica spesso discussioni collettive, stimola dichiarazioni spontanee degli studenti. Un insegnante con EIS è caratterizzato dall'intuitività, che si esprime nella frequente incapacità di analizzare le caratteristiche e l'efficacia delle proprie attività in classe.
2. Stile emotivamente metodico (EMS). Un insegnante con EMS è caratterizzato da un orientamento al processo e ai risultati dell'apprendimento, un'adeguata pianificazione del processo educativo, un'elevata efficienza e una certa predominanza dell'intuitività sulla riflessività. Concentrandosi sia sul processo che sui risultati dell'apprendimento, tale insegnante pianifica adeguatamente il processo educativo, elabora gradualmente tutto il materiale didattico, monitora attentamente il livello di conoscenza di tutti gli studenti (sia forti che deboli), il consolidamento e la ripetizione sono costantemente presentati in le sue attività materiale didattico, controllo delle conoscenze degli studenti. Un tale insegnante si distingue per l'elevata efficienza, cambia spesso i tipi di lavoro durante la lezione, pratica discussioni di gruppo. Utilizzando lo stesso ricco arsenale di tecniche metodologiche nell'elaborare materiale educativo come insegnante con EIS, un insegnante con EMS, a differenza di quest'ultimo, cerca di attivare i bambini non con intrattenimento esterno, ma è fermamente interessato alle caratteristiche della materia stessa .
3. Stile di ragionamento e improvvisazione (RIS). Un insegnante con RIS è caratterizzato da un orientamento al processo e ai risultati dell'apprendimento, un'adeguata pianificazione del processo educativo. Rispetto agli insegnanti di stili emotivi, un insegnante con RIS mostra meno ingegnosità nella selezione e variazione dei metodi di insegnamento, non è sempre in grado di fornire un ritmo di lavoro elevato, pratica raramente discussioni collettive, il tempo relativo di discorso spontaneo dei suoi studenti durante lezioni è inferiore a quello degli insegnanti con stile emotivo. Un insegnante con RIS parla meno se stesso, soprattutto durante un sondaggio, preferendo influenzare indirettamente gli studenti (attraverso suggerimenti, chiarimenti, ecc.), dando la possibilità agli intervistati di formulare una risposta dettagliata.
4. Stile ragionamento-metodico (RMS). Concentrandosi principalmente sui risultati dell'apprendimento e pianificando adeguatamente il processo educativo, un insegnante con DMS mostra conservatorismo nell'uso di mezzi e metodi dell'attività pedagogica. L'alta metodologia (consolidamento sistematico, ripetizione del materiale didattico, controllo della conoscenza degli studenti) è combinata con un piccolo insieme standard di metodi di insegnamento utilizzati, preferenza per l'attività riproduttiva degli studenti e rare discussioni di gruppo. Nel corso del colloquio, l'insegnante con RMS si rivolge a un numero ristretto di studenti, dando a ciascuno studente molto tempo per rispondere, prestando particolare attenzione agli studenti deboli. Un insegnante con RMS è generalmente riflessivo.
Così, vediamo che lo stile è una caratteristica importante della comunicazione pedagogica. Va sottolineato che lo stile di comunicazione tra insegnante e bambini è una categoria sociale e morale. La comunicazione più fruttuosa si basa sull'entusiasmo per le attività congiunte. Questo tipo di comunicazione si forma sulla base di atteggiamenti professionali ed etici elevati, sulla base del suo atteggiamento nei confronti dell'attività pedagogica in generale. Padroneggiare le basi della comunicazione pedagogica è il compito creativo dell'insegnante. Deve risolverlo trovando il suo stile individuale comunicazione.
Capitolo 3. Identificazione degli stili di comunicazione pedagogica tra gli insegnanti di materia
Lo studio accertativo degli stili di comunicazione pedagogica è strettamente connesso con i processi formativi svolti su base diagnostica.
IN lavoro di ricerca sono stati utilizzati i seguenti metodi:
Analisi teorica della letteratura psicologica e pedagogica sui problemi.
Monitoraggio dell'andamento della lezione.
Test VF Ryakhovsky per determinare le caratteristiche comunicative (vedi Appendice 1).
Questionario per l'insegnante per analizzare le caratteristiche dello stile individuale della sua attività pedagogica.
Interviste ai docenti della materia.
Il lavoro pratico è stato svolto sulla base della scuola secondaria MOU n. 1. Lo studio ha coinvolto 10 insegnanti di materie che insegnano nella classe 11th: un insegnante di algebra/geometria, un insegnante di fisica, un insegnante di biologia, un insegnante di chimica, un insegnante di lingua e letteratura russa, un insegnante di storia e scienze sociali, un insegnante di informatica, un fisico insegnante di educazione, un insegnante in inglese e insegnante di francese.
L'ipotesi del nostro studio era la seguente: "La maggior parte degli insegnanti di materie che insegnano in terza media preferisce uno stile di interazione con gli studenti ragionamento - metodico (RMS), che porta a un rapporto teso tra loro e gli studenti della classe".
Nel processo di lavoro sono state analizzate varie fonti sui temi degli stili di comunicazione pedagogica, sono stati scelti metodi per studiare aspetti della personalità dell'insegnante.
Abbiamo frequentato 10 lezioni con ogni insegnante. Dopo ogni lezione, è stata analizzata l'interazione dell'insegnante con gli studenti per determinare il suo stile di comunicazione pedagogica secondo la classificazione di A.K. Markova e A.Ya. Nikandrova.
Di conseguenza, è emerso che il 30% degli insegnanti preferisce uno stile di interazione ragionato e metodico con gli studenti, si concentra principalmente sui risultati dell'apprendimento e mostra conservatorismo nell'uso di mezzi e metodi dell'attività pedagogica. Durante il sondaggio, viene chiesto a un numero ristretto di studenti, prestando attenzione agli studenti deboli.
L'altro 30% degli insegnanti sceglie uno stile di ragionamento - improvvisazione, sono anche guidati dal processo e dai risultati dell'apprendimento, come gli insegnanti con DMS, preferiscono influenzare gli studenti attraverso suggerimenti, chiarimenti.
Il 20% degli insegnanti interagisce con gli studenti utilizzando uno stile emozionale-improvvisativo. Questi insegnanti conducono le loro lezioni in modo interessante: selezionano materiale interessante, lo costruiscono in modo logico, lo presentano bene, ma il sondaggio viene svolto a un ritmo veloce, viene chiesto solo agli studenti forti e gli studenti sono incoraggiati a esprimersi.
Infine, il restante 20% degli insegnanti preferisce lo stile emotivamente metodico. Sono caratterizzati da un orientamento al processo e ai risultati dell'apprendimento, monitorano il livello di conoscenza di tutti gli studenti, cambiano spesso i tipi di lavoro durante la lezione e si sforzano di interessare i bambini alla loro materia.
Inoltre, agli insegnanti è stato chiesto di rispondere alle domande del test Ryakhovsky, volto a determinare il livello di socialità (vedi Appendice 1). Il test è composto da 16 domande, le risposte sono valutate su una scala a 2 punti ("sì" - 2 punti, "a volte" - 1 punto, "no" - 0 punti). Il classificatore di risposta è composto da 7 livelli, che determinano il grado di sviluppo delle capacità comunicative del rispondente. Come risultato dello studio, sono stati ottenuti i seguenti dati: il livello di sviluppo è inferiore alla media - 20% degli insegnanti, il normale livello di sviluppo delle capacità comunicative - 60% degli insegnanti, l'alto livello di sviluppo delle capacità comunicative - 20 % di insegnanti.
Risultati molto interessanti sono stati ottenuti dopo aver elaborato il questionario per l'insegnante per analizzare le caratteristiche dello stile individuale della sua attività pedagogica (vedi Appendice 2). Consiste in 33 domande a cui bisogna rispondere scegliendo la risposta più appropriata. Il maggior numero di risposte "sì" in una delle colonne indica con un certo grado di probabilità che l'insegnante ha una predominanza dello stile indicato in questa colonna.
Il 40% degli insegnanti delle materie ha valutato il proprio stile di comunicazione pedagogica come Ragionamento - stile di improvvisazione, anche il 40% - come Emotivamente - stile metodico, e solo il 20% - come Emotivamente - stile di improvvisazione.
Successivamente, si è svolta una conversazione individuale con ciascun insegnante, il cui scopo era, insieme a lui, riassumere e determinare il vero (per quanto oggettivamente possibile) stile di comunicazione pedagogica con gli studenti secondo il classificazione di A.K. Markova e A.Ya. Nikonova. Inoltre, ogni insegnante ha concordato con i risultati delle nostre osservazioni e ha preso nota delle raccomandazioni per ottimizzare il proprio stile di comunicazione pedagogica con gli studenti.
Pertanto, la nostra ipotesi di ricerca è stata confermata solo parzialmente - solo il 30% degli insegnanti sceglie uno stile di ragionamento - metodico. Un altro 30% degli insegnanti sceglie uno stile di ragionamento - improvvisazione. Ma alla fine il 60% dei docenti sceglie rapporti conservativi con gli studenti, stili che comportano meno ingegnosità nella selezione e variazione di modalità didattiche che non sempre sono in grado di garantire un ritmo di lavoro elevato. Questo, a nostro avviso, può portare a relazioni tese con gli studenti dell'11 ° grado, che, a causa dell'attuale situazione sociale nel nostro Paese, sono cresciuti in un clima di maggiore permissività, meno atteggiamenti nei confronti delle autorità e desiderio di stabilire rapporti paritari, che tali stili di comunicazione pedagogica non possono fornire, come riso e rms.
Stile di improvvisazione emotiva. Hai molti vantaggi: un alto livello di conoscenza, abilità artistica, contatto, intuizione, la capacità di insegnare materiale educativo in modo interessante, di affascinare gli studenti con la materia insegnata, di guidare il lavoro di squadra, di variare varie forme e metodi di insegnamento. Le tue lezioni si distinguono per un clima psicologico favorevole.
Tuttavia, la vostra attività è anche caratterizzata da alcune carenze: mancanza di metodologia (rappresentanza insufficiente nella vostra attività di consolidamento e ripetizione del materiale didattico, controllo delle conoscenze degli studenti). Forse un'attenzione insufficiente al livello di conoscenza degli studenti deboli, esigenza insufficiente, alta autostima, dimostratività, maggiore sensibilità, che causa la tua eccessiva dipendenza dalla situazione nella lezione.
Di conseguenza, i tuoi studenti hanno un interesse persistente per la materia studiata e un'elevata attività cognitiva combinata con conoscenze fragili, capacità di apprendimento insufficientemente formate.
Sta a te superare queste carenze.
Ti consigliamo di ridurre leggermente il tempo dedicato alla spiegazione del nuovo materiale; nel processo di spiegazione, controlla attentamente come viene assimilato il materiale (per questo, a determinati intervalli, puoi chiedere agli studenti di ripetere ciò che è stato detto o rispondere alle domande). Non procedere mai allo studio di nuovo materiale senza essere sicuri che il precedente sia stato padroneggiato da tutti gli studenti. Sii attento al livello di conoscenza degli studenti deboli. Elabora attentamente tutto il materiale didattico, prestando grande attenzione al consolidamento e alla ripetizione. Non aver paura e non evitare tipi di lavoro "noiosi": elaborare regole, ripetizioni.
Cerca di attivare gli studenti non con intrattenimento esterno, ma per suscitare il loro interesse per le caratteristiche della materia stessa.
Durante il sondaggio, dedica più tempo alla risposta di ogni studente, ottieni la risposta corretta, non correggere mai subito gli errori: lascia che l'errore formuli e corregga chiaramente la sua risposta, e tu lo aiuti con chiarimenti e aggiunte. Fornisci sempre una valutazione dettagliata e obiettiva di ogni risposta.
Aumenta le tue richieste. Assicurati che gli studenti rispondano e completino i test da soli, senza chiedere suggerimenti o sbirciare.
Prova a pianificare la lezione in dettaglio, esegui il piano pianificato e analizza le tue attività nella lezione.
Stile emotivamente metodico. Ti distingui per molti vantaggi: un alto livello di conoscenza, contatto, intuizione, alta metodicità, esigenza, capacità di insegnare materiale educativo in modo interessante, capacità di attivare gli studenti, suscitare il loro interesse per le caratteristiche della materia, uso sapiente e variazione di forme e metodi di insegnamento.
Di conseguenza, i tuoi studenti combinano solide conoscenze con un'elevata attività cognitiva e capacità di apprendimento articolate.
Tuttavia, hai anche alcuni difetti: un'autostima un po 'sopravvalutata, un po' di dimostratività, una maggiore sensibilità, che causano la tua eccessiva dipendenza dalla situazione della lezione, dall'umore e dalla preparazione degli studenti.
Ti consigliamo di provare a parlare meno in classe, dando la possibilità ai tuoi studenti di esprimersi appieno, non correggendo subito le risposte errate, ma attraverso numerose precisazioni, aggiunte, accenni, per far sì che il rispondente corregga e formalizzi la sua risposta. Offri la tua formulazione solo quando è veramente necessario.
Cerca di essere il più sobrio possibile.
Stile di ragionamento e improvvisazione. Hai molti vantaggi: un alto livello di conoscenza, contatto, intuizione, precisione, capacità di insegnare in modo chiaro e chiaro materiale educativo, un'attitudine attenta al livello di conoscenza di tutti gli studenti, autostima obiettiva, moderazione.
I tuoi studenti combinano l'interesse per la materia studiata con solide conoscenze e capacità di apprendimento ben formate. Tuttavia, la vostra attività è caratterizzata anche da alcune carenze: diversità non sufficientemente ampia nelle forme e nei metodi di insegnamento, scarsa attenzione al costante mantenimento della disciplina in classe.
Dedichi molto tempo alla risposta di ogni studente, assicurati che formuli la sua risposta in dettaglio, la valuti obiettivamente, il che aumenta l'efficacia del tuo lavoro. Allo stesso tempo, questo modo di condurre il sondaggio provoca un certo rallentamento nel ritmo della lezione. Questa carenza può essere compensata da un uso più esteso di una varietà di metodi di lavoro.
Raccomandiamo di mostrare più intolleranza alle violazioni della disciplina in classe. Richiedi immediatamente e severamente il silenzio in ogni lezione, e alla fine non dovrai fare tante osservazioni disciplinari.
Stile ragionamento-metodico. Hai molti vantaggi: alta metodicità, attitudine attenta al livello di conoscenza di tutti gli studenti, elevate esigenze.
Tuttavia, la tua attività è anche caratterizzata da alcune carenze: l'incapacità di mantenere costantemente l'interesse degli studenti per la materia studiata, l'uso serie standard forme e metodi di insegnamento, preferenza per le attività riproduttive piuttosto che produttive degli studenti, atteggiamento emotivo instabile nei confronti degli studenti.
Di conseguenza, i tuoi studenti combinano capacità di apprendimento ben formate e solide conoscenze con una mancanza di interesse per la materia studiata. Rimanere nelle tue lezioni per molti di loro è noioso e non sempre interessante. Spesso non c'è un clima psicologico favorevole nelle tue lezioni.
Sta a te superare queste carenze.
Cerca di espandere il tuo arsenale di metodi di insegnamento, di variare più ampiamente le varie forme di lezioni. Se stai insegnando lingua straniera, non limitarti solo ai tipi di lavoro riproduttivo: memorizzare testi, memorizzare regole. Se li usi solo, i tuoi studenti perderanno interesse per la materia e, soprattutto, si distingueranno per un debole orientamento nella lingua. Prova a utilizzare vari esercizi per attivare le abilità linguistiche: dialoghi situazionali, giochi linguistici, canzoni, poesie, filmine.
Se insegni discipline umanistiche, pratica discussioni di gruppo più spesso, scegli argomenti per loro che possano affascinare gli studenti.
Inoltre, per aiutare l'insegnante a cambiare il suo stile di comunicazione pedagogica, puoi consigliare quanto segue:
Per interagire con successo con gli scolari, si dovrebbe, prima di tutto, valutare adeguatamente la propria personalità. La conoscenza di sé, l'autogestione dovrebbero essere la preoccupazione costante di ogni insegnante. La capacità di gestire il proprio stato emotivo richiede un'attenzione speciale: processo educativo un tono irritabile, la predominanza di emozioni negative, un grido fa male. Dovresti sempre essere consapevole di ciò che viene portato nella situazione di conflitto dall'insegnante stesso.
Le relazioni pedagogicamente opportune si costruiscono sul rispetto reciproco dell'insegnante e degli studenti, sull'affermazione della dignità della personalità degli scolari e della dignità dell'insegnante. È necessario rispettare l'individualità di ogni studente, capirlo, creare le condizioni per la sua autoaffermazione agli occhi dei suoi coetanei, sostenere lo sviluppo di tratti positivi della personalità.
L'insegnante deve anche occuparsi di un'auto-presentazione favorevole: mostrare ai bambini la forza della loro personalità, hobby, abilità, ampiezza di erudizione, senza far risaltare, ovviamente, i loro meriti.
In considerazione del fatto che un elemento caratteristico della comunicazione è l'incertezza associata a informazioni insufficienti sullo stato mentale e sui motivi del comportamento dello studente, l'insegnante dovrebbe sviluppare l'osservazione, l'immaginazione pedagogica, la capacità di comprendere lo stato emotivo, l'espressione del comportamento, e interpretarlo correttamente. Un approccio creativo all'analisi delle situazioni e al prendere decisioni si basa sulla capacità dell'insegnante di accettare il ruolo di un altro - uno studente, genitori, colleghi - per assumere il loro punto di vista.
Un indicatore importante della padronanza della comunicazione tra un insegnante e gli scolari in classe e fuori è un aumento dell'attività vocale degli studenti riducendo l'attività vocale dell'insegnante, riducendo il silenzio improduttivo e aumentando il numero di contatti (domande e risposte). L'attivazione della comunicazione è facilitata dall'uso di ripetizioni dei pensieri degli scolari, riferimenti alle dichiarazioni degli studenti e dalla riduzione dei requisiti diretti.
Anche con piccoli successi, i ragazzi dovrebbero essere generosi con le lodi. È necessario lodare in presenza della squadra, ed è meglio incolpare in privato. Allo stesso tempo, il discorso dell'insegnante non dovrebbe essere "anemico". E anche se non hai una voce, gesti, espressioni facciali e uno sguardo possono aiutarti.
Se, dopo aver iniziato a lavorare, per qualche tempo ancora non ti accorgi dei turni che speravi, continua a non abusare delle lamentele sugli studenti, non iniziare la conversazione con lamentele. Il vostro compito è rendere i genitori alleati delle vostre intenzioni pedagogiche, per chiamarli alla contemplazione. E questo è possibile solo se l'insegnante mostra un sincero interesse per il destino dello studente, preoccupazione per lui, rispetto per l'opinione dei genitori e desiderio di collaborare. È necessario portare più spesso gioia alla famiglia, essere il suo aiuto e non cercare in faccia ai genitori un mezzo di rappresaglia per la propria impotenza nel comunicare con i bambini.
Un insegnante alle prime armi spesso non ha la capacità di capire a causa dell'inutilità della conversazione o, peggio, delle domande prive di tatto. Il contenuto della conversazione dovrebbe essere interessante per entrambe le parti e l'insegnante stesso dovrebbe occuparsene. Hai "opzioni" per tali conversazioni?
Poiché le situazioni nel corso della lezione e delle attività extrascolastiche non si ripetono completamente, è impossibile fornire ricette esatte per risolvere qualsiasi problema che si presenti nella pratica dell'insegnante. Puoi formare atteggiamenti verso un certo stile di comportamento, che in condizioni reali sollecitare una risposta razionale alla situazione che si è venuta a creare.
Quando si comunica con gli scolari, bisogna ricordare di mantenere l'autorità dei colleghi al lavoro. La perdita dell'autorità di un collega può, in una certa misura, essere un indebolimento della tua influenza pedagogica personale sui ragazzi.
CONCLUSIONI
1. Il problema dello studio dei vari aspetti della comunicazione pedagogica trova la sua ampia diffusione nelle opere di un'intera galassia di insegnanti del XX secolo.
2. La comunicazione pedagogica è sempre un processo mirato. Gli obiettivi di tale comunicazione sono: 1) creare le condizioni per l'interazione materia-materia con i loro studenti e i loro genitori, con colleghi e rappresentanti di varie amministrazioni e organizzazioni pubbliche; 2) "leggere" e comprendere sia il proprio comportamento che la comunicazione di tutti i soggetti della comunicazione pedagogica al fine di utilizzare la propria alfabetizzazione comportamentale per familiarizzare i propri partner con i valori culturali della società.
3. Nella comunicazione vengono implementate molte funzioni diverse, ognuna delle quali è importante nelle attività professionali di un insegnante.
4. Una caratteristica importante della comunicazione sono i mezzi di comunicazione, che possono essere rappresentati come modi per trasmettere informazioni ed esprimere relazioni tra partner nel processo della loro interazione.
5. La struttura della comunicazione pedagogica rappresenta le fasi dell'interazione dell'insegnante con i suoi studenti e alunni dispiegati nel tempo.
6. Nella letteratura psicologica e pedagogica si distinguono più spesso 3 stili principali: autoritario, democratico e liberale.
8. Per gli insegnanti con uno stile democratico, è tipico sforzarsi di fare affidamento sull'opinione dei propri reparti, tenere conto dei loro interessi, desideri e caratteristiche, risolvere con tatto e correttamente tutte le questioni e le contraddizioni emergenti con loro.
9. I rappresentanti dello stile liberale sono caratterizzati dal desiderio di evitare situazioni di conflitto, dagli scontri con gli altri, compresi i loro studenti. Invece delle richieste, preferiscono le persuasioni e le esortazioni degli alunni, e talvolta svolgono semplicemente per loro una parte dei compiti.
10. Come risultato dello studio, è emerso che il 30% degli insegnanti preferisce un ragionamento - stile metodico di interazione con gli studenti, il 30% ragionamento - improvvisazione, il 20% emotivo - improvvisazione, il 20% - emotivamente - stile metodico di comunicazione pedagogica .
CONCLUSIONE
La personalità di una persona si forma nel processo di comunicazione con le persone. Se nel periodo iniziale della vita una persona non è libera di scegliere da sé le persone che lo fanno ambiente immediato, poi in età adulta lui stesso può regolare ampiamente il numero e la composizione delle persone che lo circondano e con le quali comunica. In questo modo, una persona si fornisce un certo flusso di influenze psicologiche da questo ambiente.
Lavoro, conoscenza, comunicazione… spesso ne parliamo e li analizziamo. Ma, se ci pensi, troverai un fenomeno curioso. Una persona studia da molti anni le forme ei metodi dell'attività lavorativa, da molto tempo padroneggiamo anche i modi di conoscere il mondo, ma una persona non impara mai intenzionalmente a comunicare da nessuna parte. Non abbiamo una scuola che insegni la complessa arte della comunicazione. Certo, l'esperienza della comunicazione viene acquisita da una persona sia nel corso del lavoro che nell'attività cognitiva ... ma, ahimè. Questo non è abbastanza. Molti seri problemi di educazione e istruzione sorgono a causa dell'incapacità dell'insegnante di organizzare adeguatamente la comunicazione con i bambini.
Il problema della comunicazione pedagogica si riflette direttamente o indirettamente nelle opere di molti famosi insegnanti e psicologi: Cannes - Kalik, Egorov, Kuzmina, Bodalev, Myasishchev, Ananiev, Lobanov, Markova e molti altri autori che costituiscono una galassia di scienziati coinvolti in Questo.
Ovviamente, c'è tanta comunicazione pedagogica come fenomeno del processo educativo. Quanto è lunga la scuola istituzione sociale per l'educazione e l'educazione delle persone. Laddove almeno una persona comincerà a interagire con un'altra persona (o gruppo di persone) come insegnante-studente o educatore-allievo, sorgeranno sicuramente problemi di comunicazione pedagogica.
Una caratteristica importante della comunicazione pedagogica è il suo stile. Va sottolineato che lo stile di comunicazione tra insegnante e bambini è una categoria sociale e morale. La comunicazione più fruttuosa si basa sull'entusiasmo per le attività congiunte. Questo tipo di comunicazione si forma sulla base di atteggiamenti professionali ed etici elevati, sulla base del suo atteggiamento nei confronti dell'attività pedagogica in generale. Padroneggiare le basi della comunicazione pedagogica è il compito creativo dell'insegnante. Deve risolverlo, trovando il proprio stile di comunicazione individuale.
La capacità di trovare la giusta intonazione, espressione facciale, movimento, gesto: questo è ciò che a volte manca a un insegnante alle prime armi.
L'insegnante deve semplicemente padroneggiare la parola, i mezzi di persuasione. Questa è la chiave per risolvere molte situazioni e talvolta conflitti che sorgono nel processo delle attività educative. Non c'è da stupirsi che gli antichi greci affermassero che l'educazione non germoglia nell'anima se non penetra a una profondità considerevole. E questa penetrazione è possibile solo nell'armoniosa unità di alta professionalità, abilità recitative e oratorie dell'insegnante.
LETTERATURA
1. Batrakova S.N. Fondamenti di comunicazione professionale-pedagogica. - Yaroslavl, 1986.
2. Bodalev A.A. Psicologia della comunicazione. - M., 1996.
3. Grechnev V.S. Cultura della comunicazione pedagogica. - M., 1990.
4. Grigoryeva T.G. Fondamenti di comunicazione costruttiva. - Novosibirsk., M., 1997.
5. Dobrovich A.B. Educatore di psicologia e psicoigiene della comunicazione. - M.: Illuminismo., 1987.
6. Zagvyazinsky V.N. Creatività pedagogica dell'insegnante. - M., 1987.
7. Zimnyaya I.A. Psicologia pedagogica. - Rostov - su - Don:. "Fenice"., 1997.
8. Ilyin E.N. L'arte della comunicazione. - M., 1982.
9. Cannes - Kalik VA Insegnante di comunicazione pedagogica. - M., "Illuminismo"., 1987.
10. Cannes - Kalik VA, Nikandrov ND Creatività pedagogica. - M., "Pedagogia"., 1990.
11. Kondratyeva S.V. Da insegnante a studente. - M., 1984.
12. Leontyev A.A. comunicazione pedagogica. - M., 1979.
13. Lisina M.I. Il problema dell'ontogenesi della comunicazione. - M., "Pedagogia"., 1986.
14. Lobanov A.A. Pedagogia della comunicazione. - Vladimir, 1995.
15. Lobanov A.A. Fondamenti di comunicazione professionale-pedagogica. - M, Accademia., 2002.
16. Makarenko A.S. Il problema dell'istruzione scolastica sovietica. Ped. cit.: in 8 volumi - M., 1984. - V.4.
17. Markova A.K. Psicologia del lavoro dell'insegnante. M, Illuminismo. 1993.
18. Mitina L.M. L'insegnante come persona e professionista. M., 1991.
19. Mudrik A.V. Insegnante: abilità e ispirazione. M, "Illuminismo"., 1986.
20. Fondamenti di eccellenza pedagogica / Ed. I.A. Zyazyun. M "Illuminismo"., 1089.
21. Pedagogia / Sotto la direzione di Yu.K. Babansky. - M., 1983.
22. Petrovskaya LA Competenza nella comunicazione: formazione socio-psicologica. - M., 1989.
23. Dizionario psicologico e pedagogico / Sotto la direzione di V.A. Mezherikov. - Rostov - sul Don, "Phoenix", 1998.
24. Rean A.A. Psicologia dell'attività pedagogica. - Iževsk., 1994.
25. Rydanova II. Fondamenti di pedagogia della comunicazione. - Minsk, 1998.
26. Sukhomlinsky V.A. Conversazione con il giovane direttore della scuola. - M., 1982.
27. Shchurkova N.E. Sei diventato un insegnante di classe. - M.: Pedagogia., 1986.
Istruzione:
Per determinare il coefficiente della tua socievolezza, devi rispondere a 16 domande. La risposta deve essere univoca: "sì", "no", "a volte".
Hai una riunione ordinaria o di lavoro. La sua attesa ti turba?
Stai rimandando una visita dal dottore fino all'ultimo momento?
Ti senti imbarazzato e insoddisfatto dell'incarico di fare un rapporto, un rapporto, informazioni a qualsiasi conferenza, riunione o evento simile?
Ti viene offerto di fare un viaggio d'affari in una città dove non sei mai stato. Farai ogni sforzo per evitare questo viaggio di lavoro?
Ti piace condividere le tue esperienze con qualcuno?
Ti arrabbi se uno sconosciuto per strada si rivolge a te con una richiesta (indica la strada, indica l'ora, rispondi a qualche domanda)?
Credi che ci sia un problema di "padri e figli" e che sia difficile per persone di generazioni diverse capirsi?
Ti vergogni a ricordare a un amico che si è dimenticato di restituirti 10 rubli, che ha preso in prestito qualche mese fa?
In un ristorante o in sala da pranzo ti veniva servito un piatto chiaramente di scarsa qualità. Rimarrai in silenzio, spingendo via solo con rabbia il piatto?
10. Una volta da solo con uno sconosciuto, non entrerai in una conversazione con lui e sarai oppresso se parla per primo. È così?
11. Sei inorridito da qualsiasi lunga fila, non importa dove sia (in un negozio, in biblioteca, al botteghino del cinema). Preferiresti rinunciare alla tua intenzione o rimarresti indietro e languiresti in attesa?
12. Hai paura di partecipare a qualsiasi comitato per la risoluzione dei conflitti?
13. Hai i tuoi criteri puramente individuali per valutare le opere di letteratura, arte, cultura e non accetti le opinioni di altre persone su questo argomento. Questo è vero?
14. Avendo sentito da qualche parte in disparte un punto di vista palesemente errato su una questione a te ben nota, preferiresti anche tu tacere e non entrare in polemica?
Ti senti frustrato quando qualcuno ti chiede di aiutare a risolvere un particolare problema di servizio o argomento di studio?
Sei più disposto a esprimere il tuo punto di vista (opinione, valutazione) per iscritto che oralmente?
30-32 punti. Sei chiaramente poco comunicativo, e questa è la tua sfortuna, poiché tu stesso ne soffri di più. Ma non è facile per le persone a te vicine. È difficile fare affidamento su di te in una questione che richiede uno sforzo di gruppo. Cerca di diventare più socievole, controlla te stesso.
25-29 punti. Sei chiuso, taciturno, preferisci la solitudine e quindi probabilmente hai pochi amici. Nuovo lavoro e il bisogno di nuovi contatti, se non ti fa precipitare nel panico, ti sbilancia a lungo. Conosci questa caratteristica del tuo carattere e sei insoddisfatto di te stesso. Ma non limitarti a tale malcontento: è in tuo potere invertire questi tratti caratteriali. Non succede che con un forte entusiasmo acquisisci improvvisamente una completa socievolezza? Ci vuole solo una scossa.
19-24 punti. Sei socievole in una certa misura e ti senti abbastanza sicuro in un ambiente sconosciuto. Le nuove sfide non ti spaventano. Eppure con nuove persone convergono con cautela, sei riluttante a partecipare a controversie e controversie. A volte c'è troppo sarcasmo nelle tue affermazioni, senza alcun fondamento. Queste carenze sono correggibili.
14-18 punti. Hai buone capacità comunicative. Sei curioso, ascolti volentieri un interlocutore interessante, abbastanza paziente nel trattare con gli altri, difendi il tuo punto di vista senza irascibilità. Sentiti libero di incontrare nuove persone. Allo stesso tempo, non ti piacciono le compagnie rumorose; buffonate stravaganti e verbosità ti infastidiscono.
9-13 punti. Sei molto socievole (a volte, forse anche oltre misura). Curioso, loquace, ama parlare di varie questioni, il che a volte irrita gli altri. Conoscere volentieri nuove persone. Ama essere al centro dell'attenzione, non rifiutare le richieste a nessuno, anche se non puoi sempre soddisfarle. Succede, divampa, ma allontanati rapidamente. Ciò che ti manca è la perseveranza, la pazienza e il coraggio di fronte a problemi seri. Se lo desideri, tuttavia, puoi sforzarti di non tirarti indietro.
4-8 punti. Devi essere il ragazzo della camicia. La socievolezza batte fuori di te. Sei sempre consapevole di tutto. Mi piace prendere parte a tutte le discussioni, anche se gli argomenti seri possono darti emicranie e persino malinconia. Prendi volentieri la parola su qualsiasi questione, anche se ne hai un'idea superficiale. Ovunque ti senti a tuo agio. Affronta qualsiasi attività, anche se non puoi sempre portarla a termine con successo. Proprio per questo, dirigenti e colleghi ti trattano con qualche apprensione e dubbio. Considera questi fatti!
3 punti o meno. Le tue capacità di comunicazione sono dolorose. Sei loquace, prolisso, interferisci in questioni che non hanno nulla a che fare con te. Ti impegni a giudicare problemi in cui sei completamente incompetente. Volenti o nolenti, spesso sei la causa di ogni sorta di conflitto nel tuo ambiente. Irascibile, permaloso, spesso di parte. Il lavoro serio non fa per te. Le persone - e al lavoro, a casa e in generale ovunque - è difficile con te. Sì, devi lavorare su te stesso e sul tuo personaggio! Prima di tutto, coltiva la pazienza e la moderazione in te stesso, tratta le persone con più rispetto; Infine, pensa alla tua salute: questo stile di vita non passa inosservato.
Questionario per l'insegnante per analizzare le caratteristiche dello stile individuale della sua attività pedagogica
Istruzione. Le risposte alle seguenti domande ti aiuteranno a identificare il tuo stile di lavoro individuale. Per fare ciò, nel questionario proposto, spunta le opzioni di risposta che ti si addicono (se due o tre opzioni corrispondono, controlla tutte le colonne). Contando il numero di caselle di controllo in ciascuna colonna, puoi determinare il tuo stile di lavoro (colonna con il numero massimo zecche).
| Domande | Opzioni di risposta | |||
| EIS | CEM | RISO | RMS | |
| Fai un programma dettagliato della lezione? | NO | SÌ | NO | SÌ |
| Pianifichi la lezione solo in termini generali? | SÌ | NO | SÌ | NO |
| Ti discosti spesso dal programma della lezione? | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
| Ti discosti dal piano quando noti una lacuna nella conoscenza degli studenti o difficoltà nell'apprendimento del materiale? | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
| Dedichi la maggior parte della lezione alla spiegazione del nuovo materiale? | ||||
| Monitori costantemente come viene assorbito nuovo materiale durante la spiegazione? | ||||
| Quanto spesso fai domande agli studenti mentre spieghi? | ||||
| Durante il sondaggio, quanto tempo dedichi alla risposta di ogni studente? | ||||
| Ottieni sempre risposte assolutamente corrette? | ||||
| Convinci sempre l'intervistato a correggere la risposta da solo? | ||||
| Usi spesso materiale didattico aggiuntivo quando spieghi? | ||||
| Cambi spesso argomento in classe? | ||||
| Permetti che un sondaggio tra studenti si trasformi spontaneamente in una discussione collettiva o in una spiegazione di nuovo materiale? | ||||
| Rispondi immediatamente alle domande inaspettate degli studenti? | ||||
| Monitorate costantemente l'attività di tutti gli studenti durante il sondaggio? | ||||
| L'impreparazione o l'umore degli studenti durante la lezione possono farti perdere l'equilibrio? | ||||
| Correggi sempre tu stesso gli errori degli studenti? | ||||
| Rientri sempre nell'ambito della lezione? | NO | NO | SÌ | SÌ |
Continuazione della tabella.
| Ti assicuri rigorosamente che gli studenti rispondano e completino il lavoro di prova da soli: senza suggerimenti, senza sbirciare nel libro di testo? | ||||
| Valuti sempre ogni risposta nel dettaglio? | ||||
| Le tue esigenze per studenti forti e deboli differiscono nettamente? | ||||
| Quanto spesso premi le buone risposte? | ||||
| Incolpi spesso gli studenti per le risposte sbagliate? | ||||
| Quanto spesso supervisioni le conoscenze degli studenti? | ||||
| Quanto spesso rivedi ciò che hai imparato? | ||||
| Puoi passare all'argomento successivo senza essere sicuro che tutti gli studenti abbiano imparato il materiale precedente? | ||||
| Pensi che gli studenti siano solitamente interessati alle tue lezioni? | ||||
| Pensi che agli studenti di solito piacciano le tue lezioni? | ||||
| Mantieni costantemente alto il ritmo della lezione? | ||||
| Sei preoccupato per gli studenti che non fanno i compiti? | SÌ | NO | NO | |
| Esigete sempre il rigoroso rispetto della disciplina durante le lezioni? | NO | SÌ | NO | SÌ |
| Sei distratto dal "rumore di lavoro" in classe? | NO | SÌ | NO | SÌ |
| Analizzi spesso le tue attività in classe? | NO | SÌ | NO | SÌ |
Nota. Il maggior numero di risposte "sì" in una delle colonne indica con un certo grado di probabilità che l'insegnante ha una predominanza dello stile indicato in questa colonna.
Psicologia della comunicazione e delle relazioni interpersonali Ilyin Evgeny Pavlovich
17.1. Caratteristiche della comunicazione pedagogica
Rean A.A., Kolominsky Ya.L. Psicologia sociopedagogica. SPb., 1999, pag. 303.
Gli insegnanti hanno spesso un modo di comunicare perentorio. Si manifesta nel desiderio dell'insegnante di parlare agli studenti con un tono ufficiale, spesso di mentoring, con frasi dure e categoriche, con una faccia senza sorriso, come: "Non vuoi capire niente!", "Non voglio consenti le mie lezioni…”, “Non ti lascerò…” ecc.
Intensità comunicativa. Secondo gli psicologi, un insegnante ha in media più di mille contatti di comunicazione al giorno lavorativo. Tuttavia, l'intensità della comunicazione con gli studenti negli insegnanti può essere diversa. Alcuni insegnanti sono caratterizzati da una comunicazione a bassa intensità, che peraltro è di natura ufficiale. La loro comunicazione è principalmente legata al trasferimento delle informazioni educative più importanti. Questo modo di comunicare sottolinea il rigore e l'efficienza di questi insegnanti.
Altri insegnanti hanno un'alta intensità di comunicazione volta a stabilire rapporti commerciali con gli studenti. Questi insegnanti sono caratterizzati da un tono uniforme, calmo e per lo più amichevole nei confronti degli studenti. Loro stessi invitano gli studenti a comunicare. La lezione è più emotiva per loro, ma la disciplina è inferiore.
Un certo numero di insegnanti obbedisce semplicemente all '"elemento di comunicazione": non loro stessi, ma gli scolari dettano la natura della comunicazione tra questi insegnanti e la classe. Tali insegnanti non raggiungono i loro obiettivi, ma si adattano agli studenti.
L'intensità della comunicazione tra insegnanti e studenti dipende dall'età di questi ultimi. L'intensità degli appelli didattici da gradi inferiori agli anziani diminuisce e la loro efficienza aumenta (gli scolari diventano più comprensivi). Nelle classi medie aumenta l'intensità degli appelli educativi.
Questo testo è un pezzo introduttivo. Dal libro Psicologia dell'educazione: Reader autore autore sconosciutoKarandashev V. N. Lo stile della comunicazione pedagogica Lo stile della comunicazione pedagogica è una caratteristica sintetica dell'interazione tra insegnante e studenti, una descrizione generalizzata delle tipiche tecniche di comunicazione, metodi, tattiche utilizzate dall'insegnante nella comunicazione
Dal libro Psicologia della comunicazione e delle relazioni interpersonali autore Ilyin Evgeny Pavlovich17.8. Stili di comunicazione pedagogica Ci sono diversi approcci per identificare gli stili di comunicazione. Uno di questi si basa sul collegamento dello stile di comunicazione allo stile di leadership: lo stile autoritario di leadership corrisponde allo stile di comunicazione autoritario (imperativo), democratico
autore Voytina Yulia Mikhailovna36. STRUTTURA DEL PROCESSO PEDAGOGICO Secondo N.V. Kuzmina, il processo pedagogico è costituito da cinque elementi: l'obiettivo dell'apprendimento, il contenuto delle informazioni educative, i metodi, le tecniche, i sussidi didattici, l'insegnante, lo studente Tutti questi metodi sono interconnessi V.Ya. Svisky
Dal libro Cheat Sheet terreno comune pedagogia autore Voytina Yulia Mikhailovna47. MEZZI E FORME DEL PROCESSO PEDAGOGICO Gli strumenti pedagogici non sono diventati immediatamente una componente obbligatoria del processo pedagogico. Per molto tempo i metodi di insegnamento tradizionali si sono basati sulla parola, ma con la crescita dell'informazione, con lo sviluppo dell'informazione
Dal libro Cheat Sheet sui fondamenti generali della pedagogia autore Voytina Yulia Mikhailovna56. FASI DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA La progettazione dei sistemi pedagogici si basa su un processo complesso, quindi è un'attività complessa a più livelli. Tutte le attività, indipendentemente da chi appartengono, non importa quale oggetto siano
Dal libro Cheat Sheet sui fondamenti generali della pedagogia autore Voytina Yulia Mikhailovna58. PROGETTAZIONE DI UN OGGETTO PEDAGOGICO Diamo una descrizione di ogni azione per la progettazione di un oggetto pedagogico.1. Analisi dell'oggetto di design. Questa fase richiede una definizione di ciò che esattamente vogliamo progettare: un sistema, un processo o una situazione.
Dal libro Cheat Sheet sui fondamenti generali della pedagogia autore Voytina Yulia Mikhailovna59. TIPI DI CREATIVITÀ PEDAGOGICA In questa domanda considereremo i tipi di creatività pedagogica. Questi includono creatività didattica, creatività tecnologica, creatività organizzativa... Consideriamo più ogni tipo di creatività pedagogica
Dal libro Laboratorio psicologico per principianti autore Barlas Tatiana VladimirovnaCompito 2b. Caratteristiche non verbali della comunicazione efficace e problematica tra adulti e bambini La procedura di osservazione in questo compito generalmente ripete il compito 2a, quindi ci concentreremo solo sulle differenze. Come oggetto da osservare
autoreLe principali funzioni e struttura della comunicazione pedagogica
Dal libro Fondamenti psicologici della pratica pedagogica: una guida allo studio autore Korneva Ludmila ValentinovnaPrincipale caratteristiche psicologiche comunicazione pedagogica Nel sistema insegnante-studente, le relazioni interpersonali e la comunicazione giocano un ruolo importante nella soluzione dei problemi della formazione, dell'istruzione e dello sviluppo. La comunicazione è uno "strumento" professionale dell'attività dell'insegnante, da
Dal libro Fondamenti psicologici della pratica pedagogica: una guida allo studio autore Korneva Ludmila ValentinovnaUno schema indicativo per lo studio della comunicazione pedagogica 1. Lo stile di comunicazione tra insegnante e studenti: lo stile della leadership studentesca; individuazione dello stile prevalente della comunicazione pedagogica; produttività dello stile di comunicazione prevalente; conformità con lo stile selezionato
autore Rezepov Ildar ShamilevichFONDAMENTI PSICOLOGICI DEL TATTO PEDAGOGICO Il tatto pedagogico è il comportamento di un insegnante, costruito sulla base di aspettative sociali adeguatamente percepite da lui in relazione a lui come mentore della giovinezza. Ciò si manifesta nel senso delle proporzioni e nella capacità dell'insegnante
Dal libro Psicologia e pedagogia. Culla autore Rezepov Ildar ShamilevichSTILI DI COMUNICAZIONE PEDAGOGICA Esistono i seguenti stili di comunicazione pedagogica.1. Comunicazione basata sulle elevate attitudini professionali dell'insegnante, la sua attitudine all'attività pedagogica in generale. Dicono di queste persone: "I bambini (studenti) li seguono letteralmente alle calcagna!"
Dal libro Psicologia e pedagogia. Culla autore Rezepov Ildar ShamilevichEFFICIENZA DELLA COMUNICAZIONE PEDAGOGICA Il processo di comunicazione tra insegnante e studenti può svilupparsi in due varianti estreme: 1) comprensione reciproca, coerenza nell'attuazione delle attività educative, sviluppo della capacità di prevedere il comportamento reciproco; 2) discordia,
autore autore sconosciuto Dal libro Psicologia e pedagogia: Cheat Sheet autore autore sconosciutoPopolare
- Progetto di attività di storia locale Progetto “La mia piccola Patria” per la biblioteca di storia locale
- Rapporto completo (aiuto) Anti-plagio Il protocollo di controllo anti-plagio si presenta come
- Configurazione elettronica di un atomo
- Come collegare l'elettricità alla casa e alla trama: dove andare, cosa ti serve e quanto costa Come scegliere un adattatore Wi-Fi per un computer: esterno e interno
- Come arredare un ufficio, uno studio o un posto di lavoro per Capodanno: idee originali Arredare un ufficio per Capodanno
- Decorazione natalizia fai da te
- Celebrazione della giornata dell'agricoltura e dell'industria di trasformazione
- Quando si celebra la Giornata dell'agricoltura?
- Giochi di carte al tavolo
- Concorsi divertenti e divertenti per una divertente compagnia di adulti