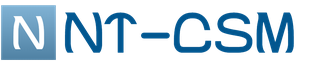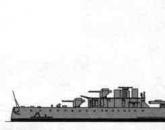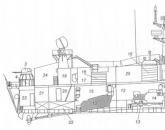Motivi inconsci di comportamento. Biblioteca elettronica scientifica
Nella psicologia domestica esistono vari approcci allo studio della personalità. Tuttavia, nonostante le differenze nelle interpretazioni della personalità, in tutti gli approcci, l'orientamento è individuato come caratteristica principale.
Molto spesso nella letteratura scientifica, l'orientamento è inteso come un insieme di motivi stabili che guidano l'attività di un individuo e sono relativamente indipendenti dalla situazione attuale.
L'orientamento dell'individuo è sempre socialmente condizionato e si forma nel processo educativo. Direzione: si tratta di atteggiamenti che sono diventati tratti della personalità e si manifestano in forme come attrazione, desiderio, aspirazione, interesse, inclinazione, ideale, visione del mondo, convinzione. Inoltre, i motivi dell'attività sono alla base di tutte le forme di orientamento della personalità.
L'attrazione è la forma di orientamento più primitiva, essenzialmente biologica. Dal punto di vista psicologico si tratta di uno stato mentale che esprime un bisogno indifferenziato, inconscio o non sufficientemente consapevole. Di norma, l'attrazione è un fenomeno transitorio, poiché il bisogno rappresentato in essa o svanisce o si realizza, trasformandosi in desiderio.
Il desiderio è un bisogno e un desiderio consapevoli di qualcosa di abbastanza specifico. Il desiderio, essendo sufficientemente cosciente, ha una forza motrice. Affina la consapevolezza dello scopo dell'azione futura e la costruzione del suo piano. Questa forma di orientamento è caratterizzata dalla consapevolezza non solo del proprio bisogno, ma anche delle possibili modalità per soddisfarlo.
L'aspirazione sorge quando la componente volitiva è inclusa nella struttura del desiderio. Pertanto, il desiderio è spesso considerato come una motivazione ben definita per l'attività.
Caratterizza più chiaramente l'orientamento della personalità dei suoi interessi. L'interesse è una forma specifica di manifestazione di un bisogno cognitivo, che assicura l'orientamento dell'individuo alla realizzazione degli obiettivi dell'attività e contribuisce quindi all'orientamento dell'individuo nella realtà circostante. Soggettivamente, l'interesse si trova nel tono emotivo che accompagna il processo di cognizione o attenzione a un particolare oggetto. Una delle caratteristiche più significative dell'interesse è che quando è soddisfatto non svanisce, ma, al contrario, evoca nuovi interessi corrispondenti a un livello superiore di attività cognitiva.
Gli interessi sono la forza motivante più importante alla conoscenza della realtà circostante. Distinguere tra interesse diretto causato dall'attrattiva dell'oggetto e interesse indiretto per l'oggetto come mezzo per raggiungere gli obiettivi dell'attività. Una caratteristica indiretta della consapevolezza dei bisogni riflessa negli interessi è la stabilità degli interessi, che si esprime nella durata della loro conservazione e nella loro intensità. Va inoltre sottolineato che l'ampiezza e il contenuto degli interessi possono servire come una delle caratteristiche più sorprendenti di una persona.
L'interesse per le dinamiche del suo sviluppo può trasformarsi in una propensione. Ciò accade quando la componente volitiva è inclusa nell'interesse. La propensione caratterizza l'orientamento dell'individuo a una particolare attività. La base della propensione è un bisogno profondo e stabile di un individuo per una particolare attività, ad es. interesse per un certo tipo di attività
L'ideale è l'obiettivo oggettivo dell'inclinazione dell'individuo, concretizzato nell'immagine o nella rappresentazione, cioè ciò per cui tende, ciò su cui si concentra. Gli ideali di una persona possono agire come una delle caratteristiche più significative della visione del mondo di una persona, cioè il suo sistema di opinioni sul mondo oggettivo, sul posto di una persona in esso, sull'atteggiamento di una persona nei confronti della realtà che lo circonda e di se stesso. La visione del mondo riflette non solo gli ideali, ma anche orientamenti di valore persone, i loro principi di cognizione e attività, le loro convinzioni.
La persuasione - la più alta forma di orientamento - è un sistema di motivazioni di una persona che lo incoraggia ad agire secondo le sue opinioni, principi, visione del mondo. Le convinzioni si basano su bisogni coscienti che incoraggiano una persona ad agire, formano la sua motivazione per l'attività.
I motivi e la motivazione forniscono principalmente l'attivazione e la direzione del comportamento umano.
Un motivo è un motivo di attività associato alla soddisfazione dei bisogni del soggetto. Il motivo è spesso inteso anche come il motivo alla base della scelta di azioni e azioni, la totalità dell'esterno e condizioni interne, causando l'attività del soggetto.
Il termine "motivazione" è un concetto più ampio del termine "motivo". La parola "motivazione" è usata nella psicologia moderna in un duplice senso: come sistema di fattori che determinano il comportamento (questo include, in particolare, bisogni, motivazioni, obiettivi, intenzioni, aspirazioni e molto altro), e come caratteristica di un processo che stimola e sostiene l'attività comportamentale a un certo livello. Molto spesso nella letteratura scientifica, la motivazione è considerata come un insieme di cause psicologiche che spiegano il comportamento umano, il suo inizio, la direzione e l'attività.
La questione della motivazione dell'attività si pone ogni volta che è necessario spiegare le ragioni delle azioni di una persona. Inoltre, qualsiasi forma di comportamento può essere spiegata da cause sia interne che esterne. Nel primo caso, le proprietà psicologiche del soggetto del comportamento fungono da punti di inizio e fine della spiegazione, e nel secondo - condizioni esterne e le circostanze delle sue attività. Nel primo caso parlano di motivazioni, bisogni, obiettivi, intenzioni, desideri, interessi, ecc., e nel secondo di incentivi derivanti dalla situazione attuale. A volte tutto fattori psicologici che, per così dire, dall'interno, da una persona, determinano il suo comportamento, sono chiamate disposizioni personali. Quindi, rispettivamente, si parla di motivazioni disposizionali e situazionali come analoghi della determinazione interna ed esterna del comportamento.
La motivazione interna (disposizionale) ed esterna (situazionale) sono interconnesse. Le disposizioni possono essere aggiornate sotto l'influenza di una determinata situazione e l'attivazione di determinate disposizioni (motivi, bisogni) porta a un cambiamento nella percezione della situazione da parte del soggetto.
In questo caso la sua attenzione diventa selettiva, e il soggetto percepisce e valuta la situazione in modo parziale sulla base di reali interessi e bisogni. Pertanto, qualsiasi azione umana è considerata doppiamente determinata: disposizionalmente e situazionalmente.
A sua volta, un motivo, a differenza della motivazione, è qualcosa che appartiene al soggetto stesso del comportamento, è la sua stabile proprietà personale, che induce determinate azioni dall'interno. I motivi possono essere coscienti o non coscienti. Il ruolo principale nel plasmare l'orientamento della personalità appartiene ai motivi coscienti. I motivi stessi sono formati dai bisogni umani.
Un bisogno è uno stato di bisogno di una persona in determinate condizioni di vita e attività o oggetti materiali. Un bisogno, come qualsiasi stato di una persona, è sempre associato al sentimento di soddisfazione o insoddisfazione di una persona. Il bisogno attiva il corpo, stimola il suo comportamento, volto a trovare ciò che è richiesto.
Le caratteristiche principali dei bisogni umani sono la forza, la frequenza dell'occorrenza e il metodo di soddisfazione. Una caratteristica aggiuntiva, ma molto significativa, soprattutto quando noi stiamo parlando sulla personalità, è il contenuto soggettivo del bisogno, cioè la totalità di quegli oggetti di cultura materiale e spirituale con l'aiuto dei quali questo bisogno può essere soddisfatto.
Lo scopo è il fattore motivante. L'obiettivo è un risultato consapevole, il cui raggiungimento in questo momento un'azione è diretta in relazione all'attività che soddisfa il bisogno attualizzato.
È consuetudine distinguere tra lo scopo dell'attività e lo scopo della vita. Ciò è dovuto al fatto che una persona deve svolgere molte attività diverse durante la sua vita, in ognuna delle quali si realizza un obiettivo specifico. Ma l'obiettivo di ogni attività individuale rivela solo un lato dell'orientamento della personalità, che si manifesta in questa attività. L'obiettivo della vita funge da fattore generalizzante di tutti gli obiettivi privati associati singole attività. Allo stesso tempo, la realizzazione di ciascuno degli obiettivi dell'attività è una realizzazione parziale dell'obiettivo generale della vita dell'individuo. Il livello dei risultati dell'individuo è associato agli obiettivi della vita. Negli obiettivi di vita dell'individuo trova espressione il “concetto del proprio futuro” cosciente di esso. La consapevolezza di una persona non solo dell'obiettivo, ma anche della realtà della sua attuazione è considerata come una prospettiva dell'individuo.
Lo stato di frustrazione, depressione, caratteristico di una persona consapevole dell'impossibilità di realizzare la prospettiva, si chiama frustrazione. Questo stato si verifica quando una persona, sulla strada per raggiungere un obiettivo, incontra ostacoli, barriere davvero insormontabili o quando vengono percepiti come tali.
La sfera motivazionale di una persona in termini di sviluppo può essere valutata dai seguenti parametri: ampiezza, flessibilità e gerarchizzazione. L'ampiezza della sfera motivazionale si riferisce alla diversità qualitativa dei fattori motivazionali: disposizioni (motive), bisogni e obiettivi. Più motivi, bisogni e obiettivi sono diversi in una persona, più sviluppata è la sua sfera motivazionale.
La flessibilità della sfera motivazionale si esprime nel fatto che per soddisfare un impulso motivazionale di carattere più generale (più alto livello) possono essere utilizzati stimoli motivazionali di livello inferiore più diversificati. L'ampiezza è la varietà della gamma potenziale di oggetti che possono servire per una data persona come mezzo per soddisfare un bisogno urgente, e la flessibilità è la mobilità delle connessioni che esistono tra diversi livelli organizzazione gerarchica della sfera motivazionale: tra motivazioni e bisogni, motivazioni e obiettivi, bisogni e obiettivi.
La caratteristica successiva della sfera motivazionale è la gerarchizzazione dei motivi. Alcuni motivi e obiettivi sono più forti di altri e si verificano più spesso; altri sono più deboli e aggiornati meno spesso. Maggiori sono le differenze nella forza e nella frequenza di attualizzazione delle formazioni motivazionali di un certo livello, maggiore è la gerarchizzazione della sfera motivazionale.
Va notato che quando parlano della gerarchia dei bisogni umani, molto spesso ricordano la classificazione proposta da A. Maslow. Secondo il concetto di A. Maslow, sette classi di bisogni compaiono costantemente in una persona dalla nascita e accompagnano la sua crescita: bisogni fisiologici (organici), bisogni di sicurezza, bisogni di appartenenza e amore, bisogni di rispetto (riverenza), bisogni cognitivi, bisogni estetici bisogni, bisogni di autorealizzazione. Inoltre, secondo l'autore, questa piramide motivazionale si basa su bisogni fisiologici e bisogni più elevati, come l'estetica e il bisogno di autorealizzazione, formano la sua sommità (Fig. 16).
L'adolescenza è caratterizzata dall'ulteriore sviluppo di interessi, e soprattutto cognitivi. Gli studenti delle scuole superiori iniziano a interessarsi ad aree già definite della conoscenza scientifica, si sforzano di ottenere una conoscenza più profonda e sistematica nell'area di loro interesse.
In corso ulteriori sviluppi e attività, la formazione di interessi, di regola, non si ferma. Con l'età, una persona ha anche l'emergere di nuovi interessi. Tuttavia, questo processo è in gran parte consapevole o addirittura pianificato, poiché questi interessi sono in gran parte legati al miglioramento delle capacità professionali, allo sviluppo delle relazioni familiari, nonché a quegli hobby che, per un motivo o per l'altro, non sono stati realizzati nell'adolescenza.
15. autocoscienza della personalità struttura dell'autocoscienza l'immagine di sé e le sue caratteristiche principali l'autostima e il livello delle aspirazioni della personalità. Metodi per il loro studio.
Maggiori informazioni sull'argomento 14. tipi di motivazioni e livelli della loro consapevolezza. Motivi consci e loro caratteristiche e motivi inconsci e loro caratteristiche.:
- 14. tipi di motivi e livelli della loro consapevolezza. Motivi consci e loro caratteristiche e motivi inconsci e loro caratteristiche.
Eppure, perché spettegoliamo - o l'incapacità di tenere la bocca chiusa?
- Divulgazione del concetto di "relazione". Il valore delle relazioni che si sviluppano.
- Il mio ruolo in queste relazioni, cosa mi insegnano?
- Divulgazione del concetto di "gossip". Un'esplorazione dei motivi inconsci per diffondere pettegolezzi. Cosa c'è dietro questo?
- Posizione adulta nelle relazioni.
La relazione che si sviluppa tra due persone - amichevole, partner, famiglia - questo è ciò che sviluppano insieme, questa è solo la loro zona di comfort personale, che è emotivamente chiusa agli altri. Tutta la responsabilità della relazione è divisa a metà, ognuno ha la sua parte di responsabilità.
Ciò che nasce tra me e te: emozioni, interessi e ciò che creiamo insieme - ha certi limiti per gli altri.
In una relazione ci apriamo a una persona, gli affidiamo qualcosa di molto importante per noi in questo periodo della vita.
Sento che mi capisci, pronto a sostenermi, a stare con me, e mi sento simile a te, se ci siamo incontrati, possiamo darci qualcosa di importante durante questo periodo della vita. Con un'altra persona avrò già un incontro diverso, una storia diversa, e sarò diverso in loro, verrà rivelata un'altra parte di me, ma questa è già una relazione diversa.
Nel processo di comunicazione, una persona ci affida qualcosa e noi, a nostra volta, ci fidiamo di lui. Questa è la nostra connessione con lui e ciò che abbiamo creato insieme.
Molto probabilmente, in queste relazioni non c'è segreto vitale su una persona, ma c'è un incontro spirituale di persone, e qualcosa di molto importante viene detto o affidato a noi, e non a qualcun altro. La persona stessa decide quando e cosa raccontare a un altro di se stesso. Una storia su se stessi, sui propri sentimenti, esperienze, azioni è già personale, il che implica di non portarla fuori dalla stanza in cui si è discusso.
Ma quante volte è diverso...
Conosci la situazione in cui due amici si incontrano e iniziano a parlare della loro amica comune, del suo personale.
Come appare dal lato? Nella migliore delle ipotesi, non è corretto in relazione a un'amica di cui si spettegola alle spalle. Queste relazioni non possono più essere definite sincere, tutto il valore di queste relazioni tra quelle amiche che spettegolano e quel conoscente di cui spettegolano è perso.
Ma perché ci interessa tanto parlare della vita di un altro,
quali sono le nostre motivazioni inconsce?
Come capire la parola "pettegolezzo" o "pettegolezzo"?
Il pettegolezzo è distorcere (abbellire) le informazioni su una persona in un dialogo con un'altra.
Una conversazione che ha un significato valutativo - sul comportamento di un altro, le sue azioni, parole, vita personale. È molto corretto imparare a parlare non di una persona, ma di te stesso: i loro stati accanto a lui, la loro reazione alle sue parole. Certo, ci sono delle eccezioni: quando i genitori parlano di un bambino; oppure dobbiamo prendere una decisione per noi stessi e ci consultiamo, ma questa è una linea molto sottile.
Perché siamo così interessati a parlare della vita di un altro,
E quali bisogni soddisfiamo?
Perché tendiamo a distorcere le informazioni?
È importante rendersi conto che le informazioni che passano attraverso la nostra realtà interiore sono nostre esperienza personale può distorcere ciò che è realmente accaduto.
1. Inconscio desiderio di compiacere gli altri, per interessarlo, per attirare l'attenzione, per mostrare la sua importanza.
2. Volendo essere protetti dalla persona che mi offende.
Sottotesto inconscio: posizione sacrificale - sto bene, ma mi sono offeso. La vittima rende l'altra persona l'aggressore: è malvagio, cattivo. Un'altra persona funge da difensore, che inconsciamente inizia a prendere la posizione della vittima e proteggerla dall'aggressore.
È anche una posizione infantile e la ricerca di una figura genitoriale che protegga.
3. A spese di altri Aumento inconsciamente la mia autostima(Molto probabilmente, non ero abbastanza significativo per i miei genitori, e questo è il vuoto che cerco di riempire tutto il tempo). Pertanto, quando parlo di qualcuno, mi dico: sto meglio, non lo farò mai.
4. Parlare di qualcuno (senza rendersene conto - spettegolare), Violo costantemente i confini degli altri e permetto agli altri di invadere i miei confini (non so difendere i miei confini, dichiarare i miei bisogni).
Non ho qualcosa di molto importante, non ho avuto modo di conoscermi, non so cosa voglio, cosa sento e dove sto andando. È difficile per me esprimere i miei bisogni, è difficile accettare il supporto, ma il contatto con gli altri e la loro opinione su di me, l'approvazione, il supporto sono importanti per me.
5. Desiderio di fare del male a un altro ferirlo, risentimento non detto nascosto, forse aggressività, condanna delle sue azioni.
Se condanniamo l'azione di un altro, è molto probabile che questo sia ciò che non accettiamo in noi stessi. Quando in noi c'è un lato oscuro che non siamo pronti ad incontrare, allora vediamo chiaramente questa qualità in un altro e questo ci irrita molto. E qui è importante porsi una domanda:
- Perché questa qualità mi infastidisce?
- Forse ce l'ho anche io, ma non voglio accettarlo, ma lo condanno così chiaramente in un altro modo?
6. Diffidenza di un altro(sfiducia di base nei confronti del mondo, il mondo è ostile nei miei confronti e io sono costantemente all'erta), incapacità di essere sincero nei rapporti con una persona, desiderio di nascondere costantemente i propri sentimenti e sembrare migliore, più riuscito di quanto non sia in realtà .
7. Arroganza rispetto a un altro, il deprezzamento di queste relazioni.
8. Nella mia vita molta confusione, problemi.
- Quando contatto un altro, di maggior successo, mi sembra di unirmi a lui e lasciarlo godersi la vita, gioire o rifiutare, non accettare, condannare ciò che non lascio entrare nella mia vita, svalutarlo.
- Quando contatto qualcuno con meno successo di me, mi sembra di aumentare la mia autostima, ma tutto nella mia vita è andato meglio, scappo dalla risoluzione dei miei problemi e rivolgo la mia attenzione alla vita di un altro, posso aiutarlo.
Né nel primo né nel secondo caso vivo la mia vita, i miei desideri, i miei bisogni, i miei obiettivi: la mia attenzione è rivolta alla vita di un altro, e lì realizzo inconsciamente i miei bisogni, non realizzandoli pienamente. Ma in questo modo non risolvo in alcun modo i compiti della mia vita, distolgo solo la mia attenzione da qualcosa di molto importante, e la mia vita mi passa accanto, e sono presente con la mia energia nella vita di un altro e lo aiuto in quello che voglio voglio davvero me stesso, ma non me ne rendo conto e non lo accetto ancora nella mia vita. L'accettazione passa attraverso la consapevolezza.
Qual è il pericolo e cosa stiamo perdendo di importante per noi stessi?
Quando ci concentriamo sulla vita di altre persone, smettiamo di prestare attenzione di qualità a noi stessi, al nostro sviluppo, ai sogni, agli obiettivi. Ma in questa situazione è importante realizzare e accettare: tutto ciò che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per noi stessi (e anche se ci sembra che lo stiamo facendo per gli altri), i nostri motivi interni, che sono elencati sopra (ovviamente, potrebbe esserci qualcos'altro).
L'altra persona percepisce i nostri secondi fini. Se violi i confini di un altro e inizi a essere eccessivamente coinvolto nella sua vita, mostra curiosità, dai consigli dove non ti viene chiesto e così via. Questo parla di vuoto interiore personale.
Quindi distorciamo la realtà interiore dell'altro e la integriamo con qualcosa di nostro, pettegolezzo (abbelliamo) per ricevere nuovamente l'approvazione dall'altro. Una persona ci affida qualcosa di importante per lui e diciamo a un'altra quanto spesso questo accade nella nostra vita.
Come si comporta un adulto sicuro di sé?
Nelle relazioni creative c'è qualcosa che diventa nostro, ciò che abbiamo creato insieme, imparato quali emozioni abbiamo vissuto, come si sviluppano le nostre relazioni e noi come individui. Sono pronto ad aiutare solo quando me lo chiedono e se non sarà un peso per me. Se non mi viene chiesto, non darò consigli.
Pertanto, posso parlare di me stesso, della mia esperienza, delle mie esperienze. Capisco i miei pensieri, controllo i miei sentimenti, parlo dei miei bisogni, sono consapevole delle mie aspettative. E apprezzo un'altra persona, credo che risolverà i suoi problemi di vita, e insieme ci muoviamo verso l'obiettivo, impariamo a collaborare e ad essere sinceri.
- Non dirò niente agli altri, ho il diritto di rispondere solo per me stesso e parlare di me stesso.
- Costruirò anche liberamente e facilmente relazioni con gli altri e separerò l'uno dall'altro. Ogni relazione ha una storia e ogni relazione è importante per me.
- Conosco la mia autostima e non ho bisogno di dimostrare nulla a nessuno per giustificare le aspettative degli altri.
Per cambiare il mondo intorno a te, devi cambiare te stesso.
Se puoi cambiare te stesso, allora cambierai il mondo intorno a te.
Il movente è inconscio
Ci sono molti più di questi motivi rispetto a quelli coscienti e fino a una certa età quasi tutti i motivi sono inconsci. Il lavoro di realizzazione delle proprie motivazioni è molto importante e molto difficile e richiede non solo una grande esperienza intellettuale e di vita, ma anche un grande coraggio. In realtà, questa è un'attività speciale che ha il suo motivo: la conoscenza di sé e l'auto-miglioramento morale.
I motivi inconsci appaiono ancora nella coscienza, ma in forme speciali. Ce ne sono almeno due: e significati personali. Allo stesso tempo, solo il motivo principale può agire come funzione di formazione dei sensi. Motivi-stimoli possono generare solo emozioni, ma non significati.
Dizionario di psicologo pratico. - M.: AST, Vendemmia. S. Yu Golovin. 1998 .
Scopri cos'è il "motivo inconscio" in altri dizionari:
Attività- il processo dinamico di interazione di un individuo con il mondo esterno (attività esterna) o con se stesso ( attività interne). Entrambi gli aspetti dell'attività coesistono in un'unità dialettica: nel corso di attività esterne: l'individuo cambia se stesso... Dizionario Enciclopedico di Psicologia e Pedagogia
Attività propositiva che realizza i bisogni del soggetto. Come principio esplicativo della psiche, nello studio viene utilizzata la categoria di D varie zone realtà mentale (psicologia dei processi cognitivi, mo ... Grande enciclopedia psicologica
Installazione (psicologia)- Questo termine ha altri significati, vedere Installazione. Questo articolo dovrebbe essere wikificato. Per favore, formattalo secondo le regole per la formattazione degli articoli. Impostazione dello stato psicologico inconscio ... Wikipedia
Ambiente psicologico- Stabilire lo stato psicologico della predisposizione del soggetto a una certa attività in una certa situazione. Il fenomeno fu scoperto dallo psicologo tedesco L. Lange (L. Lange, 1888); teoria psicologica generale dell'installazione basata su numerosi ... ... Wikipedia
M. o. si formano nel corso della lunga O. e dell'interazione delle persone. Relazione sistema completo connessioni coscienti selettive individuali dell'individuo con diversi aspetti della realtà oggettiva, comprese 3 componenti correlate: ... ... Psicologia della comunicazione. Dizionario enciclopedico
Il movente è la forza motrice del comportamento umano. E in questo non c'è il minimo dubbio tra i ricercatori coinvolti nella determinazione del comportamento umano. Allo stesso tempo, nonostante le differenze nell'interpretazione del fenomeno del "motivo", gli psicologi sono unanimi sul fatto che "il motivo come incentivo è la fonte dell'azione che lo genera" 1 . In psicologia, tuttavia, la fonte da cui proviene l'impulso non è ugualmente definita.
Le posizioni degli psicologi su questo tema possono essere suddivise in tre blocchi. Il primo, non per importanza, ma per scelta dell'autore del libro, racchiude una posizione non condivisa dalla stragrande maggioranza degli psicologi, secondo la quale al movente appartengono solo motivi inconsci: “I bisogni possono essere realizzati, e poi il comportamento acquisisce il carattere di azioni volitive, oppure possono rimanere si chiama pulsione o movente. Gli autori non danno i dettagli della definizione di cui sopra e lasciano il lettore-ricercatore tormentato dalla domanda: i bisogni percepiti non hanno il potere motivante di un movente?
Il secondo blocco include opinioni secondo cui il motivo è un impulso cosciente e il terzo - sia conscio che inconscio. Gli aderenti al movente come impulso cosciente non sono del tutto coerenti nelle loro affermazioni.
IN E. Kovalev scrive: “I motivi li intendiamo come motivi che sono proprietà dell'individuo, che sorgono sulla base dei bisogni e in connessione con il carattere relazioni pubbliche e realizzato dalla persona stessa" 3 .
Tuttavia, inoltre, riassumendo il suo ragionamento sul motivo, l'autore ammette che "il motivo è, per così dire, un bisogno consapevole". E poi l'autore ammette che "questo non è più il bisogno in sé, ma il suo riflesso, manifestazione, come se la sua trasformazione ed espressione concretizzata" . Usando la frase "come se", l'autore dà motivo di presumere che ritenga possibile assumere un altro punto di vista come verità.
S.L. Anche Rubinstein considerava il motivo un impulso cosciente, ma riteneva che la consapevolezza potesse essere più o meno adeguata 1 .
Un gruppo più ampio di psicologi sono ricercatori che sostengono che il motivo, come forza che spinge all'azione, può essere sia conscio che inconscio 2. Inoltre, gli autori difendono le loro posizioni con la convinzione di Catone e la sua invidiabile coerenza: “I motivi dell'attività umana possono essere sia consci che inconsci, anche se in generale, ovviamente, prevalgono i motivi coscienti. Tuttavia, la situazione è più complicata e ciò che chiamiamo motivo cosciente include momenti dell'inconscio e non del tutto cosciente. Allo stesso tempo, le componenti consce e inconsce dei motivi dell'attività umana sono in un'unità dialettica, che non esclude le loro contraddizioni e lotte” 3 .
Molto interessante e molto utile per ulteriori ricerche è la comprensione della motivazione di KV Shumeikina. Nota il ricercatore: “La motivazione è spesso caratterizzata dalla parola “attrazione”, e la manifestazione effettrice della motivazione si riduce a massimizzare gli sforzi del corpo volti a soddisfare un particolare bisogno. Tuttavia, la principale qualità della motivazione non è la capacità di migliorare il comportamento (qualsiasi attivazione non specifica ha questa proprietà), ma la capacità di concentrare questo sforzo in una certa direzione biologicamente definita (ricerca di cibo, attrazione per un individuo dell'opposto sesso, evitamento di un certo fattore). ambiente esterno)» .
Se prendiamo come base (altrimenti non possiamo agire) che un motivo è uno stimolo all'azione e solo spinge una persona a commettere un atto comportamentale, allora dovremmo analizzare l'affermazione che l'inconscio può anche essere un tale motore, perché in relazione al conscio quasi Tutti gli autori sono d'accordo.
Un'immagine piuttosto strana: gli scienziati sono spesso davanti ai rappresentanti di Euterpe e Melpomene. Ad esempio, I.V. Goethe mette in bocca a Faust le parole:
“Ah, due anime vivono nel mio petto malato,
Alieni l'uno dall'altro e bramano la separazione!
Questi sono gli "io" molto consci e inconsci, inseparabili antagonisti, di cui S.L. Rubinstein, un oppositore della comprensione del motivo come impulso inconscio, ha detto: “Le basi del sentimento non sono nel mondo chiuso della coscienza, sono nel rapporto dell'individuo con il mondo che va oltre la coscienza, che può essere realizzato con diversi gradi di completezza e adeguatezza. Pertanto, è possibile una sensazione vissuta molto intensamente e tuttavia inconscia o, piuttosto, inconscia. Maslow, parlando dei bisogni fondamentali, ha detto in questo contesto: “Poiché gli obiettivi fondamentali non sono sempre rappresentati nella coscienza, dovremo affrontare un problema molto importante: il problema dell'inconscio. Lo studio della sola motivazione cosciente, anche la più approfondita, lascia fuori dalla considerazione moltissimi motivi umani, che non sono da meno, ma. forse più importanti di quelli che sono rappresentati nella mente.
Contrariamente alla credenza popolare che lo sviluppo del subconscio sia iniziato con 3. Freud, i tentativi in questo settore sono stati fatti molto prima di lui. Nelle opere di Senofonte e Platone, Socrate menziona il suo demone personale, che gli ispira alcuni pensieri. Tuttavia non si può non riconoscere il merito di 3. Freud, che ha evocato "i più cattivi spiriti della critica alla psicoanalisi", portando l'inconscio in primo piano nella vita spirituale. Tuttavia, ponendo in primo piano l'inconscio sessuale, 3. Freud ha focalizzato la sua attenzione su di esso e sui notevoli sforzi del ricercatore, lasciando da parte altre caratteristiche. Indubbiamente, 3. Freud ha dato un contributo positivo alla teoria dell'inconscio e ha lasciato seguaci, molti dei quali sono stati così portati via dalla sua teoria che hanno iniziato a vedere un simbolo fallico anche negli strumenti musicali.
Contemporaneo 3. Freud K.G. Jung, che sviluppò un'interessante dottrina degli archetipi, fu il più coerente nella sua visione dell'inconscio. Il suo concetto ha costituito la base per la comprensione dell'inconscio da parte degli scienziati russi.
KG. Jung ha affermato: "Le motivazioni intrinseche sorgono da una fonte profonda, non generata dalla coscienza e non sotto il suo controllo".
C'è una parte profonda della psiche, ha sostenuto il ricercatore, che ha una natura collettiva, universale e impersonale, la stessa per tutti i membri del team. Questo strato della psiche è direttamente connesso con gli istinti, cioè fattori ereditari. Ma esistono molto prima dell'emergere della coscienza e continuano a perseguire i propri "propri" obiettivi, nonostante lo sviluppo della coscienza. L'inconscio collettivo è il risultato della vita tribale, che funge da fondamento della vita spirituale dell'individuo.
KG. Jung ha paragonato l'inconscio collettivo a una matrice, un micelio, la parte sottomarina di un iceberg: più si va in profondità "sott'acqua", più ampia è la base. Dal comune: famiglia, tribù, popolo, razza, ad es. di tutta l'umanità - discendiamo all'eredità degli antenati preumani. Come il nostro corpo, la psiche è il risultato dell'evoluzione. L'apparato mentale è sempre mediato dalle relazioni dell'organismo con l'ambiente, pertanto nella psiche si imprimono reazioni tipiche a condizioni di vita ripetitive.
"Ho fatto diversi confronti", scrive K.G. Jung - tra l'uomo moderno e il selvaggio. Tali confronti sono essenziali per comprendere le tendenze simboliche dell'uomo e il ruolo svolto dai sogni nell'esprimerle. Si è scoperto che molti sogni presentano immagini e associazioni analoghe a idee, miti e rituali primitivi. Queste immagini oniriche furono chiamate da Freud "sopravvivenze arcaiche", l'espressione stessa suggerisce che si tratti di elementi psichici sopravvissuti per secoli nel cervello umano.
Un'illustrazione della tesi di K.G. Jung può servire come osservazioni di C. Lombroso, che ha dimostrato empiricamente che gli atti creativi dei pazzi contengono elementi di comportamento ereditati dai tempi della ferocia.
Quindi, i versi di uno dei pazzi erano accompagnati da disegni, esattamente come le pitture rupestri dei selvaggi, in cui cercavano di mostrare la loro storia. Nel comportamento umano si manifesta l'eredità inconscia dell'esperienza secolare dell'umanità, compreso il periodo della ferocia.
Discutendo sulla filogenesi nel contesto delle tracce ereditarie che tendono ad attivarsi, trasformandosi in un motivo di comportamento per soddisfare i bisogni primari, aderendo rigorosamente all'assioma del piacere, Maslow, compilando da Freud, ha scritto: “L'energia dell'Es è istinto, ma questa energia è disorganizzata, non avendo volontà, governata dal mero desiderio di soddisfare bisogni istintivi secondo il principio del piacere. L'Es in Freud e Maslow è l'inconscio, in contrasto con l'IO, che si distingue per la coscienza. In effetti, da dove, da quale scatola, forse da una bellissima Pandora, una persona ha avuto il bisogno di soddisfare i suoi bisogni primari e come si sono formati i bisogni in modo tale da permetterci di parlare del loro significato motivazionale in caso di attivazione ? Sam Harris sostiene con sicurezza che sono ereditati: "Anche quando pensiamo di avere il controllo delle nostre attività (cambiare noi stessi in lato migliore acquisire conoscenze o migliorare competenze), gli unici strumenti a nostra disposizione sono ereditati dal passato.”
"La storia della mente umana", ha scritto J. Locke, "è sia la storia di come le forme razionali ereditate da epoche precedenti e il contenuto teorico della conoscenza influenzano attivamente la formazione e la comprensione dell'esperienza sensoriale delle nuove generazioni, sia il storia di come si combinano con nuove forme e contenuti teorici, determinando congiuntamente le caratteristiche del riflesso sensoriale della realtà. In questa occasione, F. Nietzsche ha un pensiero molto interessante, che esprime fedelmente quanto detto: “Non solo la mente dei millenni, ma anche la loro follia si manifesta in noi. Essere un erede è pericoloso. Nella sua opera poetica, questo è espresso come segue: "La follia della rabbia ribolle nel mio sangue".
Caratteristiche tipiche dell'esperienza millenaria dell'umanità, riflesse dalla psiche uomo moderno, non restava e non poteva restare ignorato da menti curiose, apparentemente lontane dallo studio dei fenomeni psicofisiologici. Henrik Ibsen mette in bocca al suo personaggio parole che illustrano accuratamente l'influenza dell'inconscio sul comportamento: “È qualcosa come i fantasmi. Siamo influenzati non solo da ciò che è passato in noi per eredità da nostro padre e nostra madre, ma si fanno sentire anche tutti i tipi di vecchi concetti, credenze e simili obsoleti. Tutto questo non vive più in noi, ma è ancora così saldamente che non possiamo liberarcene.
Ricercatori russi, senza negare i meriti di 3. Freud e K.G. Jung, ha continuato quello che avevano iniziato.
“Quando si analizzano le forme più alte di attività riflessa, le più alte attività nervosa, - scrive R.I. Kruglikov, - viene in primo piano la necessità di tenere conto dei fattori di traccia, poiché questi fattori sono la memoria, ad es. la storia accumulata del rapporto tra l'organismo e l'ambiente, organizza e modifica al massimo le attuali reazioni adattative. E inoltre: "... le forme di memoria" non neurali "non scompaiono - si conservano, funzionando sulla base del principio del" cambiamento dall'uso "..." .
L'esperienza storica dell'umanità, geneticamente incorporata nel meccanismo del comportamento umano, si manifesta a livello dell'inconscio in azioni specifiche. A. Moskalenko, V.F. Serzhantov scrive: "È il passato dell'umanità che determina la personalità, la cui vita, se non si congela in un punto morto, significa creazione costante, innovazione, aspirazioni per il futuro" 2 . Il "passato" è solo in attesa dietro le quinte e in un momento favorevole può spesso manifestarsi in azioni violente, come dimostrano i cosiddetti moventi teppisti che riaffiorano ogni volta nelle carte ufficiali delle forze dell'ordine in caso di comportamento inspiegabile .
In criminologia esiste persino il termine "reati paradossali", che si riferisce ad atti commessi in assenza di ragioni apparenti. Uno degli esempi di questo tipo di crimini paradossali, che illustra in misura maggiore l'inconscio storico in uno specifico atto comportamentale, è dato nel suo libro di A.F. Zelinsky. Questo esempio merita di essere qui riportato integralmente.
Lo studente di 15 anni S. era in regola a scuola ea casa. Amava andare a caccia con suo padre. Una delle due pistole era in suo possesso indiviso. Un giorno S., di ritorno da una battuta di caccia da solo, senza padre, incontrò due studentesse che conosceva. Volevo attirare l'attenzione su di me, e ha scherzosamente minacciato uno di loro: "Lyuda, ti sparo adesso!" E, caricando rapidamente la pistola con una cartuccia, ha sparato.
La ragazza è morta lì, sulla strada del villaggio. L'assassino era disperato e per molto tempo non riuscì a capire cosa fosse successo.
Condannato per omicidio sconsiderato 3 .
AF Zelinsky commenta questo caso nel modo seguente: "Sembra che tali crimini "paradossali" siano basati su impulsi derivanti dal subconscio, corrispondenti all'atteggiamento psicologico dell'autore" 1 . Parleremo dell'installazione un po 'più tardi, ma qui, visto che stiamo parlando di paradossi, vorrei tracciare un parallelo tra il suddetto caso di omicidio incurante e la ricerca degli scienziati nel campo dello sviluppo morale.
"Ci si aspettava da un cavaliere che si prendesse costantemente cura della sua gloria", osserva M. Ossovskaya, esplorando il fenomeno della cavalleria medievale 2 . La preoccupazione del cavaliere per la gloria si manifestava non solo nelle imprese militari, ma anche in vari tipi di azioni che illustravano il significato "IO" individuale. Ad esempio, una dimostrazione di forza davanti a una signora. Se scendiamo nei livelli nervosi della psiche, possiamo ricordare gli studi degli zoobiologi che raffigurano in modo colorato le battaglie di accoppiamento degli animali maschi davanti alla femmina ingrata, che rimane con il vincitore, che è anche tipico della comunicazione umana durante il periodo di corteggiare una signora.
In connessione con l'inconscio filogenetico, le caratteristiche archetipiche della psiche che influenzano le reazioni comportamentali, un tale crimine, costringendo le forze dell'ordine a commettere molti errori, come il teppismo attira l'attenzione.
Nel codice penale della Federazione Russa, il teppismo è presentato in due forme: come motivo, è regolato, ad esempio, al paragrafo "e" parte 2 dell'art. 105 e come atto manifestato in azioni specifiche - nell'art. 213.
L'articolo 213 del codice penale della Federazione Russa definisce il teppismo come atti intenzionali che violano gravemente l'ordine pubblico ed esprimono una chiara mancanza di rispetto per la società, che sono commessi con l'uso di armi o oggetti utilizzati in tale veste o per motivi estremisti.
Questa formulazione legislativa è così amorfa da suscitare sconcerto: davvero altri reati non esprimono evidente mancanza di rispetto per la società e non violano o, in misura diversa dal teppismo, violano l'ordine pubblico? Ad esempio, causare lesioni personali gravi intenzionali. Se la società ha posto una barriera normativa alla commissione di questo crimine, quindi, l'abbandono della norma stabilita (scala di comportamento) è una manifestazione di mancanza di rispetto per la società, che può essere sia esplicita che implicita, e un'indubbia violazione dell'esistente ordine in questa società. Lo stesso vale per tutti, senza eccezioni, intenzionali e una serie di reati sconsiderati.
In pratica, il teppismo si traduce in azioni molto specifiche, che sono regolate da specifiche norme di diritto penale. Si tratta di vari tipi di lesioni personali, distruzione di proprietà, insulti, ecc. Tuttavia, i tribunali spesso classificano erroneamente atti criminali specifici come teppismo. Allo stesso tempo, il criterio di qualificazione di cui all'art. 213 del codice penale della Federazione Russa è il luogo del crimine o la presenza di persone non autorizzate. Questo paradosso si riflette in decisioni giudiziarie specifiche.
Ne risulta un quadro molto strano: nonostante l'assioma dottrinale dell'imputazione soggettiva, le forze dell'ordine fanno dipendere la presenza o l'assenza di un reato dal luogo del delitto o dalla presenza di persone non autorizzate. Inoltre, i praticanti spesso qualificano un atto come teppismo se è difficile dare una definizione esatta dell'atto.
Questa situazione può essere spiegata solo dal fatto che il motivo dell'atto, ad es. motivazione interna, il legislatore si è trasformato in un reato, che è contrario ai canoni del diritto penale, comporta e continuerà a comportare errori nell'applicazione della legge.
Se il motivo dell'atto criminale non è chiaro alle forze dell'ordine, l'atto senza pensarci troppo è qualificato come teppismo. Quindi, nel verdetto nel caso di P., è stato notato che “il motivo dell'uccisione della figlia - la vendetta sulla moglie per adulterio è riconosciuto come teppista, poiché la figlia non poteva essere responsabile delle azioni della madre e di P. . le azioni di lei nei suoi confronti erano infondate” .
Nel frattempo, il teppismo non è un crimine, ma un motivo che può portare ad azioni illegali. In quanto tale, il motivo del teppismo ha giustamente preso posto nella parte 2 dell'art. 105 e una serie di altre norme della Parte Speciale del Codice Penale della Federazione Russa. Ma completamente ingiustificatamente trasformato in un reato ai sensi dell'art. 213 del codice penale della Federazione Russa. Il motivo del teppismo, incomprensibile per le forze dell'ordine, è spiegato semplicemente dal punto di vista della psicofisiologia, tenendo conto dell'esperienza filogenetica dell'umanità.
Il cavaliere doveva attirare l'attenzione su di sé, altrimenti lo attendeva l'oblio, la morte.
Anche l'uomo moderno è condannato a cercare l'attenzione sulla sua persona. Ciò significa l'indispensabile soddisfazione del bisogno fondamentale di riconoscimento. Tale attenzione può essere meritata, ad esempio, dalle scappatelle "Duma" dei deputati del popolo, da una storia d'amore scandalosa o da un'impresa. Per motivi di attenzione, puoi comporre una "Divina Commedia" o dare fuoco a Roma. Per qualsiasi persona, è meglio fare qualcosa di brutto e riprovevole piuttosto che rimanere inascoltato e non visto, non reclamato.
Secondo l'assioma psico-fisiologico, nessuna punizione, nelle sue proprietà psico-traumatiche, può essere paragonata alla mancata conferma del proprio “io”, che è la soddisfazione di un bisogno prepotente. Se rimproverano, significa che riconoscono il fatto della mia esistenza, sanno, ricordano. Questo fenomeno psicofisiologico è universale. Per esserne convinti, è sufficiente immaginare che, con tutta l'evidenza del tuo essere per te stesso, coloro che ti circondano hanno improvvisamente smesso di sentire, vedere o percepire. Inoltre, si sono completamente dimenticati di te. L'esito più probabile in una situazione del genere è impazzire o suicidarsi (le statistiche sui suicidi, purtroppo, confermano quanto detto). In questo contesto, una parabola interessante riguarda Assuero, un artigiano ebreo, la cui casa Gesù passò per essere giustiziato, chiedendo ad Assuero di dargli la possibilità di appoggiarsi al muro della sua casa per riposare. Assuero respinse Gesù e disse: "Va ', riposerai sulla via del ritorno", per cui fu condannato a vagare per sempre sulla terra fino alla seconda venuta del Signore, rifiutato da tutti, disprezzato e non trovando partecipazione. Dicono che Assuero, che ha ricevuto il sigillo dell'eterno ebreo, chiede a Dio la morte per sbarazzarsi di un'esistenza insopportabile, ma la morte non viene da lui.
Il teppismo è una manifestazione del proprio "io" ignorato dalla società, che si esprime in azioni ben precise, per le quali il soggetto deve assumersi responsabilità penali o di altro tipo come quelle commesse per motivi teppisti.
I parallelismi tra istinti animali, battaglie cavalleresche e moderni cosiddetti impulsi da teppista sono abbastanza appropriati e sono confermati dalle opinioni degli scienziati secondo cui le informazioni sulle strutture di antenati molto antichi sono nascoste nei genotipi.
Peter Fischer scrive in modo molto eloquente sui rapporti con gli antenati:
“La parte più antica del cervello è il tronco encefalico. In esso, secondo Wilson, gli istinti sono immagazzinati, radicati esperienza di vita rettili: la conservazione di ciò che si ottiene, l'osservanza di regole ferree, il desiderio di un sistema solido e irremovibile dell'ordine mondiale. E poi fa un esempio molto interessante: “Se, ad esempio, una persona si aggrappa ostinatamente a istruzioni burocratiche obsolete, significa che in lui ha vinto il tronco encefalico ereditato dai rettili che negano qualsiasi cambiamento. L'odio e l'aggressività distruttiva provengono dal diencefalo emotivo dei primi mammiferi” 1 .
Ciò può essere confermato dall'istinto come una caratteristica innata del modo di agire. L'istinto determina la strategia del comportamento, lasciando alla psiche la soluzione delle questioni tattiche. In questo senso, gli psicologi chiamano l'istinto il motivo del comportamento. Quindi, V.K. Viliunas scrive: “Sotto l'aspetto motivazionale, l'istinto può essere caratterizzato come un meccanismo ereditario per soddisfare i bisogni, la cui specificità è quella di indurre un individuo a compiere una serie di azioni private senza rifletterne la direzione generale, il cui controllo supera l'adattamento capacità della psiche nelle prime fasi del suo sviluppo” 1 .
Il ruolo dell'istinto come stimolo per il comportamento umano è stato instancabilmente sottolineato da I.M. Sechenov, e poi i suoi seguaci. Ma l'istinto non è altro che un programma filogenetico che cattura la saggezza e la follia dei secoli. Pertanto, influenzano anche il comportamento umano, fungendo da motivi.
Gli studiosi sottolineano, commentando "inconsapevolmente" F. Nietzsche, che l'eredità di secoli nella nostra memoria è molto specifica. Fondamentalmente, consiste in emozioni negative, stimoli spiacevoli, che, rimanendo nella sfera inconscia, sono sempre pronti a riversarsi nella coscienza, determinando già intenzionalmente l'attività umana.
Interessante, a questo proposito, l'esempio riportato nell'articolo di S. Garfield. Nella sua relazione sul wrestling, uno dei lottatori afferma: “Per me il wrestling è l'unico modo per dare sfogo ai miei sentimenti repressi, per rilassarmi senza entrare in conflitto con il codice penale” 2 .
In che modo questa eredità storica si manifesta nella psiche umana - è solo nella gioia selvaggia di atti di crudeltà o, forse, in qualcos'altro?
I ricercatori tedeschi osservano che il patrimonio umano può essere portato alla luce anche sotto forma di buone azioni, che sono anche trasferite storicamente alla memoria psicologica. “Le buone maniere, per definizione, sono quelle che caratterizzano il proprio gruppo; siamo costantemente guidati dalle loro esigenze, diventano una seconda natura per noi. IN Vita di ogni giorno non ci rendiamo conto che il loro scopo è rallentare l'aggressività e creare un'unione sociale” 3 . Il gruppo di persone in cui le cosiddette buone maniere erano molto più naturali di quelle "cattive", le trasmette di generazione in generazione, le fissa geneticamente. A questo proposito, i saggi giornalistici di ricercatori russi meritano la massima attenzione, a dimostrazione che dopo lo sterminio dell'intellighenzia russa da parte del governo sovietico, lo strato di nobili nel Paese è praticamente scomparso ...
Gli studi degli scienziati russi, che hanno ottenuto un grande successo nel campo dell'“inconscio storico”, mostrano chiaramente che sia la “saggezza che la malignità dei secoli” sono inconsciamente in grado di determinare il comportamento umano.
Tuttavia, solo le tradizioni secolari che sono entrate nell'inconscio sono in grado di influenzare il comportamento umano a questo livello oscuro?
Gli scienziati russi osservano: “La parte inconscia della psiche è solitamente associata all'attività della sottocorteccia, in cui è concentrata la principale matrice di informazioni filogenetiche, in altre parole, l'esperienza di specie e genere. Tuttavia, l'interpretazione di questo problema non è sufficiente, nemmeno semplificata. Non consente di spiegare correttamente, ad esempio, la localizzazione dei cosiddetti automatismi che si formano nell'ontogenesi della coscienza individuale, principalmente durante la formazione della psiche del bambino.
Di conseguenza, a livello dell'inconscio, si manifestano non solo la saggezza e la crudeltà dei secoli, ma anche tracce ontogenetiche che sono andate nell'ombra già nel processo di sviluppo individuale. Ciò significa che il livello dell'inconscio può essere suddiviso solo condizionatamente e solo ai fini di uno studio più scrupoloso in due blocchi:
- 1) un blocco di ciò che è storicamente ereditato nella coscienza, che detta la necessità di dimostrare il proprio "io" - l'effetto della filogenesi;
- 2) un blocco di ontogeneticamente acquisito, ma non superato lo stadio della consapevolezza.
Il secondo blocco dell'inconscio, da noi individuato, si forma nella psiche umana ricevendo da mondo esterno informazioni sensoriali. Tuttavia, queste informazioni non vengono realizzate, essendo elaborate e utilizzate a vari livelli mentali, che include, principalmente, la subcorteccia.
La parte inconscia dell'attività mentale è allo stesso tempo la parte inconscia dell'attività nervosa superiore. Allo stesso tempo, questa parte inconscia può passare alla coscienza, essere realizzata e, al contrario, ciò che è stato precedentemente realizzato può entrare nell'ombra inconscia, che I.P. Pavlov, e dopo di lui i moderni ricercatori russi, lo consideravano predominante e imperativo: "Grazie al subconscio, assimilato individualmente (riflesso condizionato) acquisisce l'imperativo e la rigidità insiti nei riflessi incondizionati" 1 .
Gli scienziati del ciclo criminale riflettono, forse, quelle tendenze che sono caratteristiche della questione che stiamo considerando per la ricerca psicofisiologica. Non c'è unità. Inoltre, i rappresentanti della scienza del diritto penale sono i più conservatori in materia di inconscio in relazione al movente. I manuali di diritto penale sottolineano, come mostrato sopra, la caratterizzazione di un movente come impulso cosciente: "Un movente è un impulso cosciente..." 2 .
Negli studi monografici, tuttavia, gli autori per qualche motivo mostrano grande cautela, sebbene ciò avrebbe dovuto essere fatto principalmente nei libri di testo, poiché sono la base per lo sviluppo dello studente. BS Volkov scrive: regola generale, il movente del delitto è un impulso cosciente, mediato dal desiderio di raggiungere lo scopo” 3 . rivendicare " regola generale”, osserva poco più in basso che i motivi possono essere in alcuni casi inconsci 4.
Nella ricerca dei criminologi, c'è molto più progresso nel campo dello studio dell'inconscio. I tempi del monopolio e della stigmatizzazione nella scienza sono andati nell'oblio e affermazioni inequivocabili che affermano di essere l'unica verità sono percepite come arcaiche.
Un tempo, e relativamente di recente, i criminologi scrivevano: “Nell'attività cosciente, inclusa la motivazione, ci sono sempre componenti inconsce o non pienamente coscienti. La scienza sovietica rifiuta le concezioni borghesi della motivazione, in cui gli impulsi innati e inconsci sono dichiarati come la fonte dell'attività umana. Tuttavia, non nega l'inconsapevolezza dei singoli elementi della motivazione del comportamento, sebbene la principale forza motrice dietro le azioni illegali sia la motivazione cosciente delle persone” 5 .
La realtà ha mostrato l'incoerenza di tali giudizi, che si riflette negli studi dei criminologi degli ultimi anni, dove si afferma sempre più il ruolo di primo piano in una serie di casi dell'inconscio nel sistema di determinazione del comportamento criminale. Alla fine, gli esperimenti condotti dagli psicologi dimostrano il ruolo guida dell'inconscio nel processo di scelta di una risposta comportamentale. Quindi, in uno degli esperimenti, a 1 acquirente è stato chiesto di valutare quattro paia di calze e scegliere la migliore. Nessuno dei partecipanti all'esperimento ha notato che tutte le calze sono uguali. La maggior parte ha scelto le calze situate sulla destra. Alla domanda sul motivo di questa scelta, gli acquirenti non hanno detto che tendono a scegliere le cose a destra. Allo stesso tempo, hanno affermato che la qualità del tessuto delle calze scelte era migliore. Quando i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti all'esperimento se la posizione del prodotto ha influenzato la loro scelta, hanno considerato tale domanda come la domanda di un pazzo. Valutando l'esperimento, Chris Paley osserva giustamente, ragionevolmente e allo stesso tempo arguto: “L'inconscio usa strani metodi per costringerci a fare una scelta. Il ruolo della coscienza è quello di offrire una spiegazione plausibile di come prendiamo una decisione” 2 .
Quindi, sia i motivi consci che, principalmente, inconsci possono agire come fattori motivanti del comportamento, in particolare il comportamento criminale. Nella letteratura psicologica e giuridica viene proposta una gerarchia di fattori rilevanti, che alla fine si riduce a una cosa: il bisogno, che è l'unica forza che determina il comportamento.
Paley K. Non importa. Mosca: Mann, Ivanov e Ferber, Ibid. P.110.
2015. S. 109-110.
- Rubinstein S.L. Fondamenti di psicologia generale: in 2 volumi T. II. M., 1989. S. 42. Aizman R.I., Krivoshchekov S.G. Basi fisiologiche dell'attività mentale. M.: INFRA-M, 2014. S. 141. Kovalev V.I. Motivi di comportamento e attività. M., 1988. S. 6.
- Là. S. 48. Nietzsche F. Poesie. M., 1991. S. 15.
- Ibsen G. Opere raccolte: in 4 volumi T. 3. M., 1957. S. 493. Kruglikov R.I. Il principio del determinismo e l'attività del cervello. M., 1988. S. 21. Moskalenko A.T., Serzhantov V.F. La personalità come soggetto della conoscenza filosofica. Novosibirsk, 1984, pagina 215. Zelinsky A.F. Conscio e inconscio nel comportamento criminale. Kharkiv, 1986. S. 88. Zelinsky A.F. Conscio e inconscio nel comportamento criminale. Kharkov, 1986. S. 89. Ossovsky M. Cavaliere e borghese. M., 1987. S. 82.
- BVS. 1990. N. 6. S. 14. Pescatore P. Miracoli e segreti del nostro cervello // All'estero. 1985. N. 10. S. 21. Vilyunas V.K. Meccanismi psicologici della motivazione biologica. M., 1986. S. 116. Garfield S. Teatro della crudeltà // All'estero. 1993. No. 10. P. 17. Spostamento, riorientamento dell'attacco: questo è forse il mezzo più ingegnoso inventato dall'evoluzione per dirigere l'aggressività in una direzione sicura // La conoscenza è potere. 1990. N. 7. S. 65. Zhukov N.I. Il problema della coscienza. Minsk, 1987, pagina 165. Simonov P.V. Circa due varietà dell'inconscio mentale: sub e supercoscienza. In: L'inconscio. Novocherkassk: Saguna, 1994. S. 61. Vedi, ad esempio: diritto penale sovietico. M., 1981. S. 191; Il corso di diritto penale sovietico: in 5 volumi T. 1. L., 1968. S. 441. Volkov B.S. Motivi per i crimini. Kazan, 1982. P. 9. Ibid. Il meccanismo del comportamento criminale / ed. V.N. Kudryavtsev. M., 1981. S. 61.
1. Per tipo, i motivi si distinguono:
1) sociale e cognitivo (cognitivo),
2) incentivo e formazione di senso,
3) esterno e interno,
4) conscio e inconscio,
5) reale e immaginario.
Motivi esterni provengono da insegnanti, altre persone, dalla società nel suo complesso e assumono la forma di suggerimenti, suggerimenti, richieste, istruzioni, sollecitazioni, coercizione. Agiscono, ma la loro azione incontra la resistenza interiore dell'individuo e quindi non può essere definita umana. vera fonte La motivazione di una persona è in se stessa - nei motivi interni. È necessario che il tirocinante stesso volesse fare qualcosa e lo ha fatto. Ecco perché si attribuisce un'importanza decisiva non ai motivi dell'apprendimento (pressione esterna), ma ai motivi dell'apprendimento (forze motivanti interne).
Motivi consapevoli si esprimono nella capacità dello studente di parlare delle ragioni che lo spingono ad agire, di costruire motivazioni secondo il grado di significatività.
Motivi inconsci percepiti solo in pulsioni di coscienza vaghe e incontrollate, ma allo stesso tempo possono essere forti.
Motivi reali compreso dagli studenti e dai loro insegnanti.
Immaginario (artificioso, illusorio) motivi potrebbe agire in determinate circostanze.
Il processo didattico dovrebbe essere basato su motivi reali e allo stesso tempo creare i prerequisiti per l'emergere di motivi nuovi, più alti e più efficaci che esistono al momento come promettenti nel programma di miglioramento.
2. Per livelli:
1) ampi motivi sociali (dovere, responsabilità, comprensione significato sociale insegnamenti; il desiderio dell'individuo attraverso l'insegnamento di affermarsi nella società, di affermare il proprio status sociale);
2) ristretti motivi sociali (o positivi) (desiderio prendere una certa posizione in futuro, ricevere riconoscimenti dagli altri, ricevere un degno
compenso per il proprio lavoro);
3) motivazioni della cooperazione sociale (orientamento ai vari modi di interagire con gli altri, affermando il proprio ruolo e la propria posizione nel gruppo);
4) ampi motivi cognitivi (manifestato come orientamento all'erudizione,
si realizzano come soddisfazione dal processo stesso di apprendimento e dai suoi risultati; attività cognitiva una persona è la sfera principale della sua attività di vita);
5) motivi educativi e cognitivi (orientamento ai metodi di acquisizione della conoscenza, assimilazione di specifiche soggetti);
6) motivi di autoeducazione (orientamento all'acquisizione di conoscenze aggiuntive);
3. Direzione e contenuto:
1) sociale (valore sociale),
2) educativo,
3) valore professionale,
4) estetico,
5) comunicazione,
6) stato positivo,
7) storico tradizionale,
8) utilitaristico-pratico (mercantile).
È stato stabilito che 1) determinati gruppi di motivi di apprendimento prevalgono in diversi periodi dello sviluppo della società; 2) gruppi di motivi sono in connessione dinamica tra loro, combinati in modi diversi a seconda delle condizioni emergenti. Da queste combinazioni viene motore dell'apprendimento. Il suo carattere, direzione, grandezza sono determinati dall'azione totale dei motivi.
Motivi diversi hanno diversi forza sul corso e sui risultati di un processo dinamico. Ad esempio, i motivi cognitivi ampi sono più deboli dei motivi educativi e cognitivi in un'area ristretta. In un ambiente competitivo, sono più significativi motivi utilitaristici e pratici. In questa connessione le motivazioni si dividono in incentivi(basato su azioni mirate) e significativo("tradurre" valori socialmente significativi a livello personale - motivazioni "per me". Ampi motivi sociali che in precedenza occupavano posto di primo piano, sono ora solo marginalmente attivi.
La teoria pedagogica domestica sta ancora cercando nuovi motivi nei vecchi valori. Tuttavia, dovrebbero essere ricercati nella soddisfazione degli interessi personali. IN mondo moderno siamo condannati a concentrarci sui valori eterni su cui si basa da tempo la pedagogia umanistica occidentale (IP Podlasy, 2000).
I nostri risultati di studi sui livelli di predominanza di vari motivi negli studenti universitari di medicina differiscono a seconda del loro corso di studi. Al momento dell'ammissione all'istruzione secondaria secondaria, gli studenti sono dominati da motivi di valore professionale e cognitivi, e dopo il diploma di scuola secondaria secondaria prevalgono motivi utilitaristici-pratici e di posizione. Il livello più basso in entrambi i gruppi sono motivi storico-tradizionali, estetici, comunicativi (Tabella 2.1.).
Gli individui percepiscono i loro bisogni in modi diversi.
1. A seconda di ciò, si distinguono motivi emotivi e razionali.
2. In psicologia si distinguono due gruppi di motivi interconnessi per la vita, il comportamento e l'attività. Il contenuto dei motivi generalizzati esprime il soggetto dei bisogni e la direzione delle aspirazioni dell'individuo. La forza di questo motivo è dovuta al grado di importanza per l'individuo dell'oggetto dei suoi bisogni. Le motivazioni strumentali sono determinate non solo dallo stato di bisogno dell'individuo, ma anche dal grado della sua preparazione, dalla presenza di altre opportunità per agire con successo al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati in queste condizioni. Questi gruppi di motivi (generalizzati e strumentali) insieme costituiscono la motivazione del comportamento e delle attività dell'individuo in determinate circostanze e possono non solo influenzarsi, ma anche cambiarsi a vicenda.
Tipi di motivi: ci sono consci e inconsci. Con motivazioni coscienti, una persona è consapevole di ciò che la spinge all'attività, che è il contenuto dei suoi bisogni. Questo tipo di motivi è caratterizzato da interessi, credenze, aspirazioni. Con motivi inconsci, una persona non si rende conto di ciò che lo spinge all'attività, che è il contenuto dei suoi bisogni. Questo tipo di movente è caratterizzato da atteggiamenti, pulsioni.
I motivi coscienti includono interessi, desideri, credenze, la loro forza motrice è grande, specialmente le credenze: sono in grado di controllare il comportamento e l'intera vita di una persona, persino superare l'istinto di autoconservazione (a causa della lealtà alle loro convinzioni, le persone sono anche colpito a morte).
Popolare
- Sottomarini del tipo Gato
- Insegne sulla flotta mercantile del distaccamento dell'URSS del II gruppo
- Come massimizzare la velocità della tua connessione Internet Scegliere il miglior browser
- Modi produttivi per trascorrere del tempo online
- Nascondere le foto di VKontakte
- Tim Berners-Lee - creatore del World Wide Web
- Inizia con la scienza Peso netto delle uova senza guscio = - - - - - - - - -
- Come eliminare le foto nei compagni di classe Come rimuovere la canutiglia da una foto sui compagni di classe
- Come aggiungere una foto in un contatto?
- Tatyana Gordienko: Altri designer mi copiano e ne sono felice!