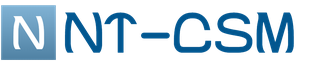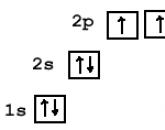Dizionario enciclopedico russo. enciclopedie
Per restringere i risultati della ricerca, puoi affinare la query specificando i campi su cui eseguire la ricerca. L'elenco dei campi è presentato sopra. Per esempio:
Puoi cercare in più campi contemporaneamente:
operatori logici
L'operatore predefinito è E.
Operatore E significa che il documento deve corrispondere a tutti gli elementi del gruppo:
Ricerca e Sviluppo
Operatore O significa che il documento deve corrispondere a uno dei valori nel gruppo:
studio O sviluppo
Operatore NON esclude i documenti contenenti questo elemento:
studio NON sviluppo
Tipo di ricerca
Quando si scrive una query, è possibile specificare il modo in cui verrà cercata la frase. Sono supportati quattro metodi: ricerca basata sulla morfologia, senza morfologia, ricerca di un prefisso, ricerca di una frase.
Per impostazione predefinita, la ricerca si basa sulla morfologia.
Per cercare senza morfologia, è sufficiente anteporre il simbolo del "dollaro" alle parole della frase:
$ studio $ sviluppo
Per cercare un prefisso, è necessario inserire un asterisco dopo la query:
studio *
Per cercare una frase, è necessario racchiudere la query tra virgolette:
" ricerca e sviluppo "
Cerca per sinonimi
Per includere i sinonimi di una parola nei risultati di ricerca, metti un cancelletto " #
" prima di una parola o prima di un'espressione tra parentesi.
Se applicato a una parola, verranno trovati fino a tre sinonimi.
Se applicato a un'espressione tra parentesi, verrà aggiunto un sinonimo a ciascuna parola se ne è stata trovata una.
Non compatibile con ricerche senza morfologia, prefisso o frase.
# studio
raggruppamento
Le parentesi vengono utilizzate per raggruppare le frasi di ricerca. Ciò consente di controllare la logica booleana della richiesta.
Ad esempio, è necessario fare una richiesta: trovare documenti il cui autore è Ivanov o Petrov e il titolo contiene le parole ricerca o sviluppo:
Ricerca di parole approssimative
Per una ricerca approssimativa, devi inserire una tilde " ~ " alla fine di una parola in una frase. Ad esempio:
bromo ~
La ricerca troverà parole come "bromine", "rum", "prom", ecc.
È inoltre possibile specificare importo massimo modifiche possibili: 0, 1 o 2. Ad esempio:
bromo ~1
Il valore predefinito è 2 modifiche.
Criterio di prossimità
Per cercare per vicinanza, devi mettere una tilde " ~ " alla fine di una frase. Ad esempio, per trovare documenti con le parole ricerca e sviluppo all'interno di 2 parole, utilizzare la seguente query:
" Ricerca e Sviluppo "~2
Rilevanza dell'espressione
Per modificare la rilevanza delle singole espressioni nella ricerca, utilizzare il segno " ^
" alla fine di un'espressione, e poi indicare il livello di rilevanza di questa espressione rispetto alle altre.
Più alto è il livello, più rilevante è l'espressione data.
Ad esempio, in questa espressione, la parola "ricerca" è quattro volte più rilevante della parola "sviluppo":
studio ^4 sviluppo
Per impostazione predefinita, il livello è 1. I valori validi sono un numero reale positivo.
Cerca all'interno di un intervallo
Per specificare l'intervallo in cui dovrebbe trovarsi il valore di un campo, è necessario specificare i valori limite tra parentesi, separati dall'operatore A.
Verrà eseguito un ordinamento lessicografico.
Tale query restituirà risultati con l'autore che inizia da Ivanov e termina con Petrov, ma Ivanov e Petrov non saranno inclusi nel risultato.
Per includere un valore in un intervallo, utilizzare le parentesi quadre. Usa le parentesi graffe per sfuggire a un valore.
© AV Smirnov 2001
X UKM(“giudizio”) – insieme ai concetti di “azione” ( Fil) e "intenzione" ( niyya), una delle categorie principali Etica musulmana. Come i concetti di "azione" e "intenzione", X UKM non è una categoria specificamente etica. Al contrario, questo concetto è ampiamente utilizzato nella scienza arabo-musulmana: in filologia, giurisprudenza, logica e altre discipline teoriche e filosofiche. Nella legge islamica, la parola " X UKM” sta per qualsiasi specifico norma giuridica, stabilito in relazione a una cosa o azione (quote di eredità, correttezza dei contratti, ecc.), nonché la qualificazione di un atto secondo il sistema delle "cinque categorie" (al-ahkam al- hamsa). In filosofia, il termine X UKM" denota la conclusione ("giudizio") del sillogismo, e anche, in senso lato, la qualificazione di una cosa, stabilita sulla base dell'una o dell'altra delle sue proprietà. Ad esempio, il termine può essere utilizzato quando si discute esattamente di come viene valutata l'azione di una persona: come prodotto della sua libera scelta o risultato dell'intervento divino; entrambe le soluzioni sono indicate come X UKM(valutazione, qualificazione) di un atto. Per quanto riguarda la teoria etica, possiamo dirlo con il cosiddetto. contenuto, rappresenta l'emanazione di determinati giudizi sui complessi semantici "intenzione - atto" (cfr. fi‘ l, Niya). Il giudizio in etica è una certa qualificazione, che viene data a un atto in base alla sua correlazione con l'intenzione.
Il sistema dei giudizi, che opera teoria etica, è strettamente correlato a quello usato nel fiqh (giurisprudenza), e può essere considerato come una sua modifica. Allo stesso tempo, la differenza essenziale tra il sistema dei giudizi etici e quello religioso-giuridico è l'assenza di un'area di azioni indifferenti (mubax): il giudizio etico si distingue per la sua totalità, e la motivazione etica copre un sfera del comportamento umano molto più ampia della motivazione religioso-legale.
Fiqh opera con un sistema di giudizi a cinque termini (ahkam). Le azioni si dividono in: a) obbligatorie ( INUN fiocco), b) raccomandato (mandub), c) indifferente, d) sconsigliato (makrux), e) inammissibile (xaram). Questa classificazione correla, da un lato, con il comando ('amr) e il divieto (nahy), e dall'altro, con la questione della ricompensa dell'aldilà (jaza'), se si tratta di una ricompensa (s avab) o punizione(‘ikab). Comando e divieto esprimono la volontà del Legislatore, cioè Dio stesso; in altri casi, le leggende sulle parole e le azioni di Maometto (hadith) servono come fonte per determinare ordini e divieti. La combinazione di questi due lati - prescrizione / divieto e punizione - determina il giudizio correlato a questo o quell'atto. Obbligatorie sono le azioni prescritte dal Legislatore e la cui attuazione è premiata e l'inadempimento è punito. Le azioni sono inammissibili, la segale è vietata dal Legislatore, il cui mancato impegno viene premiato e la commissione è punita. Si raccomandano le azioni prescritte, il cui inadempimento non è punito, ma la cui commissione è premiata. Non raccomandati sono quelli la cui commissione non è punita, ma l'astensione dalla quale è ricompensata.
Questo complesso sistema di qualifiche è sorto storicamente, nel corso dell'analisi dei testi religiosi e giuridici fondamentali: il Corano e la Sunnah. L'introduzione di categorie di azioni raccomandate e sconsigliate è stata ampiamente coerente con la necessità di interpretare i divieti e le raccomandazioni non categoriche contenute in questi testi. Allo stesso tempo, il sistema di cinque categorie, così come esiste nel fiqh, indica che la cultura islamica non ha sentito il bisogno di formare un tale sistema di classificazione delle azioni, che sarebbe stato costruito su una rigorosa dicotomizzazione dei concetti di bene e male . Nella forma in cui è realmente esistito nella cultura islamica, il pensiero religioso e giuridico (fiqh) sembra fondere in un unico sistema di categorie ciò che nella cultura europea era storicamente diviso tra due varie zone Diritto e morale religiosa. Sfera diritti costruito lì sull'idea della necessità della celebrazione giustizia, alla fine salendo all'idea Bene, e presuppone una divisione incondizionata di ciò che è appropriato e ciò che non è coerente con l'idea di giustizia. In linea di principio, il diritto presuppone che ciò che è incompatibile con l'idea di giustizia sia soggetto a punizione o, comunque, restrizione. La sfera della moralità religiosa (cristiana) stabilisce un diverso sistema di coordinate semantiche, offrendo l'idea di bene come linea guida massima, qualsiasi approccio a Krom è encomiabile, anche se il mancato approccio non può essere condannato religiosamente, e dando origine a un intero sistema di istituzioni, idee e pratiche focalizzate a stimolare il raggiungimento di tale massimo: per un credente, il l'ideale morale di un santo, passionista, martire (e in una prospettiva infinita - Cristo stesso) stabilisce il criterio di valutazione etica, secondo il quale un atto che non è buono non si rivela necessariamente cattivo e soggetto a punizione.
Esternamente, il sistema di quattro categorie stimolanti-proibitive utilizzato dal fiqh sembra unire ciò che nella cultura europea è diviso tra due sfere. Ma è impossibile non notare che tale rappresentazione risulta essere puramente esterna. Il sistema del diritto e della morale religiosa difficilmente possono essere combinati senza abbandonare le categorie fondamentali per entrambi. Ma il punto è proprio che per il pensiero religioso e giuridico musulmano, l'idea regolatrice più alta non è il concetto di bene o bontà (come si può vedere nella cultura europea), ma il grado di prescrizione o divieto di questo o quell'atto. Sebbene esteriormente il sistema di categorie utilizzato dal pensiero religioso e giuridico dell'Islam assomigli a certe istituzioni giuridiche e religiose ed etiche della cultura europea, in sostanza vi è una grave discrepanza tra di esse.
Quanto agli atti indifferenti, essi includono quelli la cui commissione o mancata commissione non viola la volontà del Legislatore. Questa è precisamente l'area che non rientra nel campo visivo del pensiero religioso e giuridico e non è soggetta a diretta regolamentazione religiosa e giuridica.
Tuttavia, tali azioni possono essere soggette a valutazione morale. Il sistema delle categorie etiche è più semplice di quello usato nel fiqh. Il ragionamento etico opera, di regola, in due categorie: un atto può essere valutato come "buono" ( X asana) o "cattivo" (A abE X). Queste valutazioni si basano sull'idea di azioni meritorie o biasimevoli. In questo caso, di norma, si ha in mente un'interpretazione correlativa, e non assoluta, dei concetti “buono” e “cattivo”; I Mu'taziliti cercarono però, senza molto successo, di offrirne un'interpretazione assoluta (cfr. CalUN M). Ciò a cui un atto è correlato, per essere giudicato come "buono" o "cattivo", è o un comando e un divieto in quanto tale, o il sistema di cinque categorie usato nel fiqh. Poiché la valutazione di "buono-cattivo" è binaria e il sistema quinquennale di categorie è fondamentalmente non dicotomico, la definizione di un atto come buono o cattivo attraverso la correlazione con i cinque giudizi del fiqh è quasi sempre paradossale. Se consideriamo buono tutto ciò “in cui non c'è difetto”, allora anche le azioni sconsigliate dovrebbero essere classificate come buone, poiché non contengono un difetto, poiché la loro commissione non comporta punizione. Se tutto ciò che non porta ricompensa o beneficio è considerato cattivo, allora tutte le azioni indifferenti dovrebbero essere dichiarate cattive. L'assoluta assurdità di tali risultati ci ha costretti a cercare altri modi per definire i concetti di "buono-cattivo". La ricerca è andata anche nella direzione di una definizione correlativa. È stato proposto di considerare buone tali azioni, la cui commissione è preferibile ( avvUN) rispetto al non fare, e quelli cattivi, il non fare to-rykh è preferibile all'impegno; tuttavia, questa classificazione è stata integrata da un terzo elemento, le azioni obbligatorie, al fine di preservare l'imperatività di alcune prescrizioni, che non possono essere intese correlativamente. Questa classificazione risulta essere, per così dire, un'estensione dei concetti “raccomandato-sconsigliato” a tutte le azioni, eccetto quelle obbligatorie, e rimane poco chiaro il destino dei divieti categorici complementari agli imperativi categorici.
Letteratura:
At-TahUN navE . Kashshaf ètilaxat al-funun. T.1-2, Istanbul, W.N.Lees; Stampa, 1984
Ibn AT - T ayyb. al-Mu‘tamad fi ’usul al-fiqkh. T. 2. Damasco: 1965
(RES) occupa un posto speciale tra le enciclopedie presentate al Rubricon. Non solo continua la tradizione dei dizionari enciclopedici pubblicati dalla casa editrice Big Russian Encyclopedia negli ultimi vent'anni. RES cade involontariamente in una nicchia destinata a un'enciclopedia universale multivolume su scala nazionale. Questo ruolo continua ad essere svolto fino ad oggi dalla Grande Enciclopedia Sovietica (BSE), che finora rimane la fonte di informazioni più completa e affidabile in vari campi. conoscenza moderna. Tuttavia, molti eventi e cambiamenti avvenuti nell'arco di un quarto di secolo, che ci separano dalla pubblicazione dell'ultimo volume del TSB, richiedono urgentemente una loro riflessione a livello enciclopedico. È questo compito che oggi il RES è chiamato a risolvere, anche se in uno stile molto più “compresso”, ma così dovrebbe essere un dizionario.
RES e TSB inclusi in unico sistema la ricerca e la navigazione del Rubricon, insieme formano un complesso informativo unico che non ha analoghi in Runet. Il numero totale di articoli è superiore a 165 mila, di cui circa 70 mila sono inclusi nel RES. Completandosi a vicenda, RES e TSB si trasformano in uno straordinario strumento efficace ottenere informazioni, che gli utenti possono verificare molto rapidamente.
Se tocchiamo come è stato creato il dizionario enciclopedico russo, va notato che gli autori e gli editori hanno cercato di aggiornare ed espandere le informazioni contenute nei precedenti dizionari ed enciclopedie. Utilizzando gli array di informazioni costantemente riforniti della casa editrice, nonché i materiali pubblicati negli ultimi anni dalla casa editrice di enciclopedie tematiche, dizionari e libri di consultazione, hanno incluso centinaia di nuovi articoli e riferimenti nel RES. Molti materiali del dizionario coprono i problemi della storia e lo stato attuale dell'umanità. Notevole attenzione è rivolta a questioni di letteratura, arte, religione, diritto, filosofia, sociologia, economia ed etnologia. Il dizionario contiene informazioni sulla geografia fisica e socio-economica, tecnologia, matematica, fisica, chimica, geologia, biologia, medicina, sport, ecc. Particolare attenzione nei materiali del dizionario è rivolta alle nuove discipline scientifiche che si sono sviluppate negli ultimi decenni del XX secolo. Ci sono matrici significative di articoli sull'ecologia e la protezione dell'ambiente.
Il blocco biografico del dizionario comprende articoli su personaggi statali, politici e pubblici di tutti i paesi del mondo, su personaggi religiosi, capi militari, scienziati e personaggi della cultura che hanno lasciato un segno notevole nella storia della civiltà.
I creatori del dizionario hanno cercato di illuminare completamente i problemi del passato e del presente della Russia, per riflettere il suo posto e il suo ruolo nel mondo che cambia. Il lettore troverà in esso articoli su tutti gli argomenti Federazione Russa e città, su oggetti naturali e storico-culturali, eventi storici, su persone le cui attività sono legate alla storia del nostro paese.
Il dizionario comprende diverse migliaia di illustrazioni. Rappresentano i paesaggi della Russia, i monumenti della cultura nazionale, i popoli che abitano il nostro paese. Un taccuino separato di illustrazioni è occupato da ritratti di personaggi storici della Russia.
Biologico parte integrale Il dizionario è un insieme di applicazioni, comprese tabelle di quantità fisiche, misure e pesi, unità monetarie, materiali economici e statistici, tabelle cronologiche sulla storia russa e mondiale.
Dizionario enciclopedico russo: in 2 libri. / Cap. Ed .: A. M. Prokhorov M .: Great Russian Encyclopedia, 2001, Book. 1: A-N., Libro. 2: N-I. 2015 p.: ill.
Dizionario enciclopedico russo / M .: Grande enciclopedia russa, 2001
Il Dizionario enciclopedico russo (RES) occupa un posto speciale tra le enciclopedie presentate al Rubricon. Non solo continua la tradizione dei dizionari enciclopedici pubblicati dalla casa editrice Big Russian Encyclopedia negli ultimi vent'anni. RES cade involontariamente in una nicchia destinata a un'enciclopedia universale multivolume su scala nazionale. Questo ruolo continua ad essere svolto fino ad oggi dal Big enciclopedia sovietica» (TSB), che finora rimane la fonte di informazioni più completa e affidabile su varie aree della conoscenza moderna. Tuttavia, molti eventi e cambiamenti avvenuti nell'arco di un quarto di secolo, che ci separano dalla pubblicazione dell'ultimo volume del TSB, richiedono urgentemente una loro riflessione a livello enciclopedico. È questo compito che oggi il RES è chiamato a risolvere, anche se in uno stile molto più “compresso”, ma così dovrebbe essere un dizionario.
RES e TSB, inclusi nel sistema unificato di ricerca e navigazione del Rubricon, formano insieme un complesso informativo unico che non ha analoghi in Runet. Il numero totale di articoli è superiore a 165 mila, di cui circa 70 mila sono inclusi nel RES. Completandosi a vicenda, RES e TSB si trasformano in uno strumento insolitamente efficace per ottenere informazioni, che gli utenti possono verificare molto rapidamente.
Se tocchiamo come è stato creato il dizionario enciclopedico russo, va notato che gli autori e gli editori hanno cercato di aggiornare ed espandere le informazioni contenute nei precedenti dizionari ed enciclopedie. Utilizzando gli array di informazioni costantemente riforniti della casa editrice, nonché i materiali pubblicati negli ultimi anni dalla casa editrice di enciclopedie tematiche, dizionari e libri di consultazione, hanno incluso centinaia di nuovi articoli e riferimenti nel RES. Molti materiali del dizionario coprono i problemi della storia e lo stato attuale dell'umanità. Notevole attenzione è rivolta a questioni di letteratura, arte, religione, diritto, filosofia, sociologia, economia ed etnologia. Il dizionario contiene informazioni sulla geografia fisica e socio-economica, tecnologia, matematica, fisica, chimica, geologia, biologia, medicina, sport, ecc. Particolare attenzione nei materiali del dizionario è rivolta alle nuove discipline scientifiche che si sono sviluppate negli ultimi decenni del XX secolo. Ci sono matrici significative di articoli sull'ecologia e la protezione dell'ambiente.
Il blocco biografico del dizionario comprende articoli su personaggi statali, politici e pubblici di tutti i paesi del mondo, su personaggi religiosi, capi militari, scienziati e personaggi della cultura che hanno lasciato un segno notevole nella storia della civiltà.
I creatori del dizionario hanno cercato di illuminare completamente i problemi del passato e del presente della Russia, per riflettere il suo posto e il suo ruolo nel mondo che cambia. Il lettore troverà in esso articoli su tutti i temi della Federazione Russa e delle città, su oggetti naturali e storico-culturali, eventi storici, su persone le cui attività sono legate alla storia del nostro paese.
Il dizionario comprende diverse migliaia di illustrazioni. Rappresentano i paesaggi della Russia, i monumenti della cultura nazionale, i popoli che abitano il nostro paese. Un taccuino separato di illustrazioni è occupato da ritratti di personaggi storici della Russia.
Parte integrante del dizionario è un insieme di applicazioni, tra cui tabelle di quantità fisiche, misure e pesi, unità monetarie, materiali economici e statistici, tabelle cronologiche sulla storia russa e mondiale.
Etica. Dizionario Enciclopedico / Ed. R. Apresyan, A. Huseynov. - M., 2001
« Bravo nell'insegnamento gr. Tolstoj e F. Nietsche (Filosofia e predicazione)"- il lavoro di Lev Shestov, che ha determinato la natura esistenziale delle sue ricerche filosofiche e religioso-morali e ha preparato la "revisione" della tradizione etica, che ha raggiunto il suo apice nell '"etica paradossale" di N.A. Berdyaev (vedi "Sul Nomina dell'uomo”). Secondo SN Bulgakov, gli atteggiamenti mentali di Shestov, già formati nei suoi primi lavori, “rappresentano una serie di tentativi di esprimere in modo nuovo un tema principale: l'apoteosi dell'”infondatezza” filosofica, che non significa altro che la filosofia della fede. " La critica della ragione etica, intrapresa da Shestov, è l'esperienza di sostanziare la moralità sulla base dell '"infondatezza filosofica", o filosofia della fede.
Può essere considerato molto significativo che V.S. Soloviev, avendo preso conoscenza del manoscritto del libro di Shestov, abbia consigliato all'autore di non affrettarsi a pubblicare il suo lavoro, rendendosi conto della serietà della controargomentazione etica in esso espressa. Tuttavia, fu con l'assistenza di Solovyov che il libro di Shestov fu pubblicato nel 1900. La risposta specifica di LN Tolstoy al lavoro scritto su di lui è sconosciuta, specialmente nel contesto del confronto del suo "sermone" con la "filosofia" di F. Nietzsche. A giudicare dalle voci del diario di Tolstoj e dalle memorie del suo segretario (VF Bulgakov), Tolstoj non ha letto questo libro (sebbene il libro stesso sia conservato nella biblioteca di Yasnaya Polyana). Tuttavia, è noto che dopo una conversazione personale con Shestov, Tolstoj parlò di lui come "uno scrittore e per niente un filosofo" (Diari, 2 marzo 1910). Questa valutazione può essere considerata una sorta di risposta di Tolstoj al libro di Shestov, che stava solo cercando di dimostrare che Tolstoj era un filosofo nelle sue opere letterarie. ("Guerra e pace" è un'opera veramente filosofica, e Tolstoj è un filosofo nel senso migliore e più nobile del termine, poiché descrive la vita da tutti i suoi lati più enigmatici e misteriosi.) La filosofia di Tolstoj, provando, secondo Shestov , credere all'armonia della vita con “l'algebra della bontà”, rivela l'unidimensionalità e l'impotenza della predicazione.
È così che Shestov affronta uno dei temi principali del suo filosofare: il tema della "sostituzione" della vita con il bene, dell'ontologia con l'etica. Cerca anzitutto di svelare i veri motivi per porre il problema stesso del “significato del bene”, “giustificare il bene”, “servire il bene”. L'esperienza dell'evoluzione di Tolstoj dalla filosofia della vita alla predicazione della bontà significa la trasformazione di un problema filosofico in una "questione personale", "la collocazione della bontà sul letto di Procuste della propria vita". Ma la ragione principale della “sostituzione” sta altrove: nella paura soggettiva e nell'impotenza della mente umana davanti al mistero della vita, davanti alla legge della necessità. Ciò a cui la mente si considera soggetta, lo chiama "buono"; tutti gli elementi della vita che non sono soggetti alla ragione sono da lui respinti come "cattivi". Nasce così il fenomeno della "razionalizzazione etica dell'essere". Secondo Shestov, "l'etica è nata insieme alla ragione"; i concetti di "ragione" ed "etica" sono sinonimi. Non sorprende che per Shestov tutti i filosofi siano in realtà etici; Tolstoj è solo un caso estremo ed evidente. Le uniche eccezioni sono Plotino, Nietzsche, FM Dostoevskij, S. Kierkegaard ed E. Husserl.
Shestov sottolinea che il fenomeno stesso della "razionalizzazione etica", che comporta la sostituzione della vita con il bene, è possibile solo nelle condizioni della perdita della fede autentica e evidente, quando il bene diventa oggetto di fede, quando Dio è inteso come buono, e buono come Dio. È in questa etizzazione della coscienza religiosa che Shestov vede l'essenziale somiglianza tra le posizioni di Tolstoj e Nietzsche. Il detto di Tolstoj "Dio è buono" e le parole di Nietzsche "Dio è morto" sono, secondo Shestov, "espressioni inequivocabili". Tuttavia, Nietzsche non si è fermato alla bontà di Tolstoj. Shestov definisce il suo passaggio dalla bontà alla vita, dall'etica all'ontologia come "la rivolta della coscienza contro la bontà". La coscienza, come voce interiore della vita e soglia della fede, restituisce a una persona una percezione olistica della vita, espressa da Nietzsche in amor fati (amore per il rock). Ciò ha permesso a Nietzsche di riconoscere che "il male è necessario quanto il bene, che lo sono entrambi condizione necessaria l'esistenza e lo sviluppo umano, e che il sole sorge ugualmente sui buoni e sui cattivi". Tuttavia, Nietzsche, secondo Shestov, non ha resistito a questa fase. Dalla predicazione del bene attraverso la filosofia della vita, si passa non alla filosofia della fede, ma a una nuova predicazione della moralità del "superuomo". La via della fede si rivelò chiusa per lui, e Nietzsche cadde nuovamente nella "tentazione" del razionalismo etico. Il libro di Shestov termina con le parole programmatiche: “Dobbiamo cercare ciò che è più alto della compassione, più alto della bontà. Dobbiamo cercare Dio". Shestov non rinuncia affatto all'etica, ma si pone il compito di giustificare l'etica nel quadro della filosofia della fede, creando un'etica che si baserebbe non sulla libertà di scelta tra il bene e il male, ma sulla "libertà del bene", che determina il trionfo finale e la vittoria del bene sulla vita. L'"etica della fede" di Shestov è chiamata da un'incomprensibile partecipazione divina ad abolire il "antico male" ("la sofferenza di Giobbe", "la morte di Socrate", "il tradimento di Giuda", ecc.), trasformandolo in un modo super razionale e assurdo di "bene che non era ancora". In questo senso, l'etica di Shestov può essere definitivamente definita come "giustificazione solo per fede del bene non ancora passato".
Lett .: Berdyaev N.A. L'albero della vita e l'albero della conoscenza // Via. 1929. N. 18; Bulgakov S.N. Operazione. in 2 t. M.: Nauka, 1993. Vol. 1; Baranova-Shestova N.L. Vita di Lev Shestov. Secondo la corrispondenza e le memorie dei contemporanei. MANCIA. Parigi: YMCA-Press, 1983; Shestov L. Buono negli insegnamenti di gr. Tolstoj e F. Nietzsche (Filosofia e predicazione) // Vopr. filosofia 1990. N. 7; Fondane B. Rencontres con Leon Chestov / Parigi: Plasma, 1982.
VN Nazarov
Immoralismo (< лат. in - не-, moralis - моральный, нравственный) — философская позиция, претендующая на выход за сковывающие рамки существующих моральных понятий и ценностей. И. не следует отождествлять с аморализмом — житейской позицией, намеренно отвергающей моральные нормы, а также с нигилизмом, ограничивающимся только отрицанием общепринятых моральных норм и ценностей. Впервые термин «И.» был употреблен для обозначения тех учений, к-рые не рассматривают моральной стороны явлений, т.е. моральный индифферентизм (В.Круг). Однако в широкий философский обиход данное понятие ввел Ф.Ницше, давший ему более глубокое толкование. В произведении «По ту сторону добра и зла» он желает встать на «внеморальную» т.з., с к-рой критикует современную культуру и философию, основанные на христианской морали. Но критический пафос Ницше направлен не на мораль саму по себе, а на общепринятые нормы поведения. Он при этом допускает, что «возможны другие..., высшие морали», имеющие абсолютное значение, ради к-рых стоит производить «переоценку ценностей». Ницше рассматривает традиционные нравственные идеалы (добро, сострадание, любовь, смирение) с т.з. «природы», «жизненного инстинкта», «воли к власти» и утверждает, что первые не способствуют укреплению жизненной силы индивида, а напротив — делают его слабым безликим «стадным животным». Напротив, эгоизм, гордость, презрение к мещанству и посредственности, ярко выраженная индивидуальность способствуют развитию сильной личности, за к-рыми Ницше усматривает будущее человеческого рода. Анализируя взгляды Ницше, О.Шпенглер дает наиболее точную формулировку И. как нового рода морали «с притязанием на преимущество по сравнению со всеми прочими». Ницшеанская мораль стремится стать по ту сторону самих понятий добра и зла. Однако по своей сути И. близок к релятивизму (см. Абсолютизм и релятивизм), утверждая, что каждый вправе иметь свою систему оценок и по ее критериям судить устоявшиеся моральные требования.
Nonostante il fatto che Nietzsche abbia iniziato a usare attivamente il termine "io" per la prima volta, la tradizione di I., espressa nel desiderio di liberarsi dalle catene dei soliti fondamenti morali per amore di una maggiore libertà, è sempre stata esisteva nella storia della filosofia. Nel buddismo c'è l'idea di un saggio-bhikkhu, che, avendo acquisito conoscenza e raggiunto l'illuminazione, si trova dall'altra parte del mondo vano, incl. "Sta al di sopra del bene e del male". L'antichità poneva il seguito della virtù in prima linea nella vita morale, a cui conduce la natura stessa (stoicismo). Ma il cristianesimo ha sottolineato la differenza tra la virtù (legge) e lo stato interiore dell'uomo (grazia), aprendo così un mondo morale diverso. Al. Paolo dice: "Il potere del peccato è la legge". Per la salvezza non basta seguire alla lettera la legge di Mosè, l'importante è acquisire fede, amare Dio e accettare l'immagine di Cristo come il più alto ideale morale. Se l'antico saggio subordinava la sua volontà alla mente del mondo (Logos), allora l'asceta cristiano allinea la propria volontà alla Divina Provvidenza, il che è incomprensibile. Successivamente, nella tradizione della teologia apofatica (Dionigi l'Areopagita, Gregorio Palamas), si sostiene che né le nostre solite idee di bene e male, né altre definizioni filosofiche possono essere attribuite a Dio, perché è superiore a loro.
Il nuovo tempo fa la propria rivalutazione dei valori. I cambiamenti stanno avvenendo non nelle virtù e nei comandamenti stessi, che rimangono formalmente cristiani, ma nella loro motivazione, che risale all'antichità, ma con una dipendenza molto maggiore dalla mente umana. L'era rinascimentale ha ravvivato l'antico interesse per la natura, ma la New Age sta perdendo la visione olistica dei greci sul mondo come unità organica di verità, bontà e bellezza. L'illuminismo considera unilateralmente la natura come un meccanismo indifferente al bene e al male. Quindi "l'uomo-macchina" (J.O. Lametrie) non ha bisogno di alcuna moralità. La filosofia del romanticismo interpretava la natura solo come un fenomeno estetico, privo di una dimensione morale; lo scopo dell'uomo è sviluppare tutti i suoi poteri nascosti, raggiungere il suo potere creativo. Per I. Goethe e i romantici, la virtù più alta è il genio. Nel panlogismo di G. W. F. Hegel, lo Spirito del mondo sulla via della realizzazione dell'idea di libertà riconcilia tutte le contraddizioni; l'opposizione del bene e del male è in definitiva immaginaria, poiché lo Spirito adatterà anche le più terribili manifestazioni del male ai propri scopi.
La filosofia della vita proponeva il concetto stesso di "vita" come una sorta di fondamento semplice e indecomponibile dell'essere umano. La vita non è né buona né cattiva, non dipende da nulla, ma influisce su tutto. S. Kierkegaard ha visto la sua più alta realizzazione nella fase religiosa dello sviluppo dell'esistenza umana. Ma per scalarlo bisogna abbandonare le istituzioni morali secolari. Nietzsche ha aderito in modo più coerente al principio di I., così come il suo precursore, M. Stirner, che ha affermato direttamente che il bene e il male "non hanno senso per me", e ha proposto di introdurre una diversa scala di valori - " mio - non mio."
Nel 20 ° secolo solo il fascismo pretendeva di essere libero da ogni vincolo morale, frutto di una lettura estremamente superficiale di Nietzsche. Esistenzialismo, ch.o. A. Camus e J.P. Sartre sottolineano l'assoluta libertà di una persona (libertà di scelta), con l'aiuto della quale crea il proprio mondo morale, non prestando attenzione a nessuna regolamentazione sociale, scegliendo così la responsabilità assoluta delle sue azioni . Le caratteristiche di I. sono inerenti alla filosofia moderna del postmodernismo. Sono apparsi come reazione all'ideologia del liberalismo, che afferma che la moralità dovrebbe essere ridotta a perfette istituzioni sociali e legge. M. Foucault chiama tale moralità “un modo di soggiogare se stessi” e riflette molto (come J. Deleuze, J Derrida, ecc.) su come una persona possa sfuggire al giogo del potere e della moda.
Lett.: Nietzsche F. Volontà di potenza. Mosca: Zhanna, 1994; Fullier A. Nietzsche e l'immoralismo. San Pietroburgo: pubblica utilità, 1905; Spengler O. Declino dell'Europa. Saggi sulla morfologia della storia del mondo. M.: Pensiero, 1993. S. 524-566; Stirner M. L'unico e la sua proprietà. Charkov: Osnova, 1994.
AA. Skvortsov
« Alla genealogia della morale"("Zur Genealogie der Moral", 1887) - un'opera di F. Nietzsche, concepita come appendice all'opera "Beyond Good and Evil" (1886). Il primo russo edizione in trad. VA.Weinstock - "La genealogia della morale: opuscolo" (1908). Lo scopo del lavoro è una critica dei valori morali. Per raggiungere questo obiettivo, Nietzsche utilizza il metodo genealogico, che consiste nel rivelare il significato dei valori attraverso l'esplicazione delle origini storiche e delle forme primarie del fenomeno in questione, le cause della deformazione o l'occultamento del suo significato originario. "A g.m." si compone di tre sezioni - "considerazioni". La sezione I solleva la questione della base dei giudizi di valore. Nietzsche giunge alla conclusione che le differenze nella comprensione del bene e del male sono principalmente legate alla differenza tra due tipi di moralità: la moralità dei "padroni", degli "aristocratici" e la moralità degli "schiavi". Si tratta di due sistemi di valori radicalmente diversi, ognuno dei quali ha i propri fondamenti socio-psicologici, il proprio meccanismo di formazione e funzionamento. La moralità dei "maestri" ("moralità primaria") è primordiale, "naturale" e nasce dalla "trionfante autoaffermazione" dell'uomo come forza sfrenata della natura. La moralità degli “schiavi” è secondaria, è “non un'azione, ma una reazione”, questa è la risposta dei deboli, dei deboli, “l'odio represso, la vendetta degli impotenti”, l'espressione del risentimento - malizia vendicativa. Nietzsche ha il merito di aver scoperto il fenomeno del risentimento. Egli considera la volontà di potenza tra i vinti, gli umiliati, i deboli, come il fondamento più profondo del risentimento, il risentimento è una forma trasformata di questa volontà. Presupposto necessario il risentimento è uno sfondo emotivo negativo: ostilità, rabbia, vendetta, invidia, gelosia. Il risentimento è uno sguardo valutativo, rivolto non a se stessi, ma all'esterno, è “no” a tutto il resto, alieno, di successo, davvero alto, sano, potente, che diventa una forza creativa. Usando l'etimologia dei termini morali, Nietzsche dimostra che il concetto di bene nella morale aristocratica risale al concetto di "nobile", "nobile" (quanto i nobili e i nobili percepivano se stessi e le loro azioni come "buoni"), e il concetto di cattivo - al basso, plebeo nel senso di classe . Nietzsche collega l'emergere della morale del secondo tipo con la "rivolta degli schiavi nella morale" e la "rivalutazione dei valori" che hanno prodotto. La propria impotenza è stata reinterpretata come "gentilezza", codarda meschinità come "umiltà", sottomissione a coloro che sono odiati come "obbedienza", incapacità di difendersi come riluttanza a vendicarsi o perdono, ecc. Da quando ha prevalso la moralità dell'uomo comune, ereditata dal cristianesimo, l'uomo fragile, «inguaribilmente mediocre», si è immaginato di essere il fine e il senso della storia. Secoli di cultura cristiana hanno dato origine a una nuova razza di persone con una coscienza di tipo servile, sottomessa al destino, ipocrita, incapace di iniziativa sociale. La morale dei padroni è fondamentalmente diversa dalla morale degli schiavi: i primi sono i creatori di valori genuini, i secondi sono opportunisti che pervertono questi valori, affermandosi attraverso la negazione di tutto ciò che è sano e attivo. Pertanto, chiarisce Nietzsche, il "buon" nobile non è affatto identico al "buon" plebeo. Romanticizzando la morale eroica, cavalleresco-aristocratica e difendendo il diritto dell'individuo all'indipendenza e all'individualità, Nietzsche rifiuta i principi e le regole obbligatorie sollevate al di sopra dell'uomo, paralizzando l'attività creativa del nobile.
Nella sezione II "A g.m." noi stiamo parlando sul ruolo del male nella storia della morale. Nietzsche mostra che i concetti fondamentali della coscienza morale - "responsabilità", "coscienza", "dovere", "giustizia", "colpa", "bene" e "male" - sono i prodotti di un processo storicamente lungo di umanizzazione di una persona . Secondo J. Habermas, Nietzsche ha dimostrato il fallimento della “filosofia della soggettività”, tentativi di trovare i fondamenti del dovere morale nelle strutture psicobiologiche del soggetto. La sofferenza si compie funzione diversa nella socializzazione di una persona: possono essere uno strumento per la formazione di una persona responsabile, indipendente, anche generosa, e possono anche essere uno strumento per sopprimere l'indipendenza e coltivare il servilismo. Più una persona si umanizzava, più sottili e spiritualizzati diventavano gli strumenti di socializzazione: l'educazione attraverso l'arte, la tragedia è, secondo Nietzsche, essenzialmente lo stesso metodo per influenzare una persona causandole dolore. La sofferenza sancita dal cristianesimo è un'altra questione. La morale cristiana, chiedendo compassione per ogni insignificanza e impotenza solo perché sono deboli, legittima e santifica così lo squallore fisico, la psicologia servile e l'incapacità in una persona.
Nella sezione III, Nietzsche analizza le funzioni dell'ideale morale cristiano e avanza argomenti contro la fede in Dio e la scienza, poiché entrambe sono ugualmente radicate nel suolo dello spirito non libero, l'assolutezza infondata della verità. Nietzsche propone l'ideale di una persona libera che manifesta spontaneamente la sua essenza e non è programmata per alcun obiettivo esterno a lui. Per una persona del genere, l'ideale ascetico è solo una condizione attività creativa piuttosto che un obiettivo in sé. L'ideale ascetico cristiano è una manifestazione del risentimento e della volontà di potenza, che si vorrebbe dominare non su nulla nella vita, ma sulla vita stessa: dando senso alla sofferenza, l'ideale ascetico sostiene la vita degenerante. L'ideologia cristiana nel suo insieme si basa sulla moralizzazione e sulla manipolazione della coscienza. Rifiutando la morale cristiana, Nietzsche propone come linea guida l'ideale del superuomo e preferisce una nuova morale futura. La creatività che c'era prima segno distintivo Dio è ora incarnato nell'attività umana. Valutando il posto di Nietzsche nella filosofia occidentale nel nichilismo europeo, M. Heidegger gli attribuisce il merito di essersi rivolto al pensiero del valore; Grazie a Nietzsche, la problematica dei valori diventa decisiva in filosofia. Secondo molti (K. Jaspers, P. Ricoeur, R. Rorty, J. Deleuze, G. G. Gadamer), Nietzsche, insieme a S. Kierkegaard, K. Marx e Z. Freud, ha determinato il volto della filosofia moderna. Il metodo genealogico di Nietzsche, con la sua attenzione all'oggettivismo spersonalizzato e all'esposizione del discorso, fu adottato da M. Foucault, che per un certo periodo identificò addirittura con esso il suo metodo "archeologico". Le idee di Nietzsche, esposte in K.M., sono state sviluppate nella filosofia della vita, nella psicoanalisi, nella fenomenologia, nell'esistenzialismo e in altre aree della filosofia.
Vedi risentimento, "Il risentimento nella struttura della morale".
Lett.: Nietzsche F. Zur Genealogie der Moral. Lipsia: Hrsg. von CG Naumann, 1887; Nietzsche F. Alla genealogia della moralità (Tradotto da K.A. Svasyan) // Nietzsche F. Works. in 2 volumi T. 2. M.: Pensiero, 1990; Huseynov AL. Filosofia come etica (un'esperienza dell'interpretazione di Nietzsche) // F. Nietzsche e la filosofia in Russia. San Pietroburgo: Istituto umanitario cristiano russo, 1999; Deleuze J. Nietzsche. San Pietroburgo: AKHYUMA, 1997; Kuzmina T.A. È possibile "superare una persona"? // Kuzmina T.A. Il problema del soggetto nella moderna filosofia borghese. Mosca: Nauka, 1979; Motroshilov I.V. "Beyond Good and Evil" come "dramma filosofico" // F. Nietzsche e la filosofia in Russia San Pietroburgo: Russian Christian Humanitarian Institute, 1999; Rorty R. Casualità, ironia e solidarietà M.: Russian Phenomenological Society, 1996 ; Svasyan K. A. Friedrich Nietzsche: un martire della conoscenza // Nietzsche F. Opere in 2 volumi Vol. 1. M.: Pensiero, 1990; Trubetskoy E./!. Filosofia di Nietzsche (saggio critico) // Friedrich Nietzsche e il russo Filosofia religiosa: traduzioni, studi, saggi di filosofi della "Silver Age": in 2 volumi Vol. 1. Minsk, M .: Alcyone, Pristsels, 1996, Heidegger M. "Le parole di Nietzsche" Dio è morto "// Voprosy filos., 1990. No. 7; Jaspers K. Nietzsche and Christianity. M.: Medium, 1994; Deleuie G. Nietzsche et la philosophic. Paris: Presses univ. de Franse, 1962; Fink E. Nietzsches Philosophic. Stuttgart: Kohlhammer , 1960 Kaufmann WA Nietzsche: Filosofo, Psicologo, Anticristo Princeton: Princeton UP, 1950.
T.N. Porokhovskaya
Nichilismo (< лат. nihil — ничто) — в широком смысле — отрицание всего культурного наследия прошлого, а также принятых в обществе норм, идеалов, традиций, ценностей. Как философская позиция Н. имеет много разновидностей и оттенков, но их общая черта — преобладание критического деструктивного пафоса над положительным идейным содержанием. Наиболее точную формулировку Н. дает Ф.Ницше: «Высшие ценности теряют свою ценность». В истории философии впервые этот термин применяет Августин, называя нигилистом неверующего человека, т.е. обращенного душой не к Божеству, а к окружающему миру, к-рый без Бога есть ничто. Понимание Н. как неверия закрепилось не только в богословии, но и в светской мысли. В таком значении этот термин употребляли С.Кьеркегор, И.А.Ильин и др.
È possibile individuare i principali tipi di N. 1) N. metafisico, che consiste nella negazione della realtà mondo esterno, la sua base ontologica. Era caratteristico del buddismo, che considera il mondo illusorio ("Maya"), per Eraclito e i sofisti, che indicavano la costante variabilità della realtà. Nei tempi moderni, i tratti del metafisico N. sono chiaramente espressi nel volontarismo del romanticismo, in A. Schopenhauer, Nietzsche, N. Hartmann, che consideravano la volontà irrazionale la base di tutto ciò che esiste. 2) N. gnoseologico come sinonimo di scetticismo e agnosticismo. Per la prima volta in questo senso, il termine appare in F. G. Jacobi nel 1799. Criticando la filosofia di I. Kant, notò che la conoscenza dei soli fenomeni della coscienza, e non del mondo reale, è la conoscenza del nulla, ad es. N. Nella filosofia del positivismo, così come in J. Dewey e B. Russell, N. è chiamato la negazione dell'affidabilità delle relazioni logiche e della conoscenza scientifica. 3) Social N., che è una comprensione allargata dell'anarchismo - la negazione non solo degli istituti statali, ma anche di qualsiasi forma di organizzazione sociale (comunità, chiese, ecc.). N. sociale particolarmente chiaramente può essere rintracciato nella filosofia di Nietzsche e M. Stirner. 4) Etico N., negando norme e valori morali stabiliti. Il momento di N., come critica degli insegnamenti precedenti e moderni sulla moralità, è contenuto in qualsiasi filosofia morale. Ad esempio, Aristotele critica l'intellettualismo di Socrate, Kant critica l'etica delle inclinazioni. Il radicale N. dovrebbe essere distinto come negazione delle norme e degli ideali stessi dal moderato N. - un tentativo di privare il valore della sua sacra sanzione divina e di ri-giustificarlo o come derivato delle leggi della natura, o come istituzione della mente umana. Questo processo Nietzsche chiama "deprezzamento" e M. Weber - razionalizzazione.
Nella sua forma pura, il radicale N. come perfetto amoralismo non esisteva in etica, altrimenti non varrebbe la pena parlare di etica in generale. Alcune delle sue caratteristiche si trovano nei primi apologeti cristiani (Tertulliano, Taziano, Atenagora), che criticavano aspramente l'antichità per il suo orgoglio, nelle opere dei materialisti volgari, che deridevano ogni impulso spirituale dell'uomo, nel marxismo, in Nietzsche, così come nei moderni insegnamenti atei, ostili o ironicamente legati alla morale cristiana. Ma questo tipo di N. si può chiamare immoralismo: la negazione forma esistente moralità e valori morali generalmente accettati per affermare gli altri - quelli più alti. Al contrario, N. moderato si incontra molto spesso. Inoltre, Nietzsche, che ha fornito l'analisi più accurata di questo fenomeno, ha sostenuto che l'intera storia del pensiero è N .: il deprezzamento di alcuni valori e l'affermazione di altri, destinati a cadere in anticipo. Quindi, sebbene esista una connessione organica tra l'antichità e il Medioevo, le principali virtù antiche (saggezza, coraggio, moderazione, giustizia) sono sostituite da altre: fede, speranza, amore. Non si può dire che il Rinascimento abbia rifiutato completamente la visione del mondo cristiana, ma il risveglio dell'antichità porta a una rivalutazione dei valori. D'ora in poi, non è Dio ad essere al centro dell'attenzione di artisti, poeti e filosofi, ma l'uomo nell'Universo; L'ascetismo cristiano viene gradualmente sostituito dalle speranze di felicità terrena. Il nuovo tempo ha sviluppato il greco. razionalità al limite: non ci sono più profondità inaccessibili alla mente; l'uomo non vuole più affidarsi alla volontà di Dio, vuole sistemarsi a sua discrezione. L'umiltà cristiana è respinta, la fiducia in se stessi è esaltata, la fede sta cambiando: ora credono non in un Dio sofferente, ma in un Dio-scienziato che ha creato il mondo e non interferisce più nella storia. Anche l'ideale morale cambia gradualmente: dall'antico saggio al santo cristiano, poi allo studioso-enciclopedista rinascimentale e, infine, al cittadino della New Age. L'ideale diventa mondano, diventa pubblicamente disponibile; la sua componente nichilista, espressa nella negazione dei valori precedenti, supera il contenuto positivo. Tuttavia, il culto della ragione, che trova il suo culmine nel panlogismo di G.W.F. Il pessimismo diventa il terreno per N .: poiché la vita non ha senso, allora non bisogna cercare ideali in essa, poiché il mondo sta cambiando, allora non c'è nulla di irremovibile in essa. Nietzsche, che ha scritto un saggio sul N. europeo, lo intende come "la credenza nell'assoluta incoerenza del mondo rispetto al più alto dei valori riconosciuti". Inoltre, N. è diventato possibile solo grazie al predominio dei valori cristiani. L'ideale morale troppo alto del cristianesimo, che ha sviluppato un senso di veridicità nelle persone, è irraggiungibile. C'è delusione e comprensione che la vita è più ricca dei valori tradizionali. Tutti gli ideali superiori sono svalutati e la caduta della moralità è di importanza decisiva. Nietzsche distingue tra attivo N. - "violenza finalizzata alla distruzione" e passivo - dubbio, incredulità, stanchezza. Tuttavia, avendo abbandonato Dio, una persona non abbandona la visione cristiana del mondo e continua a cercare in essa il sommo bene, la verità, la giustizia, sostanziandole con i dettami della coscienza, della ragione, del contratto sociale, ecc. Ma questi valori sono anche nichilisti: affermano ciò che in realtà non c'è, perché il mondo non è un tutto ordinato, ma un flusso in continua evoluzione, un insieme di attori che combattono eternamente tra loro, combattendo tra loro volontà di potere. Nietzsche ritiene che N. sia uno "stato intermedio patologico". Sarà sconfitto quando si realizzerà che il mondo non è essere, ma puro divenire. Quindi la visione del mondo cristiana sarà sostituita da un'altra: vitale, creativa, le cui caratteristiche nelle opere di Nietzsche non sono del tutto chiare.
L'analisi di Nietzsche su N. ha provocato valutazioni diverse di questo fenomeno tra i suoi commentatori. Per O. Spengler, H. Ortega y Gasset, M. Heidegger, N. è un processo distruttivo che rifiuta le cose sacre e conduce l'umanità all'indebolimento dello spirito, alla sconsideratezza, alla degenerazione della cultura. Al contrario, per gli esistenzialisti (A. Camus, J.P. Sartre) N. è un fenomeno positivo, perché, schiacciando ogni "presupposto metafisico", dona a una persona la vera libertà. I motivi nichilisti sono forti nella filosofia moderna del postmodernismo (J. Derrida, J. Bataille, J. Deleuze e altri), chiedendo una "decostruzione" dei concetti metafisici di base per liberare la mente dai loro dettami e passare a un libera interpretazione dei fenomeni.
In Russia, il termine "N." è stato utilizzato per caratterizzare le varie direzioni del movimento rivoluzionario-democratico del secondo. pavimento. 19esimo secolo, che ha negato i fondamenti fondamentali del russo. vita e ateismo professato e materialismo. A loro è stato attribuito il seguente motto: "Non prendere nulla sul serio, ma giura solo". Questa parola si diffuse dopo la pubblicazione nel 1862 di I.S. Turgenev del romanzo "Fathers and Sons", dove viene data un'immagine collettiva del nichilista Bazàrov. Ma per la prima volta questo termine è stato introdotto nell'uso letterario dal critico N. I. Nadezhdin. Nell'articolo "Crowd of Nihilists" (j. "Teleskop", 1835) ha chiamato così ... A.S. Pushkin per motivi romantici in "Poltava" e "Count Nulin".
I principali portavoce delle opinioni della gioventù rivoluzionaria erano N.G. Chernyshevsky, N.A. Dobrolyubov, D.I. Pisarev, M.A. Antonovich e altri forze metafisiche, meccanismo professante. Hanno spiegato l'origine delle virtù morali dai "bisogni naturali" dell'uomo, dati dalla natura, hanno visto l'essenza degli ideali morali nei sogni delle persone di una società giusta. I nichilisti rifiutavano il libero arbitrio dell'uomo, considerando le sue azioni determinate in due modi: sia dalla natura che dall'ambiente sociale. Correggendo i vizi umani e sociali, hanno pensato di cambiare le condizioni di vita attraverso una rivoluzione, un cambiamento violento nel sistema esistente. Il loro ideale era la costruzione di una società socialista, ma le sue caratteristiche sono indicate da loro in modo troppo vago: criticavano tutti gli insegnamenti socialisti esistenti. I nichilisti consideravano lo scopo dell'uomo il servizio disinteressato ai suoi vicini, per liberarli dal "servilismo mentale". Nel campo delle riflessioni morali, hanno aderito a uno dei tipi di utilitarismo: la teoria dell'egoismo razionale, secondo la quale l'interesse privato dell'individuo deve essere subordinato agli interessi della società e la felicità di uno è possibile soggetta a il raggiungimento della felicità universale. Il loro eroe è un "uomo nuovo" ("persona brillante"), con una conoscenza specifica delle scienze naturali, aiuta le persone, non evita il lavoro più duro. Allo stesso tempo, il suo obiettivo principale è condurre un'opera educativa, distruggere i dogmi consolidati e provocare una rivoluzione.
Le opinioni di Chernyshevsky, Pisarev e altri democratici rivoluzionari erano molto più profonde del N. mondano della gioventù radicale. Non c'è da stupirsi che Antonovich considerasse l'immagine di Turgenev di Bazàrov offensiva per il movimento democratico. Rappresentanti del russo La filosofia religiosa criticava i nichilisti per l'ateismo e la negazione dei santuari popolari, per la semplificazione del massimalismo individuale e rivoluzionario. N.N. Strakhov e F.M. Dostoevskij hanno sottolineato la loro separazione dal loro suolo natale, l'infezione delle loro menti con idee filosofiche occidentali di second'ordine e hanno sostenuto che, rifiutando la loro cultura, sono destinati all'incomprensione. Allo stesso tempo, come hanno notato gli autori di "Milestones", la visione del mondo dei nichilisti si basa su un puro desiderio religioso per il bene supremo e la giustizia.
Le caratteristiche nichiliste si trovano nel lavoro del russo. filosofi religiosi - K.N. Leontiev (nella critica delle moderne tendenze liberali e forme di cultura secolare), N.A. Berdyaev (nelle sue acute osservazioni sull '"Ortodossia ufficiale"), L. Shestov (nel rifiuto della filosofia razionalista).
Lett .: Davydov Yu.N. Estetica del nichilismo. M.: Arte, 1975; Nietzsche F. Volontà di potenza. Mosca: Zhanna, 1994; Heidegger M. Nichilismo europeo//Heidegger M. Tempo ed Essere. M.: Repubblica, 1993.
AA Skvortsov
Nel giornalismo conservatore della Russia dagli anni '60. 19esimo secolo il contenuto del concetto di N. si riduce a una radicale negazione dei valori culturali. L'intero sistema di vita pubblica e statale, credenze religiose e gerarchia ecclesiastica, valori morali del "vecchio mondo" e dei suoi tradizioni familiari e costumi, scienza del vecchio modello - tutti questi in te sono stati respinti come autorità senz'anima che impediscono il "libero sviluppo dell'individuo". Alla base della pseudo-visione del mondo dei nichilisti c'è la credenza nell'unica realtà dell'animale nell'uomo, una sorta di materialismo fisiologico; ogni uomo, come organismo naturale, soddisfa più o meno completamente i suoi bisogni; e solo in base a questo può essere "gentile" e "onesto", mentre non può esserlo affatto, contrariamente ai propri interessi e bisogni. Pertanto, la disputa sulla natura buona o cattiva dell'uomo al di là di questi limiti della meccanica fisiologica non ha senso; una persona non è né buona né cattiva, è egoista; il dovere, indipendentemente dall'inclinazione, è quindi una finzione idealistica per il nichilista. Si oppone alla moralità del pragmatismo e dell'utilitarismo nel sociale, edonismo - in senso personale: "il bene è una sensazione piacevole", il bene è "beneficio, il male è una perdita" (Pisarev); l'adempimento dei requisiti del dovere "invano disonora la sua esistenza" (Dobrolyubov). Nell'ambito di questo edonismo, al miglioramento degli esseri viene riconosciuto solo un significato tecnico o fisiologico.
La moralità del rispetto era percepita come un pregiudizio borghese e, in particolare, il rispetto per la proprietà e la vita di qualcun altro ora poteva basarsi solo sul calcolo di un egoista autoconservatore, sulla paura delle sanzioni statali; ma da qui c'è stato un passo verso l'effettiva negazione del crimine: “Nient'altro che il gusto personale impedisce alle persone intelligenti di uccidere e derubare” (Pisarev); se le azioni di una persona sono determinate dalla necessaria pressione dell'ambiente sociale o del proprio organismo, allora la colpa, la responsabilità, la criminalità della volontà sono altrettanto esattamente soggette a negazione "onesta". L'assenza di una colpa moralmente intesa rende assurdo il processo al criminale. La punizione criminale potrebbe ora essere intesa esclusivamente come l'autodifesa istintiva della macchina statale da persone ad essa svantaggiate. Negando la libertà spirituale dell'individuo, l'esistenza stessa di doveri civici. L'ideale dello stesso nichilista è l'autosviluppo dell'umanità senza limiti, l'autodeterminazione dell'individuo, l'autonomia del cittadino, non soppressa servendo l '"ideale", l'"ideologia"; una comunità di egoisti e, di conseguenza, lo Stato come egoista razionale, autorganizzazione del pubblico dal basso (quindi, il N. culturale risulta naturalmente essere un alleato, soprattutto, dell'anarchismo sociale). Il N. culturale radicale è anche democrazia sociale e politica radicale, si oppone a qualsiasi autorità autoritaria; stato tradizionale gli sembra che il "progresso ragionevole" sia frenato già dal semplice fatto che è tradizionale. Pertanto, la democrazia è diventata permanentemente rivoluzionaria; la rottura e la rivoluzione sono state presentate come un modo di esistere di una società che ha costantemente resistito alla sua formazione in uno stato. Qualunque nuovo ordine l'autorganizzazione può essere rivista, e solo per questo deve essere rivista di fatto; tale è la costante convinzione di N., che non riconosce il valore oggettivo di alcuna forma di pubblico in-compagnia. Con una versione meno coerente di N., dall'ingiustizia in-quella proprietà privata, si è giunti alla conclusione circa l'equità della proprietà comune, e quindi a tutte le strutture pubbliche è stato affidato il compito di curare l'organizzazione della comproprietà e di educare la solidarietà dei cittadini; oppure un egoista ragionevole era riconosciuto come l'ideale dell'uomo, e quindi il compito del pubblico era prendersi cura di un tale egoista ed educare il suo sostituto. Questo "nichilismo di una riserva" negava naturalmente in sé il lievito culturale nichilista, preferendo essere chiamato qualcos'altro.
L'istituto della famiglia è stato respinto come un "regno oscuro" che opprime e sfigura le donne con le sue leggi, in modo che non osano più essere edoniste egoiste e "tranne la felicità coniugale, non producono nulla" (Pisarev). Era anche naturale: l'edonismo coerente è incompatibile con il riconoscimento di qualsiasi tipo di unione morale stabile; l'introduzione di riserve nella dottrina ha portato all'approvazione della "nuova" famiglia come istituto puramente giuridico di proprietà privata ed ereditaria (nella versione liberale) o come unione morale libera da norme legali nel senso di "nuova moralità" (nella versione comunitaria), e comunque - alla decomposizione della "vecchia" morale familiare. La religiosità, precedentemente parodiata in un linguaggio accessibile al pragmatico, è stata ridicolizzata e respinta: "non aspettarti dall'alto né una ricompensa per il bene né una punizione per il male". Il paradosso di N. consisteva nel fatto che la completa negazione degli aspetti sociali e dei valori del "vecchio" modello, l'intero sistema sociale come "anormale", la cultura morale e i doveri come autoironia ascetica del l'individuo era diretto da un'affermazione semicosciente di una persona normale, "nuova", libera, e con lui - il nuovo pubblico. Il "nuovo", secondo la logica di N., distruttore e ribelle, divenne predicatore della "verità" pubblica (che lo sciame non avrebbe dovuto conoscere secondo l'impostazione iniziale), guaritore e correttore della pubblico dalle "ulcere" del "vecchio mondo". La negazione della "vecchia" scienza (principalmente l'idealismo umanitario di questa scienza) è stata guidata dall'affermazione della "nuova", prevalentemente scienza tecnico-naturale. N., inizialmente incapace di avere alcuna dottrina positiva del valore, sviluppò una propria gerarchia di valori morali e culturali, modesta in apparenza, ma convincente nelle sue conseguenze sociali. Il nichilista divenne un moralista.
Lett .: De-Poulet M.F. Il nichilismo come fenomeno patologico della vita russa // Rossiyskiy Vestnik. 1881. N. 11; Sokolov N.M. Dogmi del nichilismo russo // Ibid. 1905. N. 1; Zion MF Nichilisti e nichilismo // Ibid. 1886. N. 6; Schebalsky P.K. Nichilismo nella storia // Ibid. 1869. N. 4; Shcherban N. Depravazione politica. "Narodnaya Volya" e "Volontari del popolo" (Esperienza di analisi) // Ibid. 1887. N. 8.
AK Sudakov
« Dall'altra parte del bene e del male" ("Jenseits von Gut und Bose") è un'opera di F. Nietzsche, completata e pubblicata nel 1886. È scritto nel classico stile di aforisma di Nietzsche, ad es. è diviso in brevi frammenti, completi nel significato, interconnessi da un tema comune e solo un autore può comprenderne la logica. Ci sono 296 di questi aforismi nel libro, più la prefazione e la canzone di chiusura; sono distribuiti in nove sezioni, le più importanti delle quali per l'etica sono la quinta (“Sulla storia naturale dei costumi”), la settima (“Le nostre virtù”) e la nona (“Che cos'è l'aristocratico?”). Per la prima volta in russo lang. Il libro apparve nel 1905 in trad. N. Polilova e poi più volte ristampato.
Dopo il primo, romantico, periodo di creatività (1867-1876), il problema morale nella filosofia di Nietzsche diventa il principale. Sebbene in “Secondo i.e. ..." ci sono riflessioni su una varietà di argomenti filosofici, il problema principale del libro è la questione dell'origine della moderna moralità europea. Contiene tutti i concetti chiave e la quasi completa filosofia morale dell'autore.
Il motivo predominante dell'opera è l'ansia di Nietzsche per "la degenerazione e la riduzione dell'uomo a un perfetto animale da gregge", in cui è diventato l'europeo contemporaneo. La colpa di ciò è della morale prevalente, che ha radici cristiane. L'autore vuole “per la prima volta” considerare la morale non come qualcosa di totalmente positivo, ma sottoporla a esame critico da una prospettiva diversa, non morale, trovandosi così “al di là” del bene e del male. L'autore stesso chiama questa posizione "immoralismo". Nietzsche intende la moralità come "un sistema di valori radicato nelle condizioni di vita di un essere". Si ribella al predominio delle norme cristiane, osservando che “l'esigenza di una morale per tutti è proprio dannosa persone superiori". Nel frattempo, la morale cristiana, nonostante l'affermazione dei suoi apologeti, non è l'unica. Nietzsche individua due moralità: padroni e schiavi. Sono inerenti a qualsiasi cultura ed epoca e coesistono persino nell'anima di una persona in particolare, dove "creatura e creatore sono uniti". Entrambe le morali hanno avuto origine nelle comunità primitive. Quella del Signore divenne un'espressione di volontà persone forti comandare e creare valori; le sue caratteristiche principali sono una brillante individualità, egoismo, coraggio, orgoglio. Schiavo - una manifestazione dell'istinto di sottomissione della maggioranza passiva al potere dei tiranni; le sue caratteristiche: invidia impotente dei maestri, voglia di pareggiare tutti i membri della squadra, voglia di una vita tranquilla. Un aumento del numero di schiavi porta ad un aumento del loro potere e ad una "rivolta nella moralità". Volendo "vendicare" i maestri, condannavano la moralità aristocratica e glorificavano le seguenti virtù: "spirito pubblico, benevolenza, riverenza, diligenza, moderazione, modestia, compassione". La prima "rivolta degli schiavi nella moralità" corrisponde storicamente all'affermazione del cristianesimo, l'ultima - p. rivoluzione. D'ora in poi, secondo Nietzsche, tutti i tratti caratteriali individualistici sono maledetti, l '"istinto del gregge" è glorificato. Ciò ha portato al graduale estinzione delle virtù aristocratiche, all'umiliazione di una persona, alla sua prigionia nel "gregge". Nietzsche rifiuta le virtù cristiane fondamentali, considerandole "tirannia nei confronti della natura", la cui forza motrice principale è la volontà di potenza: il desiderio di ogni figura naturale di affermarsi ed espandere la propria sfera di influenza. La compassione è dannosa perché vuole distruggere la sofferenza, mentre il superamento della sofferenza indurisce la volontà dell'individuo. L'amore per il prossimo fa distrarre una persona da altre persone, mentre l'egoismo - "proprietà di un'anima nobile" - contribuisce alla concentrazione delle forze interne. Rifiutando la morale cristiana, Nietzsche sostiene che sono possibili "altre ... moralità superiori", risalenti all'antica maestria, caratteristica della Grecia omerica. Per fare questo è necessario fare una "rivalutazione dei valori", a cui osano solo "persone del destino", una delle quali era Napoleone. Tuttavia, Nietzsche indica in modo molto vago i tratti della "morale superiore"; "il meglio che abbiamo rimane sconosciuto." Nella sua forma più completa, la filosofia della morale di Nietzsche è esposta nell'opera "Sulla genealogia della morale".
Lett.: Nietzsche F. Al di là del bene e del male. Operazione. in 2 volumi T. 2. M.: Pensiero, 1990; Deleuze, Nietzsche. San Pietroburgo: AKHYUMA, 1997; Fullier A. Nietzsche e l'immoralismo. San Pietroburgo: pubblica utilità, 1905; Shestov L. Buono negli insegnamenti di gr. Tolstoj e F. Nitshe // Shestov L. Izbr. operazione. Mosca: Pravda, 1993; Jaspers K. Nietzsche e il cristianesimo. M.: Medio, 1994.
AA Skvortsov
Risentimento(Risentimento francese - rancore, malizia) - il concetto della filosofia di F. Nietzsche, che denota la base psicologica, nascondeva profondamente (anche allo stesso individuo moralizzatore) il motivo della moralità. Nietzsche vedeva nella morale la degenerazione spirituale dell'uomo europeo, la sua malattia, e considerava R. come la causa, una specie di virus di questa malattia. R. è un fenomeno scoperto per la prima volta da Nietzsche, per designare to-rogo lui, non trovando in esso un'unità lessicale adeguata. lang., usato fr. in una parola, dandogli un significato terminologico stretto.
R. occupa un posto centrale nella genealogia della moralità di Nietzsche. Quest'ultimo funge da socio- e psicoanalisi della moralità. La socioanalisi della moralità ha portato principalmente alle categorie di "moralità degli schiavi" e "moralità dei padroni", e la psicoanalisi della moralità - nella categoria di "R.". La struttura di R. è costituita dalla storia attuale dell'autoavvelenamento dell'anima, che ha portato al tartufismo morale, moralità come tartufismo. Nietzsche ricostruisce questo processo, distinguendo in esso le seguenti quattro fasi: a) le emozioni iniziali sono rabbia, vergogna, causate dall'umiliazione della dignità di una persona, inoltre, non da umiliazioni accidentali o erronee, ma da quelle regolari, derivanti dalla sua reale , riproducendo costantemente la disposizione nei confronti dell'autore del reato; si tratta dell'umiliazione della dignità di chi è effettivamente umiliato, e quindi in relazione a lui sembra più un'affermazione fattuale che una valutazione immeritata; b) ricordo e rivivere queste emozioni, la loro trasformazione in desiderio di vendetta, odio malizioso, intensificato dalla gelosia per l'autore del reato, invidia per la sua forza; c) un sentimento di disperazione associato alla consapevolezza che la vendetta non può essere compiuta, l'odio non può trovare uno sbocco adeguato e colpire l'autore del reato - dopotutto, l'insulto inflitto da quest'ultimo non è il suo capriccio, volontà malvagia, è un semplice riflesso , solo rinforzato; una persona comincia a capire vagamente di essere destinata a essere offesa, "degna" di umiliazione; d) rabbia, invidia, disperazione, vendetta, non potersi realizzare nelle azioni, ottenere un'incarnazione ideale, tutto si capovolge, e l'impotenza diventa forza, la sconfitta diventa vittoria, "il risentimento stesso diventa creativo e genera valori" (Alla genealogia della morale, 1.10). Incapace di stabilirsi nella vita, nelle azioni, l'anima offesa si ricompensa con una vendetta immaginaria; inverte la scala reale dei valori e dichiara il forte moralmente debole, che certamente aspetterà la sua punizione, se non in questo, poi nell'aldilà, e il debole - forte, portatore di bene, che sarà ricompensato . È così che si costruisce l'opposizione del bene e del male, che permette di dare un falso sfogo a un sentimento vendicativo, di rivolgere la rabbia verso l'interno, di dare l'apparenza di efficacia a una malizia impotente. Così, R. è vendetta senza vendetta, rimpiazzata dall'odio, trasformata in invidia, autoavvelenamento psicologico. Questa è l'umiliazione umana, la debolezza, che finge di essere dignità e forza.
R. esiste in due forme storiche principali: la moralità del gregge e l'ideale ascetico. La moralità del gregge è estroversa, porta la colpa all'esterno, l'ideale ascetico è introverso, trasferisce la colpa all'interno. La morale del gregge è una morale servile, una specie di autointossicazione con la propria debolezza; l'ideale ascetico contiene una parvenza di potere, perché è meglio "non volere niente che non volere niente" (On the Genealogy of Morals, 111.28), ma tuttavia è una forma degenerata di attività, è una specie di percorso, che una persona invertita, il desiderio di sembrare "troppo bello" per questo mondo.
Il terreno più fertile per R. Nietzsche considerava l'ordine democratico della concorrenza e dell'uguaglianza universali. R. nasce dalla dissonanza tra le pretese interne dell'individuo e la sua reale posizione nella società, dalla discrepanza tra l'alta autostima e la valutazione inevitabilmente bassa degli altri. Con il passaggio dalla regolazione dello status del Medioevo all'uguaglianza universale del New Age, che, ovviamente, non poteva annullare la reale differenza di capacità, oltre che di status sociale degli individui, questa asimmetria tra interno ed esterno che alimenta R. aumenta molte volte. R. in queste condizioni diventa universale e più militante, si trasforma in un trionfo della mediocrità.
Cfr. Genealogie della morale, Al di là del bene e del male, Il risentimento nella struttura della morale.
Lett .: Nietzsche F. Alla genealogia della moralità // Nietzsche F. Works. in 2 volumi T. 2. M.: Pensiero, 1990; Egli è. Esce Homo ("perché sono così saggio") // Ibid; Sheler M. Risentimento nella struttura della morale: San Pietroburgo: Nauka; Libro universitario, 1999; Scheler M. Vom Ressentiment im Aufbau der Moralen. Abhandlungen e Aufsatze. bd. 1. Lipsia, 1915.
AA Huseynov
« Il risentimento nella struttura della moralità"("Das Ressentiment im Aufbau der Moralen") - un'opera del periodo fenomenologico dell'opera di M. Scheler, pubblicata nel 1912 e alla pari con le opere "Shame and Shame", "Ordo Amoris" ("The Order of Love"), "Idols Self-Knowledge", "Bourgeois", ecc., Adiacente in termini di problemi alle sue opere fondamentali: "Formalismo nell'etica ed etica materiale dei valori" e "L'essenza e le forme della simpatia". "R. cm" si compone di un'Osservazione preliminare e di cinque capitoli: I. Fenomenologia e sociologia del risentimento; P. "Il risentimento e il giudizio morale di valore"; III. "Moralità cristiana e risentimento"; IV. "Risentimento e filantropia moderna"; V. "Risentimento e altri cambiamenti di valore".
"R. cm" è interdisciplinare; lo studio si svolge all'intersezione di etica, metafisica, psicologia, economia politica, storia, politica utilizzando gli strumenti concettuali della fenomenologia, psicoanalisi di Z. Freud, analitico-comprensione e psicopatologia descrittiva di K. Jaspers, adattati e 1a W. Sombart di critica dell'economia politica di K. Marx, teologia cristiana (cattolica). Lo stimolo principale per la scrittura di quest'opera è stato il desiderio di Scheler di illuminare a modo suo le origini e i meccanismi della formazione della morale borghese o morale borghese (Bourgeois), pur partendo dalla brillante ricerca filosofica, storica e socioculturale di M. Weber, W. Dilthey, Sombart, E. Troelch. L'energia etica del trattato, la sua non annunciata provvidenzialità furono determinate dalla determinazione di Scheler a proteggere la morale cristiana, in particolare cattolica, dalle denunce spietate e dalle critiche distruttive di F. Nietzsche, che diede alla parola "Risentimento" uno status categorico e la dispiegò concettualmente nella dottrina della "grande importanza" del processo di risentimento per la "rivalutazione dei valori" avvenuta in epoca moderna. descrizioni esemplari e un'analisi perspicace del risentimento e della psicologia del risentimento che Scheler ha trovato in Rus. letteratura, scrittori come N.V. Gogol, F.M. Dostoevskij, L.N. Tolstoy e persino P.A. Kropotkin.
Il concetto di "ressentimento" si è formato nella tradizione artistica e filosofica europea da un tempo relativamente lungo, almeno a partire da M. Montaigne (Esperimenti, II, XXVII). Ma fu solo grazie a Nietzsche che questo concetto ricevette il suo suono moderno, e il tema e il problema del risentimento si spostarono in una serie di temi fondamentali dell'etica e della filosofia morale. Secondo Scheler, la scoperta del risentimento da parte di Nietzsche è la più profonda delle nuove scoperte europee sull'origine dei giudizi morali. Le sezioni 8, 10 e 14 della prima rassegna sono dedicate a una descrizione sistematica del fenomeno del risentimento nella Genealogia della morale di Nietzsche, dove i principali motivi ideologici sono introdotti in consonanza sinfonica, analizzati a fondo da Scheler. Scheler non ha intenzione di dare una definizione formalmente logicamente impeccabile del termine, offre una concisa caratterizzazione essenziale del fenomeno. Il risentimento, secondo Scheler, è autoavvelenamento mentale, che ha cause e conseguenze ben definite; è un atteggiamento mentale stabile che risulta da un ritardo sistematico nella scarica di certi movimenti mentali e affetti, che sono di per sé normali e parte integrante della natura umana. Si traduce in un atteggiamento stabile nei confronti di certi tipi di manipolazione del valore (Werttäuschungen) e dei corrispondenti giudizi di valore. Questi includono principalmente movimenti mentali e affetti come la sete di vendetta, l'odio, la malizia, l'invidia, l'ostilità basata sull'invidia e l'inganno.
Secondo Scheler, il punto di partenza più importante nella genesi del risentimento è la vendetta, il motivo e l'impulso della vendetta come una sorta di risposta alle azioni aggressive o offensive di qualcuno (reale o immaginario). La vendetta, invece, implica la procrastinazione con una risposta diretta all'aggressione o all'insulto, rimandando la reazione a un momento più "conveniente" e indovinando una situazione più "adatta". La reazione immediata all'aggressione è ritardata anche dal fatto che colui dal quale ci si aspetta la reazione è consapevole che, avendo reagito immediatamente, potrebbe perdere contro l'autore del reato; ecco il motivo dei sentimenti di "incapacità", "impotenza": la vendetta è amata dall'impotenza, è la sorte e gli affari dei "deboli". Se la vendetta (invidia, malizia) si realizza, allora non si trasforma in risentimento; al contrario, non appena tale realizzazione non si verifica, la vendetta diretta si trasforma in vendetta sparsa, che predispone al risentimento. Quando la vendetta si è trasformata in vendetta, quest'ultima cerca qualsiasi motivo per la sua manifestazione. Tuttavia, è frenata dalla paura e dalla consapevolezza della "debolezza" del vendicatore: la vendetta si raffredda, ad es. viene espulso dalla coscienza, quindi viene espulsa la soddisfazione illusoria del sentimento di vendetta nelle fantasie, quindi la stessa eccitazione emotiva causata dalla sete di vendetta. Ciò crea condizioni adeguate per la formazione del risentimento. Ciò è facilitato dalla tendenza verso un sempre maggiore raffreddamento e spostamento dell'iniziale impulso di vendetta, l'instaurazione di una certa parità paradossale, l'uguaglianza tra l'autore del reato e l'offeso (vale a dire, il progressivo politico e differenziazione sociale la società lo informa della più potente accusa di risentimento), la percezione da parte dell'offeso del suo insulto come "il dito del destino". Quanto più “fatidica” sembra l'oppressione sociale oppressa, tanto meno si scatenano le forze che possono praticamente cambiare questo stato: la critica totale di tutto ciò che esiste senza alcun obiettivo positivo governa lo spettacolo. Qualsiasi reale miglioramento della situazione nella società interferisce solo con la critica del risentimento: il suo motto è "il peggio, il meglio" o "una piaga su entrambe le tue case".
Un altro punto di partenza nella formazione del risentimento è la triade affettiva: invidia, gelosia, ossessione per la rivalità. L'invidia nasce dal sentimento di impotenza dell'individuo, che paralizza il suo desiderio di ottenere la cosa che desidera, a causa del fatto che un altro la possiede. La contraddizione tra questa impotenza e il desiderio di ottenere la cosa si scarica in atti di odio o in una posizione di odio verso il proprietario della cosa desiderata, che si trasforma nella ragione per cui l'individuo non ha questa cosa. Inoltre, nell'esperienza dell'odio, il fatto di possedere una cosa da parte di un altro appare come un “ritiro” di questa cosa da parte di un individuo lussurioso e invidioso. L'invidia diventa piena invidia e il piede del risentimento quando la cosa desiderata è assolutamente irraggiungibile. L'invidia, che porta alla formazione del risentimento più forte, è diretta all'essenza individuale e all'essere di un'altra persona, questa è "invidia esistenziale". Le strade per il risentimento sono anche tracciate dal confronto individuale del proprio valore con il valore di un altro: il tipo attivo di tale comparatore è un carrierista, un cavaliere della competizione. Una persona passiva e risentimentale si sbarazza del sentimento della propria inferiorità, scarica la tensione interna sminuendo colui con cui si confronta, svaluta illusoriamente le sue preziose qualità o mostra loro una specifica "cecità".
La mossa più importante e di successo di una persona risentimentale è che si sbarazza di un complesso di inferiorità destreggiandosi tra i valori stessi, alla presenza e al significato dei quali gli oggetti di confronto possono generalmente avere un carattere prezioso. Scheler conduce un aspro dibattito con concetti (compresi quelli di B. Spinoza), che derivano valori e antivalori da "desiderio", "lussuria" e viceversa. Questi sono concetti risentimentali. Allo stesso tempo, Scheler sottolinea che la scala dei valori genuini non scompare del tutto dalla coscienza di una persona di risentimento: sembrano essere "sovrapposti" a valori di risentimento, "trasparire" attraverso di essi. Inoltre, l'autore considera le persone e le situazioni, in base alle quali condizioni favorevoli per la formazione del risentimento: questa è una donna che dipende completamente da un uomo, incl. una prostituta; sono "padri" e "figli" reciprocamente dipendenti; sono membri di famiglie simbiotiche; questi stanno idolatrando il Medioevo in rimprovero alla modernità del romanticismo; questi sono politici caduti in disgrazia e funzionari in pensione. A differenza di loro, il criminale, di regola, non è una persona risentita. Ma un rinnegato, un rinnegato, al contrario, di regola, è tale.
Passando al problema del rapporto tra risentimento e giudizi morali di valore, Scheler difende come lemma la tesi che “nel mondo non c'è una sola morale, ma diverse morali”; questa tesi include la proposizione che le regole per preferire alcuni valori ad altri sono diverse. Come teorema, Scheler afferma quanto segue: la morale è un sistema di regole per la preferenza dei valori, che deve essere "scoperta" dietro le valutazioni specifiche dell'epoca e del popolo come sua "costituzione morale", in una certa evoluzione. La morale è legata all'etica eternamente significativa nello stesso modo in cui i sistemi cosmologici, ad esempio, tolemaico e copernicano, sono legati al sistema ideale che l'astronomia cerca di ricreare. La funzione più importante del risentimento è che determina tutta la moralità, che le regole di preferenza sottostanti sono pervertite, che ciò che prima era "cattivo" sembra "buono". Sebbene Scheler condividesse la convinzione di Nietzsche che il risentimento avesse un effetto sorprendente sulla moralità dei popoli d'Europa, l'etica cristiana, secondo lui, non era fondamentalmente radicata nel risentimento. Altra cosa è la morale borghese, che ha senza dubbio le sue radici nel risentimento.
In accordo con questi obiettivi, Scheler analizza il rapporto tra morale cristiana e risentimento. Egli, in sostanza, demarca con la posizione di Nietzsche, che dichiarava l'idea dell'amore cristiano come la primula del risentimento. Presso gli antichi, i Greci e i Romani, l'amore era inteso come il desiderio dell'“inferiore” per il “superiore”, dell'“imperfetto” per il “perfetto”, ecc. Tutte le relazioni amorose tra le persone si scindevano in "amare" e "amato", e l'amato era sempre più nobile e perfetto, era un modello per l'essere, la volontà e l'attività dell'amante. Il concetto cristiano di amore è direttamente opposto a quello antico: in esso il nobile si precipita verso l'ignobile, il ricco verso il povero, il buono verso il cattivo, e si muove senza l'antica paura di perdere, perdere se stesso, la sua nobiltà. Cambiando l'idea di Dio e dei suoi relazioni fondamentali con il mondo e con l'uomo è stato il risultato di un cambiamento nel vettore dell'amore: il posto dell'eterno “motore primo” del mondo è stato preso dal “creatore”, che lo ha creato, il mondo, “per amore”. Ma il risentimento non è stato la forza trainante dietro il cambiamento del vettore dell'amore; l'altruismo secolare è una forma di odio radicata nel risentimento, nell'invidia della ricchezza, della forza, della vitalità, della felicità, della pienezza dell'esistenza. Da una posizione simile, Scheler critica la filantropia moderna, la filantropia, l'etica del cosiddetto. compassione.
In conclusione, Scheler esamina costantemente la falsificazione risentimentale dei valori in altre aree della morale borghese. In particolare, sottolinea che i regolatori individualistico-egoistici del lavoro e della proprietà privata minano l'idea cristiana di solidarietà morale. È sostituito dall'idea di uguaglianza, in cui Scheler vede uno degli effetti del risentimento. Una delle manifestazioni del risentimento è l'elevazione dell'utilità al di sopra del valore della vita.
Il libro è stato ristampato più volte. lingua separatamente e come parte delle opere complete di Scheler, è stato tradotto in altre lingue europee.
Lett .: Scheler M. Risentimento nella struttura della morale. San Pietroburgo: Nauka; Libro universitario, 1999; Frings MS Persona e Dasein. Haag: Nijhoff, 1969; Jaspers K. Nietzsche. Berlino; Lipsia: de Gruyter, 1936; Klages L. Die psychologischen Errungenschaften Nietzsches. Bonn: Bouvier, 1958; Levy H.M. Scheler, seine Lehre vom Ressentiment // Der Morgen. 1929. N. 4; Montcheuil Y. de. Le "ressentiment" dans la vie morale et religeuse, d "apres Max Scheler// Montcheuil Y. De. Melange theologique. Paris: Aubier, 1951; Scheler M. Das Ressentiment im Aufbau der Moralen. Frankfurt am Main: Klostermann, 1978; Scheler M. Ethik // Jahrbucher der Philosophie 1914. Jg II; Scheler M. Schriften aus dem Nachlass Bd. 1. Zur Ethik und Erkenntnistlehre Bern: Franke, 1957; Sombart W. Der Burgeois Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen. Munchen; Leipzig: Dunker, 1923.
Popolare
- Celebrazione della giornata dell'agricoltura e dell'industria di trasformazione
- Quando si celebra la Giornata dell'agricoltura?
- Giochi di carte al tavolo
- Concorsi divertenti e divertenti per una divertente compagnia di adulti
- "Paracadutisti" polacchi per i marines sovietici
- Progetto 205 navi missilistiche
- Com'è la vita sul nuovo cacciatorpediniere cinese
- La nuovissima fregata "Ammiraglio della flotta Kasatonov" si sta preparando per i primi test e sta andando in mare Nave ammiraglio Kasatonov
- Sottomarini del tipo Gato
- Insegne sulla flotta mercantile del distaccamento dell'URSS del II gruppo