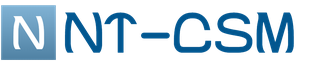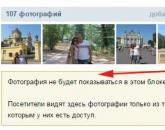Presentazione della lezione sulla sfera celeste di astronomia. Presentazione sul tema "sistemi di coordinate celesti"
Lezione 3 Coordinate celesti
Equatore celeste e meridiano celeste
Sistema di coordinate equatoriali
Coordinate orizzontali ed equatoriali
Il culmine dei luminari

A causa della rotazione assiale della Terra, le stelle ci sembrano muoversi attraverso il cielo.
archi concentrici nella foto - tracce dei percorsi delle stelle
È conveniente studiare i fenomeni del moto quotidiano delle stelle usando la costruzione matematica - sfera celeste

Sfera celeste - una sfera immaginaria di raggio arbitrario su cui vengono proiettati i corpi celesti
L'occhio dell'osservatore è solitamente preso come il centro della sfera celeste.
Per un osservatore sulla superficie della Terra, la rotazione della sfera celeste riproduce il movimento quotidiano dei luminari nel cielo

Per i popoli antichi:
la presenza di una sfera reale che limita il mondo intero e porta sulla sua superficie numerose stelle
Centro della sfera celeste:
- dove si trova l'osservatore (sfera celeste topocentrica),
- al centro della Terra (sfera celeste geocentrica),
- al centro di un particolare pianeta (sfera celeste pianeta-centrica),
- al centro del Sole (sfera celeste eliocentrica) o in qualsiasi altro punto dello spazio.

Filo a piombo (o verticale)
- una retta passante per il centro della sfera celeste e coincidente con la direzione del filo a piombo nel punto di osservazione
Il filo a piombo si interseca con la superficie della sfera celeste in due punti: zenit e, sopra la testa dell'osservatore, e nadir e - punto diametralmente opposto

I punti e gli archi più importanti della sfera celeste
Un piano passante per il centro della sfera celeste e tracciato perpendicolarmente al filo a piombo interseca la sfera celeste in un cerchio massimo -
vero orizzonte o matematico
divide la superficie della sfera celeste in due emisferi: il visibile, i cui punti sono tutti sopra l'orizzonte, e l'invisibile, i cui punti si trovano sotto l'orizzonte

I punti e gli archi più importanti della sfera celeste
asse del mondo
asse del mondo - asse di rotazione apparente della sfera celeste
L'asse del mondo interseca la sfera celeste in due punti P e P ₁ - palo OH pace
Vicino al polo nord del mondo si trova attualmente α Ursa Minor - la stella polare

I punti e gli archi più importanti della sfera celeste
Equatore celeste - un grande cerchio della sfera celeste, il cui piano è perpendicolare all'asse del mondo.
L'equatore celeste divide la superficie della sfera celeste in due emisferi:
emisfero settentrionale, con un picco al polo nord celeste,
ed emisfero australe, con apice al polo sud celeste
Equatore celeste
L'equatore celeste interseca l'orizzonte matematico in due punti: il punto est e il punto ovest. Punto est E- il punto in cui i punti della sfera celeste in rotazione attraversano l'orizzonte matematico, passando dall'emisfero invisibile a quello visibile
W - punto ovest

I punti e gli archi più importanti della sfera celeste
meridiano del cielo - un grande cerchio della sfera celeste, il cui piano passa attraverso il filo a piombo e l'asse del mondo.
Il meridiano celeste divide la superficie della sfera celeste in due emisferi -
l'emisfero orientale, con l'apice nel punto est, e
emisfero occidentale, apice nel punto ovest
meridiano del cielo

I punti e gli archi più importanti della sfera celeste
linea di mezzogiorno - la linea di intersezione del piano del meridiano celeste e del piano dell'orizzonte matematico
linea di mezzogiorno
Il meridiano celeste si interseca con l'orizzonte matematico in due punti: punto nord e punto sud . Il punto nord è quello più vicino al polo nord del mondo
NS- linea di mezzogiorno (gli oggetti illuminati dal Sole proiettano un'ombra in questa direzione a mezzogiorno)

I punti e gli archi più importanti della sfera celeste
Un piccolo cerchio della sfera celeste, il cui piano è parallelo al piano dell'equatore celeste - parallelo celeste o diurno luminari m
I movimenti giornalieri visibili dei luminari sono realizzati lungo i paralleli giornalieri
Si chiama il grande semicerchio della sfera celeste, passante per i poli del mondo e per la stella M cerchio orario o cerchio di declinazione luminari
Il grande semicerchio della sfera celeste, passante per lo zenit, il luminare M e il nadir, è chiamato cerchio di altezza,
cerchio verticale o verticale
luminari

I punti e gli archi più importanti della sfera celeste
Eclittica
Eclittica - la traiettoria del movimento apparente annuale del Sole nella sfera celeste.
Eclittica
Il piano dell'eclittica interseca con il piano dell'equatore celeste ad angolo
ε = 23°26".

I punti e gli archi più importanti della sfera celeste
L'eclittica si interseca con l'equatore celeste in due punti: equinozi di primavera e autunno
Nel punto dell'equinozio di primavera (♈) il Sole si sposta dall'emisfero meridionale della sfera celeste a quello settentrionale, nel punto dell'equinozio d'autunno (♎) - dall'emisfero settentrionale della sfera celeste a quello meridionale
La retta passante per questi due punti è linea equinoziale
♈ - segno dell'Ariete ♎ - segno della Bilancia

I punti e gli archi più importanti della sfera celeste
Due punti dell'eclittica, a 90° di distanza dagli equinozi e il più lontano possibile dall'equatore celeste - i punti del solstizio
Punto del solstizio d'estate (♋)
situato nell'emisfero settentrionale
punto del solstizio d'inverno (♑)
nell'emisfero australe
♑ - segno del Capricorno ♋ - segno del Cancro

L'aereo principale è piano dell'equatore celeste
Coordinata declinazione δ luminari M - arco mM del cerchio orario PMmP "dall'equatore celeste al luminare
O angolo centrale mOM (nel piano del cerchio orario).
Q ΄
Misurato nell'intervallo da 0° a +90° al polo nord celeste e da 0° a -90° al polo sud celeste
P ΄
z ΄
A volte la declinazione viene sostituita distanza polare p(anche arco PM o angolo centrale ROM). Si contano da 0° a 180° dal polo nord celeste a sud. p+ δ = 90°

Primo sistema di coordinate equatoriali
Seconda coordinata - angolo orario t luminari M - l'arco dell'equatore celeste Qm dal punto superiore Q dell'equatore celeste al cerchio orario PMmP "passando per il luminare,
o angolo al centro QOm (nel piano dell'equatore celeste)
Gli angoli orari sono misurati nella direzione della rotazione giornaliera della sfera celeste, cioè ad ovest del punto più alto Q dell'equatore celeste, da 0° a 360° o da 0 ʰ fino a 24 ʰ
Q ΄
P ΄
z ΄
Nel processo di rotazione giornaliera della sfera celeste, la declinazione δ dei luminari
non cambiano (se trascuriamo il moto proprio delle stelle), e gli angoli orari t aumentano.

Secondo sistema di coordinate equatoriale
Una coordinata declinazione δ , altro ascensione retta α
Ascensione retta α della stella M - l'arco dell'equatore celeste ♈m dall'equinozio di primavera ♈ al cerchio orario passante per la stella
o angolo al centro ♈Оm (nel piano dell'equatore celeste)
Q ΄
Viene conteggiato nella direzione opposta alla rotazione giornaliera nell'intervallo da 0° a 360° o da 0 ʰ fino a 24 ʰ
P ΄
z ΄
Il sistema viene utilizzato per determinare le coordinate delle stelle e compilare cataloghi. Determina il movimento annuale del Sole e di altri luminari.

Sistema di coordinate orizzontali
L'aereo principale è piano dell'orizzonte matematico
Una coordinata - distanza zenitale z, ovvero l'altezza della stella sopra l'orizzonte h
L'altezza h del luminare M è l'arco del cerchio verticale mM dall'orizzonte matematico al luminare
Q ΄
o angolo centrale mOM
Le altezze sono misurate nell'intervallo da 0° a +90° (verso lo zenit) e da 0° a -90° (verso il nadir)
P ΄
z ΄
La distanza zenitale z del luminare M è l'arco del cerchio verticale ZM dallo zenit al luminare o l'angolo al centro ZOM. Le distanze zenitali sono contate da 0° a 180° nelle direzioni dallo zenit al nadir. z+h = 90°

Sistema di coordinate orizzontali
Seconda coordinata - azimut A
- l'arco dell'orizzonte matematico Sm dal punto sud S ad un cerchio verticale passante per il luminare
o l'angolo al centro SOm (nel piano dell'orizzonte matematico)
Q ΄
Gli azimut sono misurati nella direzione della rotazione giornaliera della sfera celeste, cioè ad ovest del punto sud S, che va da 0° a 360°
P ΄
z ΄
Il sistema di coordinate viene utilizzato per determinare direttamente le posizioni apparenti dei luminari utilizzando strumenti goniometrici.

Definizione di latitudine geografica
Angolo (altezza del polo mondiale sopra l'orizzonte
) è uguale all'angolo (latitudine geografica del luogo φ ),
come angoli con lati reciprocamente perpendicolari OS ⟘ NC; O⟘CP
L'uguaglianza di questi angoli dà modo più semplice determinare la latitudine geografica dell'area: la distanza angolare del polo del mondo dall'orizzonte è uguale alla latitudine geografica dell'area
Per determinare la latitudine geografica dell'area è sufficiente misurare l'altezza del polo celeste sopra l'orizzonte:
= φ

Al polo della terra
il polo celeste è allo zenit e le stelle si muovono in cerchi paralleli all'orizzonte
Qui le stelle non tramontano né sorgono,
la loro altezza sopra l'orizzonte è invariata

Movimento giornaliero di luminari a diverse latitudini
Alle medie latitudini geografiche
ci sono ascendenti e
stelle tramontanti e quelle che non affondano mai sotto l'orizzonte
costellazioni circumpolari
alle latitudini geografiche della Russia non entrare mai
Le costellazioni che si trovano vicino al polo sud celeste non sono ascendenti.

Movimento giornaliero di luminari a diverse latitudini
All'equatore, tutte le stelle sorgono e tramontano perpendicolarmente all'orizzonte.
Ogni stella qui passa sopra l'orizzonte esattamente a metà del suo percorso.
Il polo nord celeste coincide con il punto nord e il polo sud celeste coincide con il punto sud.
L'asse del mondo si trova nel piano dell'orizzonte

L'altezza dei luminari al culmine
climax - fenomeni del passaggio di luminari attraverso il meridiano celeste
Nel climax superiore, l'altezza del luminare è massima,
nel culmine inferiore - è minimo.
L'intervallo di tempo tra i climax è di mezza giornata
Il momento del culmine superiore del centro del Sole - vero mezzogiorno ,
il momento del culmine inferiore - vera mezzanotte

L'altezza dei luminari al culmine
A non impostazione ad una data latitudine φ dei luminari sono visibili entrambe le culminazioni (sopra l'orizzonte),
alle stelle che salire e scendere , il climax inferiore si verifica sotto l'orizzonte.
Per un luminare molto a sud dell'equatore celeste, entrambe le culminazioni possono essere invisibili (luminario non ascendente )

h - l'altezza del luminare M al culmine superiore
δ - declinazione del luminare
φ - latitudine
∠ PON==φ
∠ QOZ = ∠PON come angoli con lati tra loro perpendicolari
90°-φ
h = 90° - φ + δ
La latitudine geografica può essere determinata misurando l'altezza di qualsiasi luminare con una declinazione nota δ al culmine superiore
Q ʹ
Al culmine inferiore: -h = 90° - φ - δ O
h = δ + φ - 90°
P ʹ
z ʹ

Determina la latitudine geografica del sito di osservazione se la stella Vega passa per il punto zenit.
Dato:
δ = +38°47 ′
h = 90°
h = 90° - φ + δ
φ = 90° - h + δ
φ = 90° - 90° + 38°47 ′ = 38°47 ′
Sirius era al culmine massimo a 10°. Qual è la latitudine del punto di osservazione?
h = 90° - φ + δ
Dato:
δ = -16°39 ′
φ = 90° - h + δ
φ = 90° - 10° + (-16°39 ′) = 63°21 ′


 Indietro avanti
Indietro avanti
Attenzione! L'anteprima della diapositiva è solo a scopo informativo e potrebbe non rappresentare l'intera estensione della presentazione. Se siete interessati questo lavoro si prega di scaricare la versione completa.
Lo scopo della lezione: introdurre gli studenti alle coordinate stellari, instillare le capacità di determinare queste coordinate su un modello della sfera celeste.
Attrezzatura: videoproiettore, planimetria sfera celeste
Durante le lezioni
Insegnante: Da tempo immemorabile, le persone hanno identificato gruppi separati di stelle luminose nel cielo stellato, le hanno unite in costellazioni, dando loro nomi che riflettono il loro modo di vivere e le peculiarità del loro pensiero. Così fecero gli antichi astronomi cinesi, babilonesi ed egiziani. Molti dei nomi delle costellazioni che usiamo oggi provengono dall'antica Grecia, dove si sono evoluti nel corso dei secoli.
Tabella 1 Cronaca dei nomi
Al congresso dell'Unione Astronomica Internazionale nel 1922, il numero di costellazioni fu ridotto a 88. Allo stesso tempo, furono stabiliti gli attuali confini tra loro.
dovrebbe essere evidenziato. Che la vicinanza delle stelle nelle costellazioni sia evidente, quindi sono viste da un osservatore dalla Terra. In effetti, le stelle sono in ritardo l'una rispetto all'altra a grandi distanze e per noi la loro visibilità è, per così dire, proiettata su sfera celeste- una sfera immaginaria trasparente, al centro della quale si trova la Terra (osservatore), sulla cui superficie sono proiettati tutti i luminari così come sono visti dall'osservatore in un certo momento da un certo punto nello spazio. Presentazione.Diapositiva 1
Inoltre, le stelle nelle costellazioni sono diverse, differiscono per dimensioni apparenti e luce. Le stelle più luminose delle costellazioni sono indicate dalle lettere dell'alfabeto greco in ordine decrescente (a, b, g, d, e, ecc.) Di luminosità.
Questa tradizione fu introdotta da Alessandro Piccolomini (1508-1578), e consolidata da Johann Bayer (1572-1625).
Quindi John Flamsteed (1646–1719) designò le stelle all'interno di ciascuna costellazione con un numero di serie (ad esempio, la stella 61 Cygnus). Le stelle con luminosità variabile sono indicate con lettere latine: R, S, Z, RR, RZ, AA.
Ora considereremo come viene determinata la posizione dei luminari nel cielo.
Immagina il cielo come un gigantesco globo di raggio arbitrario, al centro del quale c'è l'osservatore.
Tuttavia, il fatto che alcuni luminari si trovino più vicini a noi, mentre altri sono più lontani non viene catturato dall'occhio. Supponiamo quindi che tutte le stelle siano alla stessa distanza dall'osservatore, in superficie sfera celeste. Presentazione.Diapositiva 1
Poiché le stelle cambiano posizione durante il giorno, possiamo concludere che la sfera celeste ruota quotidianamente (ciò è dovuto alla rotazione della Terra attorno al proprio asse). La sfera celeste ruota attorno a un asse PP` da est a ovest. L'asse di rotazione apparente della sfera è l'asse del mondo. Coincide con l'asse terrestre o è parallelo ad esso. L'asse del mondo interseca la sfera celeste nei punti P - polo nord del mondo e P`- polo sud del mondo. Vicino al polo nord del mondo c'è la Stella Polare (un'Orsa Minore). Usando un filo a piombo, determiniamo la verticale e la rappresentiamo nel disegno. Presentazione.Diapositiva 1
Questa linea retta ZZ` è chiamata filo a piombo. Z- zenit, Z`- nadir. Attraverso il punto O - l'intersezione del filo a piombo e l'asse del mondo - tracciamo una linea retta perpendicolare a ZZ`. Questo è NS- linea di mezzogiorno(N- nord, S Sud). Nella direzione lungo questa linea, gli oggetti illuminati dal Sole a mezzogiorno proiettano un'ombra.
Due piani reciprocamente perpendicolari si intersecano lungo la linea di mezzogiorno. Un piano perpendicolare a un filo a piombo che interseca la sfera celeste in un cerchio massimo è vero orizzonte. Presentazione.Diapositiva 1
Si chiama il piano perpendicolare all'orizzonte vero, passante per i punti Z e Z' meridiano celeste.
Abbiamo disegnato tutti i piani necessari, ora introduciamo un altro concetto. Poniamo arbitrariamente una stella sulla superficie della sfera celeste M, disegnare attraverso i punti Z e Z` e M grande semicerchio. Questo - cerchio di altezza O verticale
La posizione istantanea della stella rispetto all'orizzonte e al meridiano celeste è determinata da due coordinate: Alto(mano azimut(UN). Queste coordinate sono chiamate orizzontale.
L'altezza del luminare è la distanza angolare dall'orizzonte, misurata in gradi, minuti, secondi d'arco, che va da 0° a 90°. Di più altezza sono sostituiti da una coordinata equivalente - z - distanza zenitale.
La seconda coordinata nel sistema orizzontale A è la distanza angolare della verticale della stella dal punto sud. È definito in gradi minuti e secondi da 0° a 360°.
Nota come cambiano le coordinate orizzontali. Leggero M durante il giorno descrive un parallelo quotidiano sulla sfera celeste - questo è un cerchio della sfera celeste, il cui piano è perpendicolare a assi del mondo.
<Отработка навыка определения горизонтальных координат на небесной сфере. Самостоятельная работа учащихся>
Quando una stella si muove lungo il parallelo giornaliero, viene chiamato il punto più alto di ascesa massimo climax. Muovendosi sotto l'orizzonte, il luminare si troverà in un punto che sarà un punto climax inferiore. Presentazione.Diapositiva 1
Se consideriamo il percorso della stella che abbiamo scelto, allora possiamo vedere che sta ascendendo - tramontando, ma ci sono luminari che non tramontano e non sorgono. (Qui, rispetto al vero orizzonte.)
Considera il cambiamento nell'aspetto del cielo stellato durante l'anno. Questi cambiamenti non sono così evidenti per la maggior parte delle stelle, ma si verificano. C'è una stella in cui la posizione cambia parecchio, questo è il sole.
Se disegniamo un piano attraverso il centro della sfera celeste e perpendicolare all'asse del mondo PP`, allora questo piano intersecherà la sfera celeste in un grande cerchio. Questo cerchio si chiama equatore celeste. Presentazione.Diapositiva 2
Questo equatore celeste si interseca con il vero orizzonte in due punti: est (E) e ovest (O). Tutti i paralleli diurni sono paralleli all'equatore.
Ora disegniamo un cerchio attraverso i poli del mondo e la stella osservata. Il risultato è stato un cerchio, un cerchio di declinazione. La distanza angolare del luminare dal piano dell'equatore celeste, misurata lungo il cerchio di declinazione, è chiamata declinazione del luminare (d). La declinazione è espressa in gradi, minuti e secondi. Poiché l'equatore celeste divide la sfera celeste in due emisferi (settentrionale e meridionale), la declinazione delle stelle nell'emisfero settentrionale può variare da 0° a 90°, e nell'emisfero meridionale da 0° a -90°.
La declinazione del luminare è una delle cosiddette coordinate equatoriali.
La seconda coordinata in questo sistema è ascensione retta (a).È analogo alla longitudine geografica. L'ascensione retta è contata da punti equinozio di primavera (g). Il sole è all'equinozio di primavera il 21 marzo. L'ascensione retta è misurata lungo l'equatore celeste nella direzione opposta alla rotazione giornaliera della sfera celeste. Presentazione.Diapositiva 2. L'ascensione retta è espressa in ore, minuti e secondi di tempo (da 0 a 24 h) o in gradi, minuti e secondi d'arco (da 0° a 360°). Poiché la posizione delle stelle rispetto all'equatore non cambia durante il movimento della sfera celeste, le coordinate equatoriali vengono utilizzate per creare mappe, atlanti e cataloghi.
Fin dall'antichità si è notato che il Sole si muove tra le stelle e descrive un giro completo in un anno. Gli antichi greci chiamavano questo cerchio eclittica, che è stato conservato in astronomia fino ad oggi. Eclittica inclinata rispetto al piano dell'equatore celeste di un angolo di 23°27' e si interseca con l'equatore celeste in due punti: l'equinozio di primavera (g) e l'equinozio d'autunno (W). Il Sole percorre l'intera eclittica in un anno, percorre 1° al giorno.
Vengono chiamate le costellazioni attraverso le quali passa l'eclittica zodiacale. Ogni mese il Sole si sposta da una costellazione all'altra. È praticamente impossibile vedere la costellazione in cui si trova il Sole a mezzogiorno, poiché supera la luce delle stelle. Pertanto, in pratica, a mezzanotte osserviamo la costellazione zodiacale, che è soprattutto sopra l'orizzonte, e da essa determiniamo la costellazione dove si trova il Sole a mezzogiorno (Fig. 14 del libro di testo Astronomia 11).
Non va dimenticato che il movimento annuale del Sole lungo l'eclittica è un riflesso dell'effettivo movimento della Terra attorno al Sole.
Considerare la posizione del Sole sul modello della sfera celeste e determinarne le coordinate rispetto all'equatore celeste (ripetizione).
<Отработка навыка определения экваториальных координат на небесной сфере. Самостоятельная работа учащихся>
Compiti a casa.
- Conoscere il contenuto del paragrafo 116 del manuale di Fisica-11
- Conoscere il contenuto dei paragrafi 3, 4 del libro di testo Astronomia -11
- Preparare materiale sull'argomento "Costellazioni zodiacali"
Letteratura.
- EP Levitan Astronomia Grado 11 - Illuminismo, 2004
- G.Ya.Myakishev e altri Fisica Grado 11 - Illuminismo, 2010
- Enciclopedia per bambini Astronomia - ROSMEN, 2000

Verifica d.z
- Quante costellazioni ci sono nel cielo? Annota il nome delle costellazioni circumpolari che conosci. Disegna la sua veduta di qualsiasi costellazione circumpolare: quale lettera indica la stella più luminosa della costellazione? Quale costellazione contiene la stella polare? Dai un nome alla stella più luminosa del cielo. Ciò che caratterizza una stella nel cielo, a seconda della luminosità apparente. Come determinare la direzione verso nord? Cos'è l'eclittica. Quante costellazioni zodiacali ci sono? E i segni zodiacali?
- Quante costellazioni ci sono nel cielo?
- Annota il nome delle costellazioni circumpolari che conosci.
- Disegna la sua vista di qualsiasi costellazione circumpolare
- Quale lettera rappresenta la stella più luminosa della costellazione?
- Quale costellazione contiene la stella polare?
- Dai un nome alla stella più luminosa del cielo.
- Ciò che caratterizza una stella nel cielo, a seconda della luminosità apparente.
- Come determinare la direzione verso nord?
- Cos'è l'eclittica.
- Quante costellazioni zodiacali ci sono? E i segni zodiacali?

Lavoro pratico#1
Costellazione
Diagramma di costellazione, alfa
Grande Carro
Costellazione
Orsa Minore
diagramma di costellazione
Cassiopea
Auriga

Lavoro pratico#1
- Usando una mappa stellare, inserisci i diagrammi delle costellazioni con stelle luminose nelle colonne appropriate della tabella. In ogni costellazione, evidenzia la stella più luminosa e scrivi il suo nome.
Costellazione
Diagramma di costellazione, alfa
Grande Carro
Orsa Minore
Costellazione
stella polare
Cassiopea
diagramma di costellazione
Auriga




Mirfak(Alpha Perseus / α Per) è la stella più luminosa della costellazione di Perseo. Tradotto dall'arabo Mirfak as-Suraya- gomito,

Shedar(Alfa Cassiopea)



Cappella(α Aur / α Aurigae / Alpha Aurigae)

Lavorare con una mappa mobile del cielo stellato
- 1. Quali costellazioni saranno visibili il 17 febbraio alle 22:00.
- 2. La costellazione di Orione sarà visibile il 30 marzo a mezzanotte.
- 3. È possibile vedere la costellazione della Vergine nella notte tra il 17 e il 18 febbraio?


La posizione di un punto sulla Terra è determinata in modo univoco dalle coordinate geografiche: longitudine (λ) e latitudine (φ).
La posizione della stella nel cielo è determinata in modo univoco dalle coordinate equatoriali - ascensione retta (α) e declinazione (δ)


Punti e linee fondamentali
- Sfera celeste - una sfera immaginaria di raggio arbitrario, descritta attorno a un osservatore sulla Terra, sulla cui superficie interna sono applicati i luminari.
- L'asse del mondo è l'asse attorno al quale ruota la Terra, muovendosi nello spazio del mondo
- I poli del mondo sono l'asse immaginario della rotazione visibile della sfera celeste.
- equatore celeste detto cerchio massimo perpendicolare all'asse del mondo. meridiano celeste chiamato il cerchio massimo della sfera celeste, passante per il polo celeste R, il polo sud celeste R".


Sistema di coordinate equatoriali - il sistema utilizzato per determinare le coordinate stellari e compilare cataloghi. Determina il movimento annuale del Sole e di altri luminari.
- declinazione-arco mm cerchio orario dall'equatore celeste al luminare. Si contano da 0 a +90 al polo nord e da 0 a -90 a sud. p+=90.
- Ascensione retta α- chiamato l'arco dell'equatore celeste ♈ dal punto equinozio di primavera♈ al cerchio orario passante per il luminare (in senso antiorario) da 0 a 360 o da 0 a 24 ore.

La posizione della stella X è indicata dalle coordinate: ascensione retta α (distanza angolare lungo l'equatore celeste dal punto dell'equinozio di primavera ϓ alla direzione verso la stella) e declinazione δ (distanza angolare dall'equatore celeste lungo il grande cerchio passante per i poli del mondo).
L'ascensione retta si misura in ore e può essere solo un valore positivo, la declinazione è in gradi e può assumere sia valori positivi che negativi.

L'entità dell'ascensione retta dello stesso luminare non cambia a causa della rotazione giornaliera del cielo e non dipende dal luogo di osservazione sulla superficie terrestre.
A causa della rotazione terrestre, 15° corrispondono a 1 ora e 1° a 4 minuti, quindi un'ascensione retta di 12 ore è 180° e 7 ore e 40 minuti è 115°.


Le coordinate equatoriali delle stelle non cambiano per secoli,
quindi viene utilizzato il sistema di coordinate equatoriale
durante la creazione di globi stellari, mappe e atlanti.
Su un globo stellare non sono rappresentate solo le stelle,
ma anche una griglia di coordinate equatoriali.


- Pesce alfa del sud
- betta andromeda
- Alfa Toro (Aldebaran)
- Alfa Bilancia


Sistema di coordinate orizzontali utilizzato per la determinazione diretta delle posizioni apparenti dei luminari mediante strumenti goniometrici
h - altezza- la distanza angolare del luminare dall'orizzonte (Р MOA, misurata in gradi, minuti, secondi; da 0 o a 90 o)
A - azimutè la distanza angolare della verticale del luminare dal punto sud (Ð SOА) nella direzione del moto quotidiano del luminare, cioè senso orario; Si misura in gradi minuti e secondi da 0° a 360°).


climax - il fenomeno dell'attraversamento del meridiano celeste da parte del luminare
- Secondo il movimento quotidiano dei luminari sono divisi in:
- 1 - non ascendente
- 2 - (ascendente - impostazione ) ascendente e tramontante
- 3 - non avvicinante .

Lavoro pratico №2
Spica -a Vergine +1.04

- Cos'è la sfera celeste?
- Quali linee e punti della sfera celeste conosci?
- Quali osservazioni dimostrano la rotazione giornaliera della sfera celeste (questo serve come prova della rotazione della Terra attorno al suo asse).
- È possibile, utilizzando un sistema di coordinate orizzontali, creare mappe del cielo stellato?
- Cos'è un punto culminante?
- Sulla base del climax, dai il concetto di luminari che non tramontano, non ascendono, - tramontano in ascensione.

Casa. Esercizio
- par.4, apprendere i punti e le linee principali della sfera celeste, i sistemi di coordinate

Sfera celeste
Quando osserviamo il cielo, tutti gli oggetti astronomici sembrano essere posizionati su una superficie a forma di cupola, al centro della quale si trova l'osservatore.
Questa cupola immaginaria forma la metà superiore di una sfera immaginaria, chiamata "sfera celeste".

Elementi della sfera celeste

P - il polo nord del mondo
Vero orizzonte
N - punto nord
S - punto sud
meridiano del cielo
P ' - il polo sud del mondo
linea di mezzogiorno
Z' - nadir

La sfera celeste svolge un ruolo fondamentale nell'indicare la posizione degli oggetti astronomici.
Coordinate orizzontali
Nel sistema di coordinate orizzontali, la posizione di un oggetto è definita rispetto all'orizzonte e rispetto alla direzione sud (S).

Verticale - cerchio di altezza

Coordinate orizzontali
La posizione della stella M è data dalla sua altezza H (distanza angolare dall'orizzonte lungo il cerchio massimo - verticale) e azimut A (misurata ad ovest, la distanza angolare dal punto sud alla verticale).
Variazioni di altezza: da 0 ° fino a +90 ° (sopra l'orizzonte) da 0 ° fino a -90 ° (sotto l'orizzonte)
Cambiamenti di azimut: da 0 ° fino a 360 °

Culmine dei corpi celesti
Muovendosi attorno all'asse del mondo, i luminari descrivono paralleli quotidiani.
Il culmine è il passaggio del luminare attraverso il meridiano celeste.


Culmine dei corpi celesti
Durante il giorno, ci sono due climax: quello superiore e quello inferiore
Il luminare che non tramonta ha entrambi i culmini sopra l'orizzonte. Il luminare non nascente ha entrambi i punti culminanti sotto l'orizzonte.

Ma per alcuni compiti di astronomia, il sistema di coordinate deve essere indipendente dalla posizione dell'osservatore e dall'ora del giorno. Tale sistema è chiamato "equatoriale".
Coordinate equatoriali
A causa della rotazione della Terra, le stelle si muovono costantemente rispetto all'orizzonte e ai punti cardinali e le loro coordinate nel sistema orizzontale cambiano.

Equatore celeste
declinazione
α - ascensione retta
punto equinozio di primavera
Cerchio di declinazione

Coordinate equatoriali
Eclittica - il percorso apparente del Sole nella sfera celeste.

Coordinate equatoriali
La "declinazione" di una stella è misurata dalla sua distanza angolare a nord oa sud dell'equatore celeste.
"Ascensione retta" è misurata dall'equinozio di primavera al cerchio di declinazione di una stella.
"Ascensione retta" cambia da 0 ° fino a 360 ° o da 0 a 24 ore.

Eclittica
L'asse di rotazione terrestre è inclinato di circa 23,5° rispetto alla perpendicolare tracciata al piano dell'eclittica.
L'intersezione di questo piano con la sfera celeste dà un cerchio: l'eclittica, il percorso apparente del Sole in un anno.

Eclittica
Ogni anno a giugno, il Sole sorge alto nel cielo nell'emisfero boreale, dove le giornate si allungano e le notti si accorciano.
Dopo essersi spostati dalla parte opposta dell'orbita a dicembre, nel nostro nord, le giornate si accorciano e le notti lunghe.

Eclittica
L'intera eclittica è coperta dal Sole in un anno, spostandosi di 1 ° , avendo visitato ciascuna delle 12 costellazioni zodiacali per un mese.
Lezione di astronomia
Argomento: "Coordinate celesti" ( instradamento lezione)
| Articolo | Astronomia |
| Classe | 10 |
| Argomento della lezione | Coordinate celesti |
| Astronomia. 10-11. Un livello base di. VM Charugin |
|
| TCO (apparecchiature) | Computer, proiettore, lavagna |
| Strumenti ICT (EFS, programmi, applicazioni, risorse Internet) |
Risultati educativi pianificati
| soggetto | riprodurre definizioni di termini e concetti: equatore celeste e celeste meridiano; coordinate orizzontali, equatoriali; culmine dei luminari. Sistema di coordinate orizzontali. Sistema di coordinate equatoriali |
| Metasoggetto | ricerca e selezione informazione necessaria, la capacità di definire concetti, stabilire analogie, costruire ragionamenti logici e trarre conclusioni, promuovere lo sviluppo di operazioni mentali: confronto, analisi, sintesi, generalizzazione. assistenza nello sviluppo dell'attività cognitiva, capacità intellettuali. |
| Personale | autodeterminazione, la capacità di autovalutare le proprie azioni, determinare il significato delle informazioni per se stessi personalmente, accettazione ruolo sociale alunno. Sviluppo dei motivi attività didattiche e la formazione del significato personale della dottrina. Sviluppo delle capacità di cooperazione con l'insegnante e i compagni in diverse situazioni di apprendimento. |
| Organizzazione e struttura della lezione |
|||||
| Fase di lezione | Compiti educativi(risultati pianificati) | Risorse utilizzate | Attività dell'insegnante | Attività degli studenti | Durata |
| Organizzazione del tempo | Saluta gli studenti. Come determinare la posizione del corpo nello spazio? | diapositiva 1; 2 Coordinate celesti | Passa all'argomento della lezione, permette di pianificare il proprio lavoro, si offre di fissare l'obiettivo della lezione, si offre di annotare su un quaderno ciò che gli studenti vorrebbero sapere, capire, chiarire nella lezione. | Stabilire l'argomento e gli obiettivi, scrivere su un quaderno ciò che vorresti sapere, capire, chiarire | 5 minuti |
| Aggiornamento delle conoscenze di base | Aggiornare le conoscenze degli studenti di fisica e astronomia. Sapere cos'è una costellazione.Capacità di identificare le costellazioni e conoscere i nomi di alcune costellazioni dell'emisfero boreale, | Diapositiva 3. Domanda-risposta "Cosa c'è oltre l'orizzonte" | Aiuta a ricordare cos'è una costellazionecome identificare le costellazioni e conoscere i nomi di alcune costellazioni . | 10 minuti |
|
| Lavoro di gruppo | Considera i punti, le linee e i cerchi principali sulla sfera celeste: Orizzonte, linea di mezzogiorno, meridiano celeste, Equatore celeste, Eclittica, Zenit, Polo celeste, asse del mondo, Punti equinozio. Rispondere alle domande. | Carte in dispensa. | Suggerisce, in base allo scopo della lezione, di essere diviso in tre gruppi. Distribuisce un compito: un'istruzione a ciascun gruppo, ci sono tre compiti in essi, che divide tra gli studenti. | Studia il materiale sulle carte. Rispondono alle domande poste. Trascorso il tempo, le diapositive della presentazione rispondono alle domande. | 10 minuti |
| Rapporto di gruppo | sviluppare la capacità di costruire relazioni tra studenti e insegnante. | Slide di presentazione. | Organizzazione di spettacoli di gruppo a turno. | Risposte alle domande. | 10 minuti |
| Risultato | Fare generalizzazioni, sistematizzare le conoscenze sull'argomento "Meccanica" Applicare la conoscenza delle leggi alla risoluzione dei problemi. Riflessione | Compiti sulle carte | Sottolinea gli obiettivi che sono stati scritti alla lavagna all'inizio della lezione, distribuisce un foglio di riflessione | Completare i fogli di riflessione. | 5 minuti |
| Compiti a casa | Consolidare il materiale | § 4 | Imposta compiti a casa, carte con domande. | Annota i compiti, ordina le carte. | 5 minuti |
Riassunto della lezione
Scegli un'immagine e rispondi a una domanda. Verifichiamo la correttezza e la completezza della risposta.
1. Qual è il nome di questa costellazione? Cosa si chiama costellazione e quante costellazioni ci sono nella sfera celeste?
costellazione
chiamato una sezione della sfera celeste, i cui confini sono determinati da una decisione speciale dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU). In totale, ci sono 88 costellazioni nella sfera celeste.
2. Qual è il nome di questa costellazione?
Costellazione dell'Acquario.
3. Qual è il nome della costellazione? E qual è la sua origine?
Bilancia. Una delle costellazioni zodiacali non viventi. L'origine del nome di questa costellazione è anche associata al mito della dea Themis. Non solo il Tonante Zeus osserva le leggi dell'Olimpo, ma anche la madre di Prometeo, la dea Themis. Convoca le riunioni degli dei sull'eterno Olimpo e controlla l'ordine e la legge. Tiene la bilancia tra le mani - un segno di giustizia.
4. Cos'è la sfera celeste?
Una sfera immaginaria di raggio arbitrario centrata in un punto arbitrario, sulla cui superficie sono tracciate le posizioni dei luminari così come sono visibili nel cielo a un certo punto nel tempo da un dato punto.
5.
Come si chiama il fenomeno apparente? Qual è l'asse del mondo?
L'apparente fenomeno della rotazione della sfera celeste attorno alla stella polare riflette l'effettiva rotazione del globo attorno al proprio asse. L'asse parallelo all'asse di rotazione visibile della sfera celeste è chiamato asse del mondo.
6
. Come si chiama la stella più luminosa della costellazione del Boote?
.
La costellazione del Boote, la stella più luminosa di questa costellazione di Arturo. Si trova lungo la continuazione della coda dell'Orsa Maggiore.
7.
Come si chiama l'eclittica?
Il percorso annuale del Sole che attraversa le 12 costellazioni zodiacali.
8.
In che modo i pianeti differiscono dalle stelle se visti ad occhio nudo?
Sia il pianeta che la stella sono caratterizzati dalla luminescenza, grazie alla quale possono essere visti dalla Terra. Tuttavia, una stella è un oggetto auto-luminoso. Mentre il pianeta risplende per la luce riflessa dalle stelle. Pertanto, la radiazione dei pianeti è molte volte più debole della radiazione stellare. Per le stelle, lo scintillio causato dalla fluttuazione dell'aria è più caratteristico. I pianeti, a loro volta, brillano in modo uniforme, anche se più debolmente.
9.
Cos'è la magnitudine stellare apparente?
Grandezza apparenteMindica il flusso di radiazione vicino all'osservatore, cioè la luminosità osservata di una sorgente celeste, che dipende non solo dalla potenza reale dell'oggetto, ma anche dalla distanza da esso.
Parte principale:
Come descrivere con precisione la posizione della stella nel cielo? Dove dirigere l'occhio o il telescopio per vedere ciò che interessa l'osservatore.
I matematici hanno usato a lungo un modo per descrivere un punto nello spazio usando un sistema di coordinate. Esistono tali sistemi di coordinate in cui la posizione dell'oggetto è caratterizzata non da quella lineare, ma da quella angolare. (Le coordinate geografiche - latitudine e longitudine - sono gli angoli che determinano la posizione di un punto sulla superficie della Terra.
Per descrivere le posizioni reciproche dei movimenti visibili dei luminari, è conveniente collocare tutti i luminari sulla superficie interna di una sfera immaginaria al centro dell'osservatore. Una tale sfera è chiamata celeste.
L'asse parallelo all'asse di rotazione apparente della sfera celeste è detto asse del mondo.
L'asse del mondo attraversa la sfera celeste in due punti: i poli del mondo.

Dal "Celestial Atlas" di A. Cellarius 1660 Sfera armillare di Tycho Brahe
Equatore celeste e meridiano celeste.
equatore celeste
detto cerchio massimo perpendicolare all'asse del mondo.
meridiano celeste
chiamato il cerchio massimo della sfera celeste, passante per il polo celeste R, il polo sud celeste R".


Sistema di coordinate orizzontali: Piano principalesistema orizzontalecoordinate èorizzonte matematico NWSE, e il rapporto è di Z zenit e da uno dei punti dell'orizzonte matematico. Una coordinata èdistanza zenitale z (Distanza Zenith a Sud zv = φ - δ; A nord zн = 180 - φ - δ) ol'altezza del sole sopra l'orizzonte H . Altezza H luminari M chiamato l'altezza del cerchio verticale mm daorizzonte matematicoPrima luminari, o angolo centrale mamma tra pianoorizzonte matematicoe direzione verso luminare m . Le altezze sono contate da 0 a 90 k zenit e da 0 a -90 Nadir. La distanza zenitale del luminare è chiamata arco del cerchio verticale ZM da luce a zenit . z + h = 90 (1). La posizione del cerchio verticale stesso è determinata dall'arco di coordinate - azimut A . Azimut A detto arcoorizzonte matematico sm dal punto sud S ad un cerchio verticale passante per il luminare. Azimut contato nel senso di rotazione sfera celeste , cioè. a ovest del punto sud, compreso tra 0 e 360. Il sistema di coordinate viene utilizzato per determinare direttamente le posizioni apparenti dei luminari utilizzando strumenti goniometrici.
Primo sistema di coordinate equatoriale:
Inizio del conto alla rovescia -equatore celeste Q. Una coordinata èdeclinazione. declinazionedetto arco mm cerchio orario PMmP' dall'equatore celeste al luminare. Si contano da 0 a +90 al polo nord e da 0 a -90 a sud. p+=90. La posizione del cerchio orario è determinata angolo orario t .
angolo orario luminari M chiamato l'arco del cielo Equatore Qm dall'alto Q equatore celeste a cerchio orario PMmP′, passando attraverso la luce. Gli angoli orari sono misurati nella direzione della rotazione giornaliera della sfera celeste, ad ovest di Q nell'intervallo da 0 a 360 o da 0 a 24 ore. Il sistema di coordinate viene utilizzato nell'astronomia pratica per determinare l'ora esatta e la rotazione giornaliera del cielo. Determina il movimento giornaliero del Sole, della Luna e di altri luminari.
Secondo sistema di coordinate equatoriale:
Una coordinata è declinazione , un altroascensione retta α. diretto salita α luminari M detto arco dell'equatore celeste ♈ M dal puntoequinozio di primavera♈ al cerchio orario passante per il luminare. Viene conteggiato nella direzione opposta alla rotazione giornaliera nell'intervallo da 0 a 360 o da 0 a 24 ore. Il sistema viene utilizzato per determinare le coordinate delle stelle e compilare cataloghi. Determina il movimento annuale del Sole e di altri luminari.
L'altezza del polo celeste sopra l'orizzonte, l'altezza del luminare nel meridiano
L'altezza del polo celeste sopra l'orizzonte è sempre uguale alla latitudine astronomica del luogo dell'osservatore:
Se la declinazione della stella è inferiore alla latitudine geografica, allora culmina a sud dello zenit a z = φ - δ o ad un'altezza h = 90 - φ + δ
Se la declinazione della stella è uguale alla latitudine geografica, allora culmina allo zenit e z = 0, e h = + 90
Se la declinazione della stella è maggiore della latitudine geografica, allora culmina a nord dello zenit a z = c - φ o ad un'altezza h = 90 + φ - c
Compito 1.
Le stelle con quale declinazione culmineranno allo zenit alla latitudine di Mosca (55° 45′ N 37° 37′ E)?
Ricordiamo le formule più necessarie per risolvere problemi sulla relazione tra latitudine, altitudine e declinazione:
A sud dello zenit -HVC=90
∘
−φ+δ
, o altroHVC=90
∘
+(δ−φ)
&
Hnk=δ−(90∘
−φ)
, o altroHnk=δ+φ−90∘
.
a nord dello zenitHVC=90
∘
−δ+φ
, o altroHVC=90
∘
−(δ−φ)
.
Hnk=δ−(90∘
−φ)
, o altroHnk=δ+φ−90∘
.
Allo zenit alla latitudine di Mosca, i luminari saranno al culmine superiore. Pensa, forse in fondo? Pertanto, applichiamo la formula per il climax superiore. Che cosa? A sud oa nord dello zenit? È ovvio che le formule per l'altezza del culmine superiore a sud oa nord dello zenit non dovrebbero subire interruzioni nel punto di transizione (h = 90°). Dalle formule si può vedere che si può usare qualsiasi.
HYu=90
∘
+(δ−φ)=hCon=90
∘
−(δ−φ)=90∘
è l'altezza dello zenit. Si può vedere dalle formule cheδ
=
φ
. Risposta 55° 45′
Compito 2.
A che altezza si trova il Polo della Pace alla latitudine di Mosca (55° 45′ N 37° 37′ E)?
Il polo del mondo è notevole in quanto ha una declinazioneδ
=
90
∘
.
Una stella situata al polo celeste avrà un'altezza costante h =φ
.
Prova a dedurlo dalle formule del culmine superiore e inferiore. Quale formula scegliere? Qualsiasi formula funzionerà e perché?
Compito 3.
Qual è la declinazione di una stella che non tramonta e che tocca appena l'orizzonte alla latitudine di Mosca (55° 45′ N 37° 37′ E)? Ignora gli effetti ottici.
Secondo le condizioni, la stella alla latitudine di Mosca non tramonta, ma a volte tocca l'orizzonte. A che punto può accadere? Si può vedere che al momento del climax inferiore, da allora al momento del culmine superiore, la sua altezza non sarà inferiore. Scriviamo la formula dell'altezza nel climax inferiore: h nk=δ+φ−900
Qual è l'altezza all'orizzonte? Esatto, zero. Quindi declinazione e latitudine sono complementari fino a 900
(δ+φ=900
). Risposta: 37° 37′
D.Z. § 4
Scheda 1. Qual è la declinazione del punto zenit alla latitudine geografica di Minsk (ᵠ
= 53
O54
/
)?
Carta 2. In quale costellazione si trova oggi il Polo dell'eclittica?A quali paralleli geografici la stella Capella (δ = + 45°58") oltrepassa l'orizzonte, non è mai visibile, e passa nel nadir al culmine inferiore?
3 Card Circolo Polare Artico (φ=+66°33"). Declinazione Capella δ=+45°58".
Popolare
- Inizia con la scienza Peso netto delle uova senza guscio = - - - - - - - - -
- Come eliminare le foto nei compagni di classe Come rimuovere l'orpello da una foto sui compagni di classe
- Come aggiungere una foto in un contatto?
- Tatyana Gordienko: Altri designer mi copiano e ne sono felice!
- Account personale Linii Lubvi (Linee d'amore)
- Familia: “Nella vendita al dettaglio, le cose più semplici funzionano meglio Dove posso trovare gli indirizzi di tutti i grandi magazzini della rete
- I modelli bassi più famosi Parametri del modello ideale
- L'audit tecnico include
- Audit tecnico dell'impresa e caratteristiche della sua provvidenza
- Specifiche per la costruzione di rottami di acciaio GOST Specifiche per la costruzione di rottami di acciaio